Il buon racconto di orrore danzerà
fino al centro della tua vita
e troverà quella porta della stanza segreta
di cui solo tu credevi di conoscere l’esistenza.
Danse Macabre, Stephen King
Lester Billings, un uomo di mezza età, è
inquadrato da subito, dalla voce in terza persona che mette a fuoco i
due protagonisti del racconto, nello studio del dottor Harper,
psichiatra.
Solo a uno psichiatra, difatti, Billings
si può rivolgere, prima di tutto in quanto non-cattolico. Un
prete non gli servirebbe a niente. Né un legale,
perché qui di avvocati non c’è affatto
bisogno.
La situazione è chiara, e solo
un terapeuta può essere in grado di ascoltare.
Perché
di questo si tratta, di ascoltare.
“I came to you
because I want to tell my story”: così inizia
appunto Il BauBau (The Boogeyman)
di Stephen King (2000), apparso per la prima volta sulla rivista
Cavalier nel 1973 e raccolto, insieme ad altri diciannove racconti, in Night
Shift cinque anni dopo (anziché Turno
di notte, l’editore italiano ha preferito dare al
volume il nome di uno dei racconti, A volte ritornano).
L’esordio
di questa short story, genere, sia detto en
passant, in cui King eccelle leggermente meno rispetto ai
romanzi lunghi (due per tutti: The Stand, 1978 e It,
1986) o alle saghe (come quella straordinaria in otto romanzi di The
Dark Tower, 1982-2012) fa il
paio con le prime parole pronunciate da Lester, personaggio che inizia
il suo racconto facendoci precipitare subito nell’orrore:
sono qui per raccontare la mia storia, dice, e la mia storia
è quella di un padre che ha ucciso i suoi tre figli. Uno
alla volta, per la precisione.
Ma l’orrore, come
è emerso d’improvviso, così in qualche
modo si smorza.
Il padre infatti parrebbe non aver materialmente
ucciso i figli, come suggerisce il dottor Harper. “But I was
responsible”, corregge il tiro lo stesso Billings.
Il
racconto è in terza persona, si diceva, e da subito entriamo
nella testa del più silenzioso dei due, il dottor Harper.
Mentre Billings parla Harper lo scruta e comincia a formulare un
giudizio, e una diagnosi, che mediati dalle parole del narratore non
possono apparirci altro che oro colato.
Il narratore
comincia un sottile lavoro di progressivo depistaggio che ci
condurrà ad un finale da autentica scossa
elettrica.
Billings sembra rigido e a disagio, con
un volto inespressivo. Poco dopo viene descritto “vecchio e
indifeso”, con i capelli radi e l’incarnato
addirittura giallastro, anche se non dovrebbe esserlo. Il dottor Harper
pensa e il narratore dà voce ai suoi pensieri: “I
suoi occhi nascondevano tutti i miserabili segreti del
whisky”. Insomma, quello che il dottor Harper si trova di
fronte sembrerebbe un alcolista che con tutta probabilità,
in impeti di incontrollata violenza, avrebbe ucciso uno alla volta i
suoi tre figli: Denny nel 1967, Shirl quattro anni dopo, Andy nel 1973,
cioè nello stesso anno dei fatti diegetici.
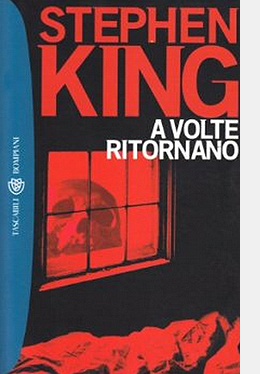 Certo, Billings non si accusa esplicitamente, ma tenta di
ragionare insieme al laconico psichiatra sulla
(im)possibilità di dare credito ad altre spiegazioni.
“Sono stati assassinati, capisce? Solo che nessuno ci crede.
Se ci credessero, le cose andrebbero meglio”. Ma
meglio in che senso? Verrebbe da dire... Ormai i bambini sono
morti. Meglio forse nel senso di scagionarsi e di attribuire la colpa a
qualcun altro o addirittura a qualcos’altro?
All’invito immediato del dottore di approfondire e battere
fino in fondo questa pista, Billings svicola subito, e i suoi occhi si
fissano sulla porta dello stanzino (o del ripostiglio, dello
sgabuzzino, dell’armadio a muro, come viene traducendo di
volta in volta in italiano Tullio Dobner) dello studio del dottor
Harper. La parola nel racconto di King, che ritorna martellante (si
contano ben ventidue occorrenze nel testo), è sempre e solo
una: “closet”. Il luogo, almeno nello studio del
dottore, dove si appendono soprabito e soprascarpe. “Apra.
Voglio vedere”. Guardare nel “closet” del
proprio psichiatra durante la prima seduta? Ne avrà sentite
anche di peggio nella sua carriera il dottor Harper, se la replica
è alzarsi in silenzio, rassegnato, aprire la porta del
ripostiglio, e dare così seguito al desiderio del proprio
paziente. “Contento?”, chiede alla fine.
“Sì, grazie”.
Certo, Billings non si accusa esplicitamente, ma tenta di
ragionare insieme al laconico psichiatra sulla
(im)possibilità di dare credito ad altre spiegazioni.
“Sono stati assassinati, capisce? Solo che nessuno ci crede.
Se ci credessero, le cose andrebbero meglio”. Ma
meglio in che senso? Verrebbe da dire... Ormai i bambini sono
morti. Meglio forse nel senso di scagionarsi e di attribuire la colpa a
qualcun altro o addirittura a qualcos’altro?
All’invito immediato del dottore di approfondire e battere
fino in fondo questa pista, Billings svicola subito, e i suoi occhi si
fissano sulla porta dello stanzino (o del ripostiglio, dello
sgabuzzino, dell’armadio a muro, come viene traducendo di
volta in volta in italiano Tullio Dobner) dello studio del dottor
Harper. La parola nel racconto di King, che ritorna martellante (si
contano ben ventidue occorrenze nel testo), è sempre e solo
una: “closet”. Il luogo, almeno nello studio del
dottore, dove si appendono soprabito e soprascarpe. “Apra.
Voglio vedere”. Guardare nel “closet” del
proprio psichiatra durante la prima seduta? Ne avrà sentite
anche di peggio nella sua carriera il dottor Harper, se la replica
è alzarsi in silenzio, rassegnato, aprire la porta del
ripostiglio, e dare così seguito al desiderio del proprio
paziente. “Contento?”, chiede alla fine.
“Sì, grazie”.
Cos’è
che turba a tal punto Billings da chiedere al dottore di soddisfare una
curiosità così insensata?
C’è
un elemento ricorrente nelle uccisioni dei piccoli, e in ogni forma
delirante, chioserebbe il dottor Harper, esiste una logica stringente
che determina la catena degli eventi. Lo stanzino buio da cui sarebbe
emerso il Boogeyman, l’Uomo Nero (o il BauBau, come traduce
Dobner smontando il potenziale orrorifico) per ucciderli tutti
è lo stesso “closet” indicato dai tre
bimbi, il “closet” che resta aperto di un nonnulla
(“just a crack”, altro sintagma ricorrente nel
racconto) e da cui emergono gli artigli che ghermiscono le tre prede.
Il primo, sia detto per dovere di cronaca, muore dissanguato, col
sangue che gli è uscito dal didietro; la seconda per aver
ingoiato la propria lingua, morta soffocata per delle convulsioni
incontrollabili; Andy, il terzo, il bimbo che ridà gioia e
vita ai due genitori distrutti, il “ritratto fatto e
finito” di Lester, finisce col collo spezzato. Tutti e tre i
piccoli avevano avvertito i genitori che l’Uomo Nero, il
Boogeyman, si annidava nel ripostiglio pronto a uscire fuori al momento
opportuno, quando tutte le luci si fossero taciute, per portarseli via,
e ucciderli. Tra il racconto della morte di Denny e quello del trapasso
di Shirl gli occhi di Lester si posano ancora, magnetici, rapiti dal
ricordo forse, sulla porta dello stanzino. Il dottor Harper non
può non accorgersene e forse con una punta di sarcasmo gli
chiede se per caso la preferisca aperta, quella porta.
“No!” urla di rimando Lester, “con una
risatina nervosa”.
A chi importa di vedere
le soprascarpe di uno psichiatra?
Dopo la nascita di
Andy i due Billings si trasferiscono. La Cosa – a detta di
Lester – ci mette un anno a rintracciarli dopo il trasloco ma
alla fine ce la fa.
Una notte, tutte le porte della casa si spalancarono. Mi alzai, la mattina, e trovai una traccia di sudiciume e di fango che attraversava l’anticamera, dalla porta d’entrata all’armadio a muro. Una traccia che usciva? O che entrava? Non lo so! Davanti a Dio, proprio non lo so! Dappertutto tracce di fango, specchi rotti... e i rumori... i rumori...
Billings si passa una mano tra i capelli.
Ti svegliavano alle tre del mattino e allora guardavi nell’oscurità e lì per lì pensavi: ‘È soltanto l’orologio’. Ma sotto sotto, sentivi qualcosa che si muoveva in modo furtivo. Ma non troppo furtivo, perché voleva che lo sentissi. Un suono viscoso, melmoso, come di qualcosa che uscisse dallo scarico di cucina. Oppure un ticchettio, come di artigli che venissero trascinati leggermente su per la ringhiera delle scale. E allora chiudevi gli occhi, sapendo che se lo sentivi era già un guaio, ma se poi lo vedevi...
E così Billings arriva a raccontare la morte del suo terzo figlio, e lo fa con una voce in preda a un attacco isterico quando coglie sul fatto l’Uomo Nero. Svegliato dalle grida di terrore del suo angioletto, Billings accorre, ma è troppo tardi, e la paura è tanta, così tanta da impedirgli anche di accendere la luce quando si precipita nella cameretta di Andy.
E capii fino a che punto lo amavo perché corsi di là, senza nemmeno accendere la luce, correvo, correvo, correvo, oh, Gesù e Maria, il mostro lo aveva preso; stava scrollandolo, scrollandolo come un cane che scuote uno straccio, e vedevo qualcosa di orribile con le spalle spioventi e una testa da spaventapasseri e sentivo un odore come di topo morto dentro una bottiglia di gazzosa e sentivo...
Billings ritorna in sé per concludere:
“Sentii quando il collo di Andy si
spezzò”, producendo un rumore “come
quando si pattina su uno stagno, d’inverno, e il ghiaccio si
rompe”. Ma perché Billings non ha acceso la luce?
E perché è fuggito subito dopo senza tentare di
fare qualcosa? È chiaro che i sospetti a questo punto si
concentrano ancora di più tutti su di lui.
“Signor
Billings, ci sono tante cose di cui parlare”: sentenzia il
dottor Harper, invitando il paziente, se vuole cercare di liberarsi
completamente dai sensi di colpa, a prendere un appuntamento con la sua
infermiera. “Anzi ne prenda diversi. Va bene il
martedì e il giovedì?”.
Visibilmente
sollevato (“maledetto aggiustacervelli” bofonchia
tra un “all right” e l’altro) Billings va
verso la stanza dell’infermiera, che è
però vuota, con il tipico cartello “Torno
subito”. Billings torna indietro per chiedere al dottore cosa
fare. Lo studio è deserto, ma lo sgabuzzino è
aperto. Appena appena socchiuso, “just a crack”.
“So nice” dice la voce dallo sgabuzzino. Anche se
le parole suonano proprio come se uscissero da una bocca piena di
alghe. Billings rimane pietrificato sul posto, mentre la porta dello
sgabuzzino si spalanca. Billings sente d’improvviso, e
confusamente, uno strano senso di calore all’inguine. Si ha
questa sensazione, lo ricordate anche voi?, quando ci si piscia
addosso. “So nice” ripete l’Uomo Nero,
sgusciando dallo stanzino. “Aveva ancora la maschera da
dottor Harper nella mano putrida, a forma di artiglio”.
Dei
quattro archetipi fondamentali del genere, per seguire il King teorico
dell’orrore, il Vampiro, il Lupo Mannaro, la Cosa senza nome
e il Fantasma, siamo di fronte ad un mirabile esempio della Cosa,
anche se a questa Thing, per renderla
più percepibile e inquietante un nome è stato
dato, impersonificandola appunto: signore e signori, ecco a voi
l’Uomo Nero.
Nell’intelligente
introduzione proprio a Night Shift firmata dallo
stesso King leggiamo:
Tutte le nostre paure assommano a una sola, grande paura, fanno tutte parte di quell’unica paura: un braccio, una gamba, un dito, un orecchio. Abbiamo paura del cadavere sotto il lenzuolo. È il nostro cadavere. E il grande significato della narrativa dell’orrore, in tutte le epoche, è che essa serve da prova generale per la nostra morte.
L’orrore, come il soprannaturale, costituisce uno
schermo, un filtro tra il conscio e l’inconscio, tra
ciò che possiamo fare in tranquillità e quello di
cui dobbiamo sbarazzarci in un modo o nell’altro.
King
teorizza nel godibilissimo Danse Macabre del 1981
(2006), il saggio che lo scrittore del Maine dedica al
genere, tre sfumature diverse della paura. L’emozione
più fine è il terrore, quello
evocato dalle storie in cui non si vede niente di tremendo;
è il lavoro della mente a renderle insopportabili.
L’orrore è invece la cosa
amorfa ma dagli effetti fisici in quelle narrazioni in cui un oggetto,
un essere altro, si impossessa
di noi. Esiste poi un terzo livello, quello della repulsione.
Chiaramente
con The Boogeyman abbiano a che fare con un
sapiente incrocio dei tre livelli.
Sapiente anche
nel suo progredire punto per punto, nel suo modo di usare la storia
solo come un mezzo per arrivare all’ultima frase
d’effetto, come in Halloween (1978):
“Era l’Uomo Nero”, il Boogeyman, dice
sconvolta Jamie Lee Curtis nell’ultima scena del capolavoro
di John Carpenter. “Il terrore spesso nasce da un diffuso
senso di spiazzamento; quando le cose sembrano sul punto di sfasciarsi.
Se quel senso di disfacimento è improvviso e sembra
personale, se vi colpisce al cuore, allora si installa nella
memoria”, così ancora King in Danse
Macabre.
Ma The Boogeyman
è anche un modo per King di ritornare alle sue vecchie
rabbrividenti passioni. Billings durante la sua seduta nello studio del
dottor Harper ricorda difatti una storia horror di William M. Gaines, The
Haunt of Fear, direttamente dagli inquietanti Tales
from the Crypt (un fumetto della Ec Comics dei primi anni
Cinquanta): è la storia di un uomo ucciso dalla moglie in
combutta con l’amante di lei che ritorna per farla fuori.
“Era tutto marcito e verdastro, i pesci gli avevano mangiato
un occhio e aveva delle alghe nei capelli. Tornava e la uccideva. E
quando io mi svegliavo, nel cuore della notte, mi pareva che stesse
chinandosi sopra di me. Con gli artigli... dei lunghi
artigli...”
Quei fumetti
dell’orrore degli anni Cinquanta incarnano per King
“l’epitome dell’orrore,
quell’emozione di paura che giace sotto al terrore,
un’emozione un po’ meno fine, perché non
interamente mentale”.
Lo stesso
scuotimento emotivo che proviamo arrivati all’ultimo rigo di The
Boogeyman.
LETTURE
— King Stephen, A volte ritornano, Bompiani, Milano, 2000.
— King Stephen, Danse Macabre, Sperling & Kupfer, Milano, 2006.



