Una recente raccolta di racconti di Andrea Camilleri, Il
diavolo, certamente (2012), contiene trentatré
brevissime, fulminee storie in cui – in termini micidiali
– i tentativi imbastiti da altrettanti uomini o donne di fare
il Male si ritorcono puntuali e inesorabili contro i propri artefici.
La forza, l’entità che governa queste vendette
della realtà sugli uomini non appare mai, ma viene
esplicitamente evocata nel titolo, con una traccia di sottilissima,
quasi impercettibile ironia.
Leggendo questi
racconti dello scrittore siciliano si può immaginare un
legame con l’ironia di un altro scrittore – e di un
suo racconto – di più di mezzo secolo fa: lo
scrittore è lo svedese emigrato ad Amburgo Kurt Kusenberg, e
il racconto è Una certa stanza.
In
un tempo che non sappiamo, anche se siamo nel Novecento, in una
cittadina che non ha importanza sapere come si chiama, anche se
immaginiamo sia nel nord dell’Europa, in una strada, forse
suburbana, di cui è altrettanto fungibile il nome,
c’era – e forse c’è ancora
– un’abitazione (appartamento o villetta, ancora
una volta è superfluo saperlo) in cui dimoravano il signor
Klose, “uomo di modesta estrazione
piccolo-borghese” e la sua famigliola.
Nell’abitazione
dei Klose non poteva mancare il salotto buono, tenuto con estrema cura,
quasi sempre chiuso, se non qualche volta aperto la domenica per
ricevere parenti o amici – e durante la settimana
perché la giovane signorina Klose, la figliola
dell’inquilino, potesse esercitarsi al pianoforte. E, a
partire da questo (posto a troneggiare nel mezzo del salotto, o
collocato più discretamente in un angolo?), possiamo
immaginarne il resto dell’arredamento, i soprammobili, i
centrini all’uncinetto sotto questi, le passamanerie
damascate e tutta quella cara roba di pessimo gusto che appartiene
all’universo del kitsch.
Un cattivo gusto
probabilmente discreto anch’esso, sobrio, attento al decoro
per così dire, come si conviene ad una famigliola perbene,
senza slanci, né preoccupazioni, se non quelle minime,
legate alla dignità della vita quotidiana. Un
ménage, possiamo immaginare, routinario, regolare, una fila
ininterrotta di giornate sempre uguali a se stesse
all’insegna del decoro piccolo borghese.
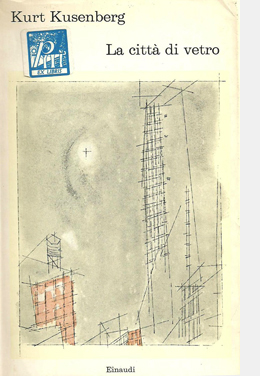 Pure… pure, come spesso accade – come la
letteratura ci rivela quanto spesso succeda
– seppur nell’inconsapevolezza dei padroni di casa,
quella “certa stanza” non è nemmeno
lontanamente ciò che appare. Nasconde un segreto
inquietante. Malvagio? Benigno? O semplicemente impersonale,
demiurgico, metafisico? Ciò che avviene
in quella stanza – i piccoli spostamenti dei soprammobili,
l’aprirsi o chiudersi dei tendaggi, i movimenti delle sedie
(forse anche la pressione sui tasti del pianoforte) si riverbera
amplificandosi fin nei luoghi più lontani del pianeta, a
volte catastroficamente (terremoti, morti, disastri), a volte con
conseguenze benefiche (matrimoni, nascite, vincite alla
lotteria…). Insomma, il salotto buono della
famiglia Klose è il centro di una rete infinita di fili
invisibili che legano gli oggetti che vi sono contenuti
all’intero mondo, e ne decidono gli eventi – e la
sorte degli uomini e delle donne coinvolti. Quello che viene chiamato
“Effetto farfalla”, insomma. E
l’aspetto inquietante della cosa è che fra i
presenti, padroni di casa e invitati, non c’è
nessuna consapevolezza del rapporto micro/macro che esiste fra la
stanza del signor Klose e il mondo esterno. Né, tantomeno,
la conoscenza del linguaggio che “traduce” gli
eventi che accadono nel salotto negli avvenimenti che si verificano nel
mondo esterno.
Pure… pure, come spesso accade – come la
letteratura ci rivela quanto spesso succeda
– seppur nell’inconsapevolezza dei padroni di casa,
quella “certa stanza” non è nemmeno
lontanamente ciò che appare. Nasconde un segreto
inquietante. Malvagio? Benigno? O semplicemente impersonale,
demiurgico, metafisico? Ciò che avviene
in quella stanza – i piccoli spostamenti dei soprammobili,
l’aprirsi o chiudersi dei tendaggi, i movimenti delle sedie
(forse anche la pressione sui tasti del pianoforte) si riverbera
amplificandosi fin nei luoghi più lontani del pianeta, a
volte catastroficamente (terremoti, morti, disastri), a volte con
conseguenze benefiche (matrimoni, nascite, vincite alla
lotteria…). Insomma, il salotto buono della
famiglia Klose è il centro di una rete infinita di fili
invisibili che legano gli oggetti che vi sono contenuti
all’intero mondo, e ne decidono gli eventi – e la
sorte degli uomini e delle donne coinvolti. Quello che viene chiamato
“Effetto farfalla”, insomma. E
l’aspetto inquietante della cosa è che fra i
presenti, padroni di casa e invitati, non c’è
nessuna consapevolezza del rapporto micro/macro che esiste fra la
stanza del signor Klose e il mondo esterno. Né, tantomeno,
la conoscenza del linguaggio che “traduce” gli
eventi che accadono nel salotto negli avvenimenti che si verificano nel
mondo esterno.
Finché qualcuno – non
sappiamo come, ma ha davvero importanza? – lo scopre. Un
certo Paik, piccolo lestofante, poco raccomandabile faccendiere
coinvolto in loschi traffici, che si muove subito oltre i confini della
legalità e dell’etica, che per un certo periodo ha
frequentato il salotto, ha scoperto che “su una staccionata
di assi, dove gli abitanti del quartiere erano soliti attaccare dei
piccoli annunci […] comparivano regolarmente certi foglietti
scritti in rosso, i quali contenevano comunicazioni, per esempio, del
seguente tenore: Caricato l’orologio – Flagello di
cavallette nel Siam, Spazzolato il tappeto – colpo di stato
in Argentina”.
Fatta questa scoperta, Paik si impegna su due fronti:
sorveglia la staccionata, per registrare quanti più
collegamenti è possibile, e si ingegna, ogni volta che
è ospite a casa dei Klose, a fare esperimenti per conto
proprio. Il suo intento e costruire un vero e proprio dizionario
“salotto-mondo”, per poter poi sfruttare le cose a
suo vantaggio, orientando i suoi traffici sulle conseguenze degli
eventi esterni che riesce a provocare. Una specie di “insider
trading” del destino, insomma, ma a livelli demiurgici, e con
gran beneficio dei suoi affari.
Addirittura, nel momento in
cui il padrone di casa gli ingiunge di non farsi più vedere
perché teme per la virtù e la serenità
della figlia (che Paik aveva fatto capire di voler sposare, senza mai
decidersi a farlo), il losco individuo giunge a addestrare un suo
conoscente piuttosto stolido che frequenta la casa, perché
agisca al posto suo e provochi gli eventi che Paik vuole che si
verifichino. E così riesce, per un po’, a superare
l’ostracismo che Klose gli ha imposto.
Ma in tutto
c’è un ordine – metafisico o meno
– che governa le cose. Le leggi che regolano il destino degli
umani, che siano frutto di una meccanica senza volontà, o di
un disegno consapevole, hanno una loro forza, e un robusto legame con
l’equilibrio dell’universo. E, senza aver bisogno
di una figura soprannaturale – come il diavolo di Camilleri
– si ribellano alle forzature.
Accade
così che – nel tentativo di riuscire a realizzare
una mappatura completa dei rapporti fra micro e macromondo –
il farabutto fa un gesto avventato. Ordina al suo “braccio
esecutivo” di eseguire un’operazione di cui
può solo dedurre, sulla base dei suoi
“calcoli”, le conseguenze, ma che si rivela nei
suoi esiti fatale: la sua stessa morte.
L’ordine
è ristabilito. L’armonia – seppur
indecifrabile – delle catene che legano cause ed effetti
viene ristabilita. Che sia fato, destino, caso, o necessità.
Che sia il frutto di un’architettura precisa, o che affondi
la sua ragione nelle profondità dell’abisso del
continuum spazio/temporale, l’ordine delle cose non
può essere ostaggio di un qualsiasi piccolo uomo, che costui
si muova a fin di bene, o sia un malintenzionato egomaniaco. Se
le buone intenzioni, insomma, ci spalancano davanti le porte
dell’inferno, figuriamoci le cattive, sembra sostenere questo
racconto. Anzi, questa parabola, nel senso in cui lo erano quelle di
Franz Kafka, “parabole cui è stata sottratta la
chiave”, secondo Theodor W. Adorno (1972), che a sua volta
citava l’Angelus Novus (1976) di Walter
Benjamin.
È per questo che dobbiamo
fermarci al “sembra”, che non possiamo essere
sicuri che quello che abbiamo ipotizzato per il racconto di Kusenberg
ne sia il senso.
Come si potrebbe dire degli altri racconti di
Kurt Kusenberg, che diceva della sua scrittura: “Se qualcuno
trova un senso nelle mie storie, è affar suo: io non ce
l’ho messo. Sussiste naturalmente la
possibilità che il senso ci sia capitato dentro a mia
insaputa” (corsivo nostro), ammettendo
così da sé la possibilità di essere
soltanto uno sciamano, un mortale unto e invaso dal demone della
letteratura – a sua volta espressione di sfere esterne,
superiori, trascendenti.
Di Kurt Kusenberg (1904/1983), studioso di Storia
dell’arte e narratore fra il grottesco, l’onirico e
il surreale, in italiano è stata pubblicata solo una scelta
di racconti, La città di vetro (1964),
da cui sono tratti anche Una certa stanza e la
frase virgolettata qui sopra.
Uno scrittore eccentrico,
irriducibile per certi versi alle classificazioni, per la cifra serena,
referenziale, cronachistica e neutrale con cui narra le sue storie,
senza prendere le parti di nessuno dei personaggi, concentrato
com’è nel narrare la stranezza del mondo e delle
cose, la loro indecifrabilità sostanziale.
Come in
questo racconto, se vogliamo paradigmatico: esiste un ordine nelle cose
umane, ma appartiene ad una sfera intangibile, ineffabile, tanto che se
la si sfiora questa si ribella per riequilibrarsi – e sa
essere spietata.
Tema fino a Kusenberg trattato con molta
maggiore drammaticità, nel dominio del fantastico puro, del
gotico, dell’horror, della fantascienza.
“Esistono più cose in cielo e in Terra, lettore,
che in tutta la tua filosofia”, insomma, parafrasando
l’Amleto di William Shakespeare. Con qualche forzatura
interpretativa, l’archetipo di tutte le storie che ci
ricordano che esistono soglie che è meglio non varcare,
segreti che è più che opportuno non violare,
misteri che si fa bene a non cercare di decifrare.
Ma per
affermarlo e dimostrarlo, a leggere Kusenberg, non
c’è bisogno di evocare le ire del cielo e
dell’inferno, quanto piuttosto la saggezza delle cose stesse.
Che non ha intenzionalità né valore,
né direzione. Ma punisce la presunzione e
l’arroganza degli uomini, dimostrandogli – con la
ferocia dell’inconsapevolezza delle cose – che il
principio umanista che poneva l’Uomo al centro
dell’universo è falso, è pura
illusione. Che non basta liberarsi dal dominio del sacro, che non
è solo una questione di soggezione a qualcosa di inventato
da noi uomini: la struttura della realtà è forte,
e ha i suoi percorsi. E non tollera interferenze, forzature. Un
po’ come nell’ultimo romanzo di Stephen King, 22/11/’63,
di cui ci siamo di recente occupati (
www.quadernidaltritempi.eu/rivista/numero36/bussole/q36_b05.htm),
anche se King si misura con eventi e biografie molto più
imponenti.
Insomma, all’opera sembra essere ciò che
Jean Baudrillard (1984) definì, anche se in un contesto
decisamente diverso, “lo scaltro genio
dell’oggetto”, la capacità che sembra
abbiano acquisito le cose di mimetizzarsi, nascondersi
all’osservatore, ingannarlo, sfuggirgli. Una riscrittura,
all’ingresso nella tarda modernità e
nell’era della simulazione, delle riflessioni del filosofo
Ernst Mach sull’impossibilità di stabilire con
certezza le relazioni di causa/effetto nello studio dei fenomeni.
Seguiamo il suo ragionamento: “Dall’inizio del XX
secolo la scienza riconosce che ogni dispositivo
d’osservazione a livello microscopico provoca una tale
alterazione nell’oggetto da metterne in forse la
conoscenza”.
Baudrillard ne trae
implicazioni vertiginose: “Non viene mai fatta
l’ipotesi, al di là della sua distorsione, di una ritorsione
attiva da parte dell’oggetto al fatto di essere
interrogato, sollecitato, violato” (ibidem,
corsivo nostro).
Ora, tornando a Kusenberg il nostro Paik non
si preoccupa assolutamente di cercare di sapere qual è il
rapporto fra cause ed effetti, cos’è che lega il
salotto dei Klose al resto del mondo. Gli basta conoscere, grazie alla
pura osservazione dei dati (i biglietti sulla staccionata), cosa
succederà. Ma compie una violazione ancor più
estrema: cerca di sfruttare ai suoi fini – illeciti
– le sue osservazioni, anzi, cerca di produrre
eventi. Peccato ancor più grave, dal punto di vista
dell’oggetto-realtà,
evidentemente. Che lo punisce annichilendolo. “Si potrebbe
immaginare – scrive ancora Baudrillard – che
l’oggetto finga di obbedire alle leggi della fisica solo
perché fa molto piacere all’osservatore”
(ibidem, corsivo nel testo). Con una coda che
aggiungiamo noi, pensando al signor Paik: Finché
non perde la pazienza, e non si libera dell’osservatore.
“Questa
sarebbe la patafisica – se seguiamo ancora il filosofo
francese – che minaccia ogni fisica alle sue
estremità inconfessabili” (ibidem).
LETTURE
— Adorno Theodor W., Appunti su Kafka, in Prismi, Einaudi, Torino, 1972.
— Baudrillard Jean, Le strategie fatali, Feltrinelli, Milano, 1984.
— Benjamin Walter, Franz Kafka, in Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1976.
— Camilleri Andrea, Il diavolo, certamente, Mondadori, Milano, 2012.
— King Stephen, 22/11/’63, Sperling & Kupfer, Milano, 2011.
— Kusenberg Kurt, Una certa stanza, in La citta di vetro, Einaudi, Torino, 1964.



