|
|
DOCUMENTARI DEL NON-VERO LA PROPAGANDA DURANTE LA GUERRA FREDDA
di Giorgio Signori |
|
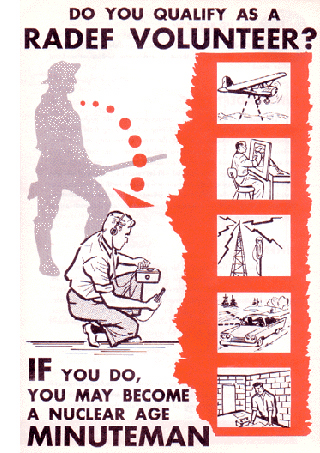 Il metodo osservativo offre cosi
l’opportunità al pubblico di
calarsi nelle esperienze di qualcun altro, di conoscere la sua
quotidianità, realizzando il sogno spiccatamente
voyeuristico del
cinema di vedere “senza essere visto11”. Volendo
recepire questa
categorizzazione a posteriori, è possibile inquadrare i
filmati della
Guerra Fredda nella prima categoria, in virtù della grande
forza
empatica che determinate immagini riescono a evocare, e
dell’importanza
attribuita alla reazione emotiva e alla relazione con lo spettatore. In
riferimento alla Guerra Fredda la questione è resa ancor
più
interessante dal momento che alcuni filmati di propaganda, frutto di
un’accurata messa in scena, e non propriamente documentari
nel senso
stretto del termine, sono proposti al pubblico nella forma e nei
linguaggi tipici del documentario, influenzandone la percezione. Il
film può essere dunque “venduto” come
reale al fine di alterare la
percezione che il pubblico può avere del prodotto, o di se
stesso.
Il metodo osservativo offre cosi
l’opportunità al pubblico di
calarsi nelle esperienze di qualcun altro, di conoscere la sua
quotidianità, realizzando il sogno spiccatamente
voyeuristico del
cinema di vedere “senza essere visto11”. Volendo
recepire questa
categorizzazione a posteriori, è possibile inquadrare i
filmati della
Guerra Fredda nella prima categoria, in virtù della grande
forza
empatica che determinate immagini riescono a evocare, e
dell’importanza
attribuita alla reazione emotiva e alla relazione con lo spettatore. In
riferimento alla Guerra Fredda la questione è resa ancor
più
interessante dal momento che alcuni filmati di propaganda, frutto di
un’accurata messa in scena, e non propriamente documentari
nel senso
stretto del termine, sono proposti al pubblico nella forma e nei
linguaggi tipici del documentario, influenzandone la percezione. Il
film può essere dunque “venduto” come
reale al fine di alterare la
percezione che il pubblico può avere del prodotto, o di se
stesso.
Allargando il campo, è possibile sottolineare come l’analisi dei prodotti al di fuori del circuito cinematografico mainstream, dal cinema di finzione tradizionale, può estendersi a tutti quei prodotti la cui origine va oltre la semplice definizione di “documentario”. Questo include, ad esempio, i cortometraggi, la pubblicità, e, appunto, la propaganda. Un lavoro di riferimento sul piano metodologico dell’analisi e sicuramente quello di Lino Miccichè, che analizza le tendenze del linguaggio del cinema italiano a partire proprio dal documentario, in un periodo che va dal 1945 al 1965. Dall’analisi di Miccichè emerge la fisionomia di un genere che, sviluppatosi contemporaneamente al Neorealismo, rappresenta un punto di vista eccezionale per lo studio e la fotografia di una società vista da un occhio contemporaneo12. L’esempio italiano aiuta a definire l’evoluzione di un genere, quello documentario (anche se la definizione di documentario, a questo punto, risulta assai limitativa), che può vantare un corpus rilevantissimo sia in termini di quantità, sia in termini di rilevanza dei meccanismi del linguaggio, sia dal punto di vista dell’indizio “sociale”. 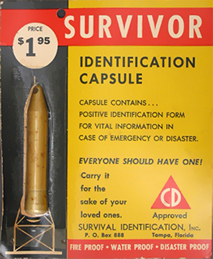 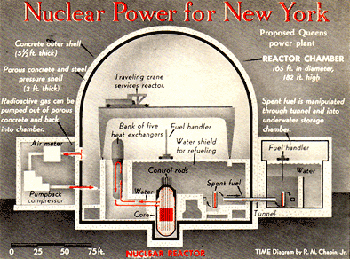 
| ||
|
Avvicinandosi ulteriormente all’oggetto di questa analisi, Augusto Sainati sottolinea che: “la nozione di cinema di non-fiction, o più specificatamente quella di cinema documentario, del cui vasto territorio le attualità cinematografiche fanno parte, sembra far pensare di primo acchito a una forma filmica di per sé priva di artificio, legata a una funzione perlopiù testimoniale, in un certo senso ritratta di fronte al proprio sguardo, che sarebbe portata e restituire oggettivamente”13. La percezione che si ha del documentario parte dunque dalle premesse formali e percettive del prodotto presentato come tale. L’oggettività delle immagini è dunque solo presunta, in funzione di tale punto di vista, sempre presente con la propria influenza anche in situazione di apparente neutralità. Non è importante, ai fini dell’analisi, validare le affermazioni contenute nei filmati della Guerra Fredda in termini di oggettività, verità o realtà, perché la positività di tale giudizio non è necessaria né vincolante, e la negatività non esclude la possibilità di trarre delle conclusioni storicamente significative. Giungere a tale consapevolezza apre una serie di possibilità d’analisi che possono essere con gran forza ritenute scientifiche a tutti gli effetti, sotto forma di un procedimento metodologico indiziario (nel senso ginzburghiano del termine) che sia in grado, in questo come altri casi, di recuperare la forma filmica come fonte d’indagine storica e sociologica. |
||
| [1] [2] [3] [4] [5] (6) | ||
|
|
||
|
11.
È dunque principalmente,
in definitiva, il modo in cui lo spettatore percepisce il film, la modalita del consumo, a polarizzare l’inclusione di un prodotto in una macrocategoria come quella del documentario, come emerge in B. Nichols, Representing reality. Issues and concepts in documentary, Indianapolis, Bloomington, 1991. |
12.
Si veda in particolare
Lino Miccichè, Studi di dodici sguardi d’autore in cortometraggio, Torino, Lindau, 1955. |
13.
Augusto Sainati,
“Stile e formato dell’informazione ‘Incom’”, in A. Sainati, La settimana Incom, cinegiornali e informazione negli anni ’50, Lindau, Torino, 2001. |
|
|||
|
|
||||||
|
bibliografia
| ||||||
|
Bazin, A., “Ontologia dell’immagine fotografica”, in Che cos’e il cinema?, Garzanti, Milano, 1973. Bordwell, D., Thompson, K., CINEMA come ARTE. Teoria e prassi del film, Il Castoro, Milano, 2003. e Luna, G., La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo, Nuova Italia, Firenze, 2001. Grierson, J., Documentario e realtà, in “Bianco e Nero”, 1950 |
Metz,C., Cinema e psicanalisi, il significante immaginario, Tascabili Marsilio, Venezia, 1980. Metz,C., Semiologia del cinema, Milano, Garzanti, 1972. Miccichè, L., Studi di dodici sguardi d’autore in cortometraggio, Lindau, Torino, 1955. |
Montani, P., L’immaginazione narrativa, il racconto del cinema oltre i confini dello spazio letterario, Guerini, Milano, 1999 Nepoti, R., Storia del documentario, Patron, Bologna, 1988. Nichols, B., Representing reality. Issues and concepts in documentary, Indianapolis, Bloomington, 1991. |
Odin, R., 'L'entrée du spectateur dans la fiction', in J. Aumont, J.L. Leutrat, Théorie du film, Paris, 1980. Odin, R., Della finzione. Milano, Vita e Pensiero, 2004. Sainati, A., “Stile e formato dell’informazione 'Incom'”, in A. Sainati, La settimana Incom, cinegiornali e informazione negli anni ’50, Lindau, Torino, 2001. |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|