|
|
DOCUMENTARI DEL NON-VERO LA PROPAGANDA DURANTE LA GUERRA FREDDA
di Giorgio Signori |
|
|
| ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
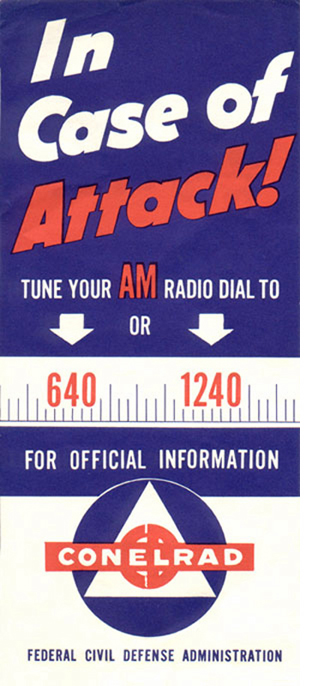 L’analisi diventa dunque una continua negoziazione
del senso tra ciò
che si vede e ciò che vi si può leggere. In
realtà “non ci può essere
la lettura storica di un film senza riferimenti ad alcune categorie
interpretative mutuate da altre discipline come la semiologia e
l’antropologia e, soprattutto, prescindendo dalla mediazione
concettuale offerta da una nozione come quella di ‘cultura
cinematografica’ come chiave per decifrarne
l’ambiguità e la
complessità dei segni e dei significati”3. Soffermarsi
sul problema della falsificazione che ogni filmato,
qualunque sia la propria origine, porta in sé, è
riduttivo, in quanto
l’oggettività è in realtà un
falso problema. Chi cerca di ricostruire
la storia deve invece tentare di comprendere la realtà
rappresentata e
collocata all’interno dell’impalcatura narrativa
del film. I filmati di
propaganda della Guerra Fredda giocano molto su questa
ambiguità:
utilizzano forme del linguaggio cinematografico che aiutano a veicolare
un’immagine di verità, ma contemporaneamente, a
volte ne palesano la
finzione.
L’analisi diventa dunque una continua negoziazione
del senso tra ciò
che si vede e ciò che vi si può leggere. In
realtà “non ci può essere
la lettura storica di un film senza riferimenti ad alcune categorie
interpretative mutuate da altre discipline come la semiologia e
l’antropologia e, soprattutto, prescindendo dalla mediazione
concettuale offerta da una nozione come quella di ‘cultura
cinematografica’ come chiave per decifrarne
l’ambiguità e la
complessità dei segni e dei significati”3. Soffermarsi
sul problema della falsificazione che ogni filmato,
qualunque sia la propria origine, porta in sé, è
riduttivo, in quanto
l’oggettività è in realtà un
falso problema. Chi cerca di ricostruire
la storia deve invece tentare di comprendere la realtà
rappresentata e
collocata all’interno dell’impalcatura narrativa
del film. I filmati di
propaganda della Guerra Fredda giocano molto su questa
ambiguità:
utilizzano forme del linguaggio cinematografico che aiutano a veicolare
un’immagine di verità, ma contemporaneamente, a
volte ne palesano la
finzione.Nell’analisi del vero e del funzionale nel film non ci si riferisce quindi esclusivamente ai film cosiddetti di fiction: i confini fra il documentario e la finzione sono sfumati, spesso intrecciati. Se il film è fiction, ciò non significa che sia completamente avulso dall’attualità, anche perché non tutto quel che viene mostrato o sottinteso in un film deve essere immaginario. Attraverso il tema, il soggetto, la caratterizzazione e altri mezzi, un film di finzione può presentare, in maniera più o meno diretta, delle idee sul mondo reale4. Tenendo presente questo vasto range di sfumature, è possibile avvicinarsi al “documentario” della Guerra Fredda con meno circospezione: ci si trova di fronte a un prodotto che ha forma di documentario, ma finalità propagandistiche. Ma, essendo l’oggettività un falso problema, questa caratterizzazione non è fondante per l’analisi: è possibile analizzare gli elementi di questi documentari privi del pregiudizio sul reale, perché non è la finalità autoriale o la destinazione propagandista a nascondere le tracce lasciate sulla pellicola. A volte la nostra reazione a un film di finzione è plasmata sulle nostre illazioni su come esso è stato realizzato. Tuttavia le modalità con cui le immagini e i suoni sono prodotti non sono sufficienti a distinguere nettamente film di finzione e documentari. Ciò che veramente distingue queste macrocategorie filmiche, come ricorda Roger Odin5, è solo l’atteggiamento spettatoriale, l’insieme delle modalità percettive, l’effetto prodotto in chi guarda. Avendo in mente queste caratteristiche è facile arrivare al ritenere film di finzione e documentari come egualmente degni di essere considerati fonti storiche. Parte del discorso analitico della produzione cinematografica originata al di fuori dei grandi circuiti internazionali è concentrato su film che possono fregiarsi di appartenere alla macrocategoria dei “documentari”. Definire questo genere è un’operazione ardua che ha alimentato, sin dagli albori del cinema, un dibattito ancora oggi particolarmente acceso e tuttora aperto. L’inserimento dei filmati della Guerra Fredda in questa categorizzazione ha contorni sfumati, orientati tra l’uso di un linguaggio tipico del documentario, e contenuti sapientemente montati e selezionati a fini propagandistici. Come posizionarli all’interno di una macrocategoria dai tratti spesso ambigui e incerti? Per dare una risposta e necessario ripercorrerne le caratteristiche fondanti. 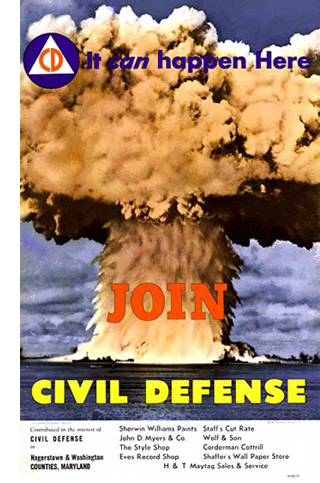 Una delle prime
definizioni di documentario parte da John Grierson,
produttore scozzese e padre della scuola documentaristica inglese, che
nel 1932 formalizza le sue tesi in un manifesto teorico dei
documentari, intesi come un vasto repertorio di testi filmici sulla
base di una loro presunta aderenza alla materia realistica6. Una delle prime
definizioni di documentario parte da John Grierson,
produttore scozzese e padre della scuola documentaristica inglese, che
nel 1932 formalizza le sue tesi in un manifesto teorico dei
documentari, intesi come un vasto repertorio di testi filmici sulla
base di una loro presunta aderenza alla materia realistica6.La problematica però e ancora abbondantemente in fieri: la principale osservazione riguarda la tipica tendenza del ricondurre alla denominazione di documentario una pluralità di differenti realtà cinematografiche non omogenee fra di loro. Ne consegue una grande difficoltà nell’individuare il documentario come genere a sé stante, visto semplicemente come un insieme di prodotti accomunati in base ad un generico trattamento della realtà. Avendo bisogno di una categorizzazione, impossibile non partire dall’opera del semiologo Christian Metz, che osserva come i film non narrativi si distinguano dai film di finzione più per intenzionalità sociale e per il contenuto che non per gli effettivi procedimenti di linguaggio. L’approccio tipicamente semiotico si sofferma sulla modalita percettiva dello spettatore, che è il vero elemento in cui si chiude il cerchio della rappresentazione documentaria. Non esiste, secondo Metz, una grande differenza al livello del linguaggio cinematografico, tra film di finzione e documentario: le grandi figure fondamentali della semiologia del cinema (montaggio, movimenti di macchina, scala dei piani, sequenze, raccordi tra le inquadrature ecc.) conservano la loro identità anche nel cinema non di finzione. È quindi l’atteggiamento spettatoriale nei confronti del prodotto a sancire, sotto forma di percezione, l’appartenenza al genere documentario. Al livello del linguaggio dei segni la dicotomia fiction/non fiction è basata su elementi non determinanti, e i criteri di differenziazione (presenza del racconto, discriminante dell’attore, ecc.) non sono risolutivi: il racconto è una dimensione rintracciabile anche nel documentario, così come esiste un livello diegetico. Piuttosto che nell’opposizione fiction/non fiction, le marche differenzianti del documentario andranno ricercate sul terreno del rapporto con la realtà e nei relativi modi di codificazione linguistica7. |
||
| [1] [2] (3) [4] [5] [6] | ||
|
|
|
3.
G. De Luna,
La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo, Firenze, La Nuova Italia, 2001. |
6.
Su Grierson cfr. R. Nepoti,
Storia del documentario, Bologna, Patron, 1988. Si veda inoltre il saggio dello stesso Grierson, J. Grierson, Documentario e realtà, in “Bianco e Nero”, 1950. |
7.
Id., pp. 11.
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|