|
|
DOCUMENTARI DEL NON-VERO LA PROPAGANDA DURANTE LA GUERRA FREDDA
di Giorgio Signori |
|
 Nel caso dei filmati della Guerra Fredda, è
interessante porsi la
domanda su quale possa essere l’atteggiamento spettatoriale
di chi li
guarda, ma soprattutto, per capire i linguaggi della propaganda, quale
poteva essere tale atteggiamento cinquanta anni fa. Oggi infatti, con
la forza di una cultura scientifica ben più diffusa e di
più facile
portata, si tende a trovare risibili le tesi e le posizioni mostrate
nel film, ad immaginare grottesche determinate affermazioni
(soprattutto, sulla minimizzazione dei rischi atomici). La chiave di
lettura per immedesimarsi nello spettatore dei primi anni Cinquanta
è
la paura: occorre calarsi nello stato psicologico innestato da una
situazione instabile e ansiogena come la Guerra Fredda. Con tutta
probabilità l’atteggiamento spettatoriale doveva
essere del tutto
analogo a quanto oggi si può provare nel rapportarsi a
prodotti
audiovisivi, più sottili e liminali ma inequivocabilmente
eredi della
medesima propaganda, che affrontano le paure del terrorismo
internazionale. La paura innescata da immagini spettacolari e terribili
della bomba atomica ha il medesimo DNA mediatico delle esplosioni
dell’11 Settembre: l’incertezza, la
novità, il timore, l’incredulità,
sono gli ingredienti necessari a recepire e capire
l’atteggiamento di
chi era spettatore nel pieno della Guerra Fredda. Analogamente, si
ripropone oggi la contrapposizione tra due visioni ideologiche
totalizzanti, e l’enfatizzazione di un nemico che, reale e
non
costruito, rappresenta una minaccia presentata come subdola e
incontrollabile.
Nel caso dei filmati della Guerra Fredda, è
interessante porsi la
domanda su quale possa essere l’atteggiamento spettatoriale
di chi li
guarda, ma soprattutto, per capire i linguaggi della propaganda, quale
poteva essere tale atteggiamento cinquanta anni fa. Oggi infatti, con
la forza di una cultura scientifica ben più diffusa e di
più facile
portata, si tende a trovare risibili le tesi e le posizioni mostrate
nel film, ad immaginare grottesche determinate affermazioni
(soprattutto, sulla minimizzazione dei rischi atomici). La chiave di
lettura per immedesimarsi nello spettatore dei primi anni Cinquanta
è
la paura: occorre calarsi nello stato psicologico innestato da una
situazione instabile e ansiogena come la Guerra Fredda. Con tutta
probabilità l’atteggiamento spettatoriale doveva
essere del tutto
analogo a quanto oggi si può provare nel rapportarsi a
prodotti
audiovisivi, più sottili e liminali ma inequivocabilmente
eredi della
medesima propaganda, che affrontano le paure del terrorismo
internazionale. La paura innescata da immagini spettacolari e terribili
della bomba atomica ha il medesimo DNA mediatico delle esplosioni
dell’11 Settembre: l’incertezza, la
novità, il timore, l’incredulità,
sono gli ingredienti necessari a recepire e capire
l’atteggiamento di
chi era spettatore nel pieno della Guerra Fredda. Analogamente, si
ripropone oggi la contrapposizione tra due visioni ideologiche
totalizzanti, e l’enfatizzazione di un nemico che, reale e
non
costruito, rappresenta una minaccia presentata come subdola e
incontrollabile.A livello linguistico si indaga sul rapporto fra cinema e realtà. Questo rapporto obbliga a addentrarsi nel delicato dibattito filosofico fra Reale/Immaginario, Realtà/Rappresentazione, Vero/Falso. Queste problematiche tendono erroneamente a interrogarsi sulla posizione autoriale e su quanto sia possibile, con la macchina del cinema, far coincidere il reale con la visione del reale che è il prodotto risultante dall’operazione di costruzione. È un dato di fatto che queste due realtà non sono sovrapponibili, ma ci si può domandare come l’autore ci restituisca la propria, personalissima visione di reale. È proprio nel documentario che si riscontra la tendenza più accentuata verso la coincidenza fra Realtà e sua Rappresentazione, almeno nelle intenzioni di chi fa il documentario e che qui, parafrasando l’istanza narrativa di Metz, può essere definita istanza rappresentativa. Tale istanza non è assoluta, e giammai scissa dal proprio creatore. 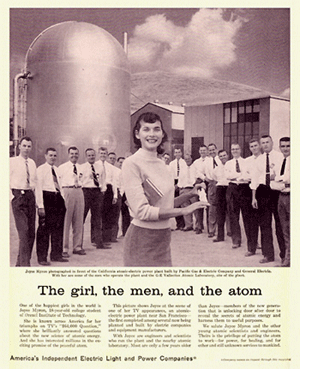 Roger Odin proseguendo sulla strada della
percezione da parte dello
spettatore, individua due modalità di lettura: una
documentarizzante,
una finzionalizzante. Nella prima il lettore non deve far coincidere
l’enunciatore del film con il suo autore, bensì
con l’entità costruita
presupponendo la realtà di questo enunciatore. Si tratta di
una lettura
critica, in grado di esplicare la prospettiva sull’enunciato,
che opera
in sinergia con un’insita attività epistemica di
indicalità, e che può
entrare in gioco rispetto a qualsiasi genere di film. Il fondamento
della lettura documentarizzante, opposta a quella della fiction, non
sarebbe allora la realtà del rappresentato, ma quella
presupposta
dell’enunciatore. Gli enunciatori reali del film possono
essere
molteplici: il regista, l’operatore, lo sceneggiatore. Tali
elementi
sono i medesimi tanto nel cinema documentario quanto in quello
finzionale. Il tipo di lettura documentarizzante varierà al
variare del
tipo di enunciatore reale scelto. L’atto di lettura
documentarizzante è
quindi un’operazione che mette in moto un sistema interattivo
a tre
attanti: un film, un’istituzione, un lettore. Sinteticamente,
l’istituzione regola la costituzione dell’immagine
del documentarista operata dallo spettatore, che nel caso dei
documentari, si vede negare l’accesso alle intenzioni
illocutorie del
locutore, in modi da confrontare con ciò che accade nel
mondo
dichiaratamente immaginario del film di finzione8.
Roger Odin proseguendo sulla strada della
percezione da parte dello
spettatore, individua due modalità di lettura: una
documentarizzante,
una finzionalizzante. Nella prima il lettore non deve far coincidere
l’enunciatore del film con il suo autore, bensì
con l’entità costruita
presupponendo la realtà di questo enunciatore. Si tratta di
una lettura
critica, in grado di esplicare la prospettiva sull’enunciato,
che opera
in sinergia con un’insita attività epistemica di
indicalità, e che può
entrare in gioco rispetto a qualsiasi genere di film. Il fondamento
della lettura documentarizzante, opposta a quella della fiction, non
sarebbe allora la realtà del rappresentato, ma quella
presupposta
dell’enunciatore. Gli enunciatori reali del film possono
essere
molteplici: il regista, l’operatore, lo sceneggiatore. Tali
elementi
sono i medesimi tanto nel cinema documentario quanto in quello
finzionale. Il tipo di lettura documentarizzante varierà al
variare del
tipo di enunciatore reale scelto. L’atto di lettura
documentarizzante è
quindi un’operazione che mette in moto un sistema interattivo
a tre
attanti: un film, un’istituzione, un lettore. Sinteticamente,
l’istituzione regola la costituzione dell’immagine
del documentarista operata dallo spettatore, che nel caso dei
documentari, si vede negare l’accesso alle intenzioni
illocutorie del
locutore, in modi da confrontare con ciò che accade nel
mondo
dichiaratamente immaginario del film di finzione8.Ma come funziona il procedimento di identificazione e atteggiamento spettatoriale nei riguardi del documentario? Il personaggio tende a diventare un oggetto dello spazio rappresentato, entrando nel film proprio nella misura del rapporto con esso. Ciò provoca generalmente reazioni di spiazzamento nello spettatore, il quale si trova nella condizione di dover trovare altre vie d’identificazione. Può venirci a questo proposito in soccorso la distinzione di Metz tra identificazione cinematografica primaria e secondaria9. |
||
| [1] [2] [3] (4) [5] [6] | ||
|
|
||
|
8.
Sul rapporto tra realtà
e finzione nel cinema Roger Odin, della scuola francese, è un autore chiave. Cfr. R. Odin, L'entrée du spectateur dans la fiction, in J. Aumont, J.L. Leutrat, Théorie du film, Paris, 1980. |
9.
A tal proposito si veda
C. Metz, Cinema e psicanalisi, il significante immaginario, Venezia, Tascabili Marsilio, 1980. |
|
|
|||
|
|
||||||
|
|
|
|