|
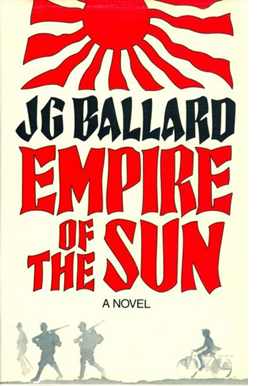 Lo stadio è diventato
durante la guerra la centrale operativa dell’esercito
giapponese di stanza nella Cina meridionale, e quando Jim e gli
internati di Lunghua vi arrivano nel corso della loro estenuante marcia
verso Nantao trovano ad accoglierli le ombre della loro vita
precedente. Nell’enorme stadio sono stati stipati dai
giapponesi tutti i mobili pregiati, le auto americane, i tappeti
persiani e le statue di marmo appartenenti agli occidentali della
Concessione, e sottratti durante il sacco di Shanghai successivo allo
scoppio della guerra. Jim ritrova la Packard dei genitori tra le tante
auto accatastate e impolverate, e come in Crash
l’auto assurge a simulacro di un corpo, in questo caso quello
dei genitori, dei cui volti Jim non ricorda più i dettagli e
che ritornano nella sua memoria attraverso una sorta di proiezione
freudiana. Ma Jim si rende presto conto che lo stadio è un
microcosmo irreale, una grande tomba dell’imperialismo
occidentale in Cina dove non a caso si lasciano morire buona parte
degli inglesi scampati da Lunghua. La morte, ancora una volta, aleggia
tra “ruote da roulette, carrelli da bar e ninfe in gesso
dorato con lampade dai colori sgargianti sopra il capo…
rotoli di tappeti persiani e turchi frettolosamente avvolti in teli
incerati” (Ballard, 2006a, p. 267 ). Tra questi
“miseri trofei”, come li giudica giustamente Jim,
ben presto trovano la morte più di un centinaio di
prigionieri, facendo dello stadio un enorme tomba. Ed è
proprio su questa tomba, a suggellare l’irruzione della
morte, che si staglia improvvisa la luce della bomba di Nagasaki che
illumina in modo spettrale e persistente lo stadio, nonostante le
centinaia di miglia che separano la costa cinese dal luogo
dell’ecatombe. Simbolicamente, la luce della bomba unisce i
giapponesi e gli inglesi nello stadio olimpico, stendendo su entrambi
un velo di morte. I due mondi che hanno accompagnato la vita di Jim
fino ad allora scompaiono in questo momento catartico del romanzo e del
film. È la fine dell’Impero del Sole. Lo stadio è diventato
durante la guerra la centrale operativa dell’esercito
giapponese di stanza nella Cina meridionale, e quando Jim e gli
internati di Lunghua vi arrivano nel corso della loro estenuante marcia
verso Nantao trovano ad accoglierli le ombre della loro vita
precedente. Nell’enorme stadio sono stati stipati dai
giapponesi tutti i mobili pregiati, le auto americane, i tappeti
persiani e le statue di marmo appartenenti agli occidentali della
Concessione, e sottratti durante il sacco di Shanghai successivo allo
scoppio della guerra. Jim ritrova la Packard dei genitori tra le tante
auto accatastate e impolverate, e come in Crash
l’auto assurge a simulacro di un corpo, in questo caso quello
dei genitori, dei cui volti Jim non ricorda più i dettagli e
che ritornano nella sua memoria attraverso una sorta di proiezione
freudiana. Ma Jim si rende presto conto che lo stadio è un
microcosmo irreale, una grande tomba dell’imperialismo
occidentale in Cina dove non a caso si lasciano morire buona parte
degli inglesi scampati da Lunghua. La morte, ancora una volta, aleggia
tra “ruote da roulette, carrelli da bar e ninfe in gesso
dorato con lampade dai colori sgargianti sopra il capo…
rotoli di tappeti persiani e turchi frettolosamente avvolti in teli
incerati” (Ballard, 2006a, p. 267 ). Tra questi
“miseri trofei”, come li giudica giustamente Jim,
ben presto trovano la morte più di un centinaio di
prigionieri, facendo dello stadio un enorme tomba. Ed è
proprio su questa tomba, a suggellare l’irruzione della
morte, che si staglia improvvisa la luce della bomba di Nagasaki che
illumina in modo spettrale e persistente lo stadio, nonostante le
centinaia di miglia che separano la costa cinese dal luogo
dell’ecatombe. Simbolicamente, la luce della bomba unisce i
giapponesi e gli inglesi nello stadio olimpico, stendendo su entrambi
un velo di morte. I due mondi che hanno accompagnato la vita di Jim
fino ad allora scompaiono in questo momento catartico del romanzo e del
film. È la fine dell’Impero del Sole.
La luce della bomba atomica riflessa sullo stadio
di Nantao sembra quasi alludere, inoltre, a una sorta di esperienza
onirica. La scelta di Ballard per la novellizzazione della sua
esperienza autobiografica si potrebbe leggere anche in questa chiave;
in più riprese, Ballard sostenne che le vicende di Shanghai
e del campo di Lunghua gli sembrassero appartenere a una specie di
sogno. I “vent’anni per dimenticare” e
gli altrettanti “vent’anni per ricordare”
sarebbero stati perciò necessari affinché
esperienze reali ed esperienze immaginate si fondessero in un intreccio
inestricabile, l’intreccio di un romanzo. Solo negli ultimi,
con l’approssimarsi della certezza della morte, Ballard ha
avuto il coraggio di uscire per una volta dalla finzione dei suoi
romanzi - tutti, più o meno, autobiografici - per scrivere I
miracoli della vita, la vera autobiografia non romanzata dove
l’esperienza di Shanghai è stata per la prima
volta esposta nella sua realtà. Eppure, anche qui il lettore
non riesce a liberarsi dal dubbio che Ballard sia giunto a fondersi con
le sue stesse opere, facendo della sua stessa vita l’oggetto
di una grande e surreale fiction. Dopo la visione del film di
Spielberg, in un articolo Ballard raccontò,
“Christian Bale e John Malkovic [i due attori protagonisti]
sembrano prendere per mano i miei veri genitori e il me stesso
più giovane davanti alle luci della ribalta”
(Ballard, 2006b), come se tutto fosse divenuto (o fosse tornato ad
essere) solo uno spettacolo: “Ma forse, alla fine,
è stato tutto solo un film”, concludeva.
|

