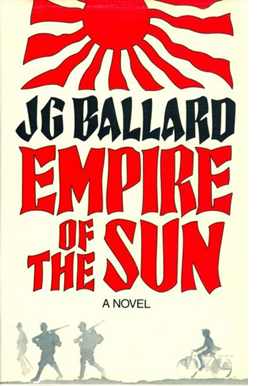|
La
narrativa ballardiana, del resto, è sempre stata dominata
dal tema del “microcosmo”: luoghi reali distorti al
punto da diventare veri e propri universi alieni in cui prendono vita
tutte le follie della civiltà contemporanea. A partire dai
racconti di Vermillion Sands passando per
l’isola spartitraffico di Concrete Island
(1974), il gigantesco palazzone di Condominium
(1975), il villaggio residenziale di Un gioco da bambini
(1988), il complesso turistico spagnolo di Cocaine Nights
(1996) e quello sulla Costa Azzurra di Super-Cannes (2000),
lo spazio interiore esplorato da Ballard trova nello spazio esteriore
del microcosmo il laboratorio più adatto per ardite
sperimentazioni. Ne L’impero del sole si
possono individuare ben tre microcosmi attraverso i quali si dipana la
vicenda di Jim e la tragedia della guerra: la Shanghai decadente alla
vigilia di Pearl Harbour, il campo di concentramento di Lunghua
(“universo concentrazionario” nel senso reale del
termine) e lo stadio olimpico che è forse la più
surreale tra le tappe della fuga di Jim verso Shanghai.
La
Shanghai vista attraverso gli occhi di Jim assume i contorni di
“un cinegiornale di cui la sua mente era il
proiettore” (Ballard, 2006a, p. 11), un affastellamento di
immagini senza senso o – come la descriverà il
James Ballard maturo – “un presagio delle
città mediatiche del futuro, dominate da
pubblicità e giornali di diffusione di massa”
(Ballard, 2006b). La festa in costume degli europei nei sobborghi
occidentali della città sembra quasi un tentativo di
esorcizzare la paura della guerra rifugiandosi nelle fantasticherie
più sfrenate, al punto che – nota Jim –
“Shanghai sembrava diventata una città di
pagliacci”. La ricostruzione del film, dove una teoria di
clown, sultani e Marie Antoniette sfila tra centinaia di cinesi
disperati in comode Rolls-Royce e Packard, rende perfettamente questo
stridente contrasto. È il tema che ritroveremo nelle opere
più tarde di Ballard, dove la civiltà ricca e
gaudente dell’alta borghesia ricorre alle soluzioni
più estreme (sesso, droga, omicidio) per rifuggire la
mediocrità della routine. Chi appare fuori posto
paradossalmente è proprio Jim, che pur con la mente piena di
fantasticherie tipica di un ragazzino prende contatto con la guerra
prima degli adulti, inoltrandosi nell’aerodromo abbandonato
dove s’imbatte in una colonna di giapponesi pronta
all’azione. È la guerra vera, non quella sempre
fittizia e virtuale di cui parlano gli adulti, tra i cui campi di
battaglia pieni di detriti appositamente sistemati addirittura
passeggiano le “signore in abiti di seta” e i loro
“mariti in vestito grigio” (Ballard, 2006a, p. 28).
Quando la guerra scoppia davvero, il lusso e l’opulenza che
tanto hanno abbagliato il giovane Jim si rivelano mere illusioni. Nelle
grandi ville abbandonate in cui vaga in cerca di cibo, Jim rischia
quasi di morire di fame: un terribile paradosso dato che nelle ville
“lussureggianti” (come le definisce Jim) abbondano
il whisky, il gin e le curiosità più strambe,
come una collezione di denti e un cinema privato. Vuoti simulacri, come
la piscina ormai asciutta in cui Jim ritrova alcuni oggetti che aveva
perso, le ville degli occidentali sono microcosmi nel microcosmo di
Shanghai, dove i giradischi tornano a suonare solo per far ballare i
giapponesi che hanno fatto delle case le loro basi operative.
|