 |
|
|
|
|
|
Più in particolare, da un’analisi del quotidiano nazionale Repubblica, che ha interessato il periodo dal 30.01.2002 al 30.06.2003, risulta che nell’intero anno 2002, soprattutto nel primo semestre, sono stati pubblicati articoli tutti i giorni con un picco di più di un articolo al giorno nei mesi “caldi” (febbraio, ossia quando le indagini andavano sempre più stringendosi intorno all’ambito familiare e marzo, per l’arresto e il successivo rilascio della madre della piccola vittima). Lo stesso vale per i telegiornali (Tg1, Tg2, Tg3), che vi hanno dedicato servizi tutti i giorni e in tutte le loro edizioni nei mesi successivi all’accaduto.
Probabilmente, al “successo” della “storia” ha contribuito molto l’efferatezza del delitto e il suo presunto svolgimento nel contesto familiare; ma c’era anche il caso umano di una madre, unica indagata che nega di esserne l’autrice, e il carattere meramente ipotetico delle ricostruzioni, che dilatavano all’infinito le speculazioni sulla vicenda. Se dunque, nel complesso, si ha l’impressione di una copertura televisiva squilibrata ed eccessiva dell’omicidio di Samuele Lorenzi, ciò non è da ascriversi all’eventuale incapacità professionale nella restituzione dell’evento o a singole “cadute di stile” di questo o quel servizio, ma è attribuibile “a monte”, alla stessa scelta di inanellare quotidianamente la narrazione con nuove puntate evanescenti, fatte di nulla, giacché nulla di nuovo era accaduto. Si è di fronte a un caso, molto comune, di non-notizia, che giornalisticamente è un fatto che non contiene nulla di nuovo, utilizzata in genere per tenere in piedi una vicenda che potrebbe avere improvvisamente sviluppi clamorosi, in modo da non allentare l’attenzione del pubblico.
Il “difetto” nel riportare il delitto di Cogne va allora
ricondotto al fatto di averne fatto una narrazione È bene precisare che generalmente si tratta di caratteristiche tipiche degli articoli di cronaca, in modo particolare della cronaca nera. Ossia un articolo, proprio come un racconto, può essere analizzato come una storia, con certi personaggi che hanno certi ruoli e compiono certe azioni, con un inizio, uno svolgimento e (quasi sempre) una conclusione. E la narrativizzazione ha un’evidente funzione spettacolarizzante, vivacizza la notizia, spesso serve ad evidenziare i fattori emotivi e umani. Ciò non avviene solo nei giornali popolari, ma anche nei quotidiani più diffusi, nei quali l’andamento narrativo tende anche a costruire un ideale percorso di lettura che non caratterizza più solo il singolo articolo, ma addirittura si configura come un racconto a puntate.
|
|
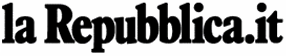
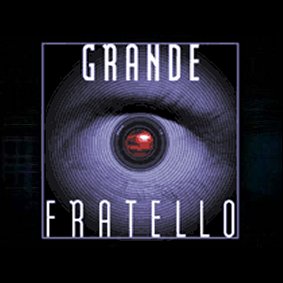 continua, che non poteva essere interrotta, di aver trasformato un fatto di
cronaca, pur terribile e sconvolgente, nell’evento televisivo dell’anno. Ed è
proprio questa narrazione continua, trattata il più delle volte con espedienti
narrativi che sottolineano la dimensione del racconto così come quella
della fiction articolata in più puntate, spesso e volentieri
ripetitive e inutili, che fa pensare al delitto di Cogne come ad un
reality show o ad una fiction a puntate.
continua, che non poteva essere interrotta, di aver trasformato un fatto di
cronaca, pur terribile e sconvolgente, nell’evento televisivo dell’anno. Ed è
proprio questa narrazione continua, trattata il più delle volte con espedienti
narrativi che sottolineano la dimensione del racconto così come quella
della fiction articolata in più puntate, spesso e volentieri
ripetitive e inutili, che fa pensare al delitto di Cogne come ad un
reality show o ad una fiction a puntate.