
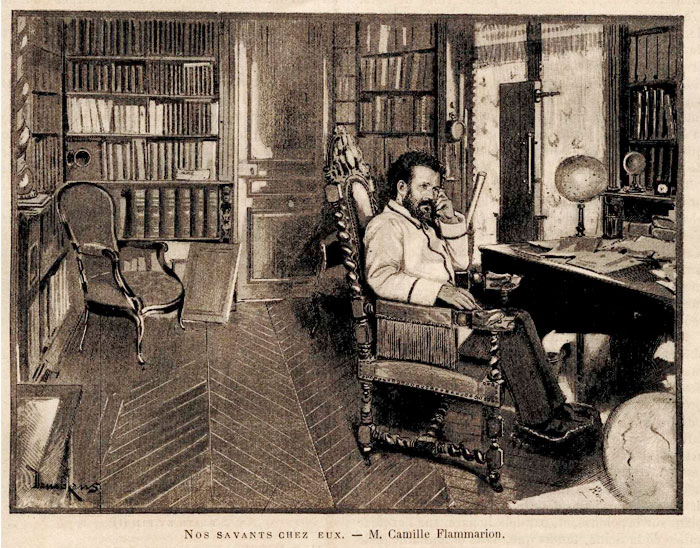
Il discorso sulla Luna sviluppato in Les mondes imaginaires
et les mondes réels
è tuttavia soprattutto un modo di riportare il lettore dai
deserti
seleniti sulla sua terra stessa, e di fargli osservare il suo mondo
alla luce riflessa del suo satellite. Flammarion riprende per
illustrare il suo proposito la divisione proposta da Giovanni Keplero
nella sua Astronomia lunaris, dove
“chiama Sub-volves, sotto la Terra, i
Seleniti che abitano questa parte della Luna, mentre chiama Privolves,
privati della Terra, quelli che abitano l’altra parte. Queste
denominazioni vengono dal nome Volva (Colei
che gira), nome che i Seleniti, sempre secondo questo
astronomo, danno alla Terra” (ibidem,
pag. 13). È nel loro rapporto con la Terra che Flammarion
esamina i due
emisferi lunari, giudicando che i Sub-volves beneficiano della vista
maestosa del nostro pianeta, suscettibile di ispirare loro pensieri
elevati e di spingerli alla contemplazione, mentre i Privolves
che risiedono sul lato perennemente oscuro devono aver ricorso ad altri
stratagemmi, e “forse, sotto la loro atmosfera sconosciuta,
hanno dei
soli artificiali che accendono per la metà
dell’anno” (ibidem,
pag. 29). A partire dalle osservazioni astronomiche, e dalla posizione
della Luna rispetto alla Terra, Flammarion si lascia tentare dal
desiderio di prevedere quali possano essere i rapporti tra gli abitanti
dei due opposti emisferi lunari, e conclude per l’esistenza
di “una
distinzione fondamentale nella nazionalità dei Seleniti.
Quelli che
abitano l’emisfero privilegiato [quello dal quale si vede la
Terra]
sarebbero i nobili; ai loro antipodi risiederebbero i
villani”. Egli
s’immagina che la vista del nostro pianeta, coi suoi
brillanti colori,
attirerebbe le popolazioni del lato oscuro desiderose di vedere almeno
una volta nella loro vita lo spettacolo che è loro negato.
Ma se la
divisione geografica dovesse effettivamente corrispondere a una
separazione sociale, prevede che “forse i pellegrinaggi alla
Terra
avrebbero un valore ancora ben più grande, e potrebbero
anche essere
proibiti ai plebei”, aggiungendo tuttavia prudentemente:
“Di questo
preferiamo non discutere” (ibidem, pag.
23). Questo
trasferimento nello spazio dei conflitti sociali terrestri serve
all’autore per ricordare ai suoi lettori come, vista dalla
Luna, la
Francia appaia “quasi invisibile”, (ibidem,
pag. 18) e per
supporre che “i Seleniti che contemplano tranquillamente
durante le
notti silenziose gli squarci verdi e grigi della Terra, non sospettano
minimamente le battaglie che oppongono tra loro quelle
nazionalità
lontane” (ibidem, pag. 19).
 Lo spiritismo che l’autore
sottoscriveva aveva in effetti un lato progressista molto marcato. Il
socialismo romantico di Fourier e di Pierre Leroux prevedeva
già certi
elementi dottrinali poi recuperati dallo spiritismo fin-de-siècle
e adottati per l’essenziale anche da Flammarion. Al
disfacimento
sociale causato dall’industrializzazione e dalla
società borghese
dominata dall’egoismo, questo proto-socialismo pre-marxiano
opponeva
l’idea di un’unione totale
dell’umanità al di sopra delle classi, che
trovava la sua espressione più alta nella teoria della
reincarnazione
delle anime. Questa visione, metafisica ma non prettamente religiosa,
aveva il vantaggio di emarginare il Cristianesimo –
considerato il
braccio spirituale della repressione borghese – per proporre
l’idea di
uno sviluppo armonioso degli spiriti di vita in vita,
all’interno di
una spirale eternamente ascendente. Jean Reynaud fu probabilmente il
primo, in questo contesto, a rappresentare nel suo libro Terre
et ciel
(1854) l’idea di una catena continua di reincarnazioni dove
gli animi
passavano da un pianeta all’altro e di vita in vita, in una
progressione inarrestabile verso la perfezione (cfr. Weber, 2007). Il
concetto di pluralità dei mondi abitati sviluppato da
Flammarion si
prestava a meraviglia ad un tentativo di collegare logicamente il
progresso materiale e il progresso spirituale, arrivando per finire ad
identificare le forme di vita extraterrestri con le nuove incarnazioni
di esistenze terrestri passate. In uno dei sue tre romanzi a tema
fantascientifico, Stella (1897), l’autore
identifica
nell’elettricità la sostanza autentica
dell’anima e la forza che
permette la comunicazione tra gli spiriti, dipingendo il ritratto di un
universo dove fluidi imponderabili in perenne stato di transizione
collegano tra loro pianeti, soli e satelliti (Finn, 2007). In questo
contesto dotato di una sua logica interna ineccepibile, dove spirito e
materia superano la loro antichissima opposizione per ritrovarsi in una
“sintesi di tutti i saperi” (ibidem),
la Luna di Camille
Flammarion, da pallido, inutile e deserto satellite della Terra,
diventa il primo gradino su di una scala che porterà le
anime umane
alle soglie della perfezione. Lo spiritismo che l’autore
sottoscriveva aveva in effetti un lato progressista molto marcato. Il
socialismo romantico di Fourier e di Pierre Leroux prevedeva
già certi
elementi dottrinali poi recuperati dallo spiritismo fin-de-siècle
e adottati per l’essenziale anche da Flammarion. Al
disfacimento
sociale causato dall’industrializzazione e dalla
società borghese
dominata dall’egoismo, questo proto-socialismo pre-marxiano
opponeva
l’idea di un’unione totale
dell’umanità al di sopra delle classi, che
trovava la sua espressione più alta nella teoria della
reincarnazione
delle anime. Questa visione, metafisica ma non prettamente religiosa,
aveva il vantaggio di emarginare il Cristianesimo –
considerato il
braccio spirituale della repressione borghese – per proporre
l’idea di
uno sviluppo armonioso degli spiriti di vita in vita,
all’interno di
una spirale eternamente ascendente. Jean Reynaud fu probabilmente il
primo, in questo contesto, a rappresentare nel suo libro Terre
et ciel
(1854) l’idea di una catena continua di reincarnazioni dove
gli animi
passavano da un pianeta all’altro e di vita in vita, in una
progressione inarrestabile verso la perfezione (cfr. Weber, 2007). Il
concetto di pluralità dei mondi abitati sviluppato da
Flammarion si
prestava a meraviglia ad un tentativo di collegare logicamente il
progresso materiale e il progresso spirituale, arrivando per finire ad
identificare le forme di vita extraterrestri con le nuove incarnazioni
di esistenze terrestri passate. In uno dei sue tre romanzi a tema
fantascientifico, Stella (1897), l’autore
identifica
nell’elettricità la sostanza autentica
dell’anima e la forza che
permette la comunicazione tra gli spiriti, dipingendo il ritratto di un
universo dove fluidi imponderabili in perenne stato di transizione
collegano tra loro pianeti, soli e satelliti (Finn, 2007). In questo
contesto dotato di una sua logica interna ineccepibile, dove spirito e
materia superano la loro antichissima opposizione per ritrovarsi in una
“sintesi di tutti i saperi” (ibidem),
la Luna di Camille
Flammarion, da pallido, inutile e deserto satellite della Terra,
diventa il primo gradino su di una scala che porterà le
anime umane
alle soglie della perfezione.
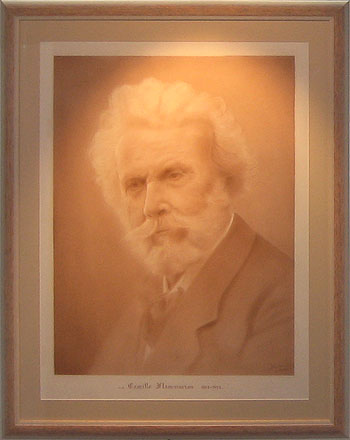 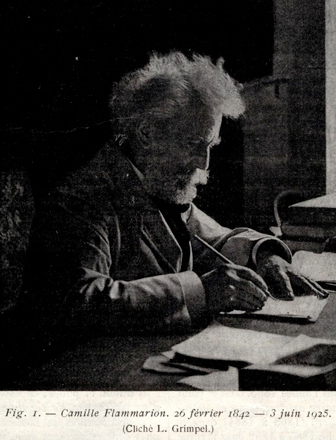
|