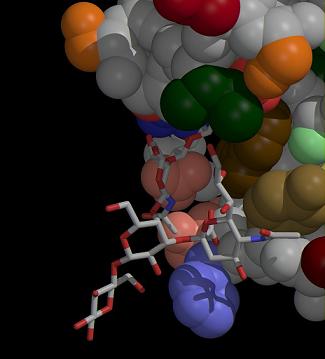 La
diade bioetica e futuro si può declinare nel segno degli irenici scenari di una
tecnologia che libera l’uomo dalle catene della necessità? O in quelli
apocalittici di una umanità asservita alle sue produzioni materiali?
La
diade bioetica e futuro si può declinare nel segno degli irenici scenari di una
tecnologia che libera l’uomo dalle catene della necessità? O in quelli
apocalittici di una umanità asservita alle sue produzioni materiali?
L’umanità che discute del
futuro anzitutto dovrebbe chiederci se ci sarà… Lo ha detto Hans Jonas che
proponeva di uscire dall’appiattimento sul presente dell’interrogazione etica
classica proiettando la domanda bioetica sulle generazioni future… Nel 1979 il
filosofo ebreo-tedesco proponeva l’idea che l’unica massima veramente
universalizzabile è quella che assume come principio ispiratore la conservazione
della vita umana così come la conosciamo.
Dopo trent’anni uno degli
aspetti più paradossali del dibattito bioetico è che, accomunati nell’ansia per
il futuro, ritroviamo il mirmecologo che ha segnato i nostri manuali di
sociologia con l’ipotesi neopositivista di una etica determinata in maniera
preponderante dai fattori ereditari, e il maestro francofortese che ci ha
insegnato la dialettica tra pluralità legittima dei mondi di vita e
l’universalità normativa dei principi morali. Edward Wilson e Jürgen Habermas
(oltre ad essere nati ad otto giorni di distanza nel giugno del 1929) hanno
dedicato due lavori recenti l’uno al Futuro della Vita (Codice Edizioni –
Torino 2002), l’altro al Futuro della Natura Umana (Einaudi – Torino
2002) che, a partire da differenti prospettive e metodologie di indagine,
pervengono a un monito analogo: l’umanità deve decidersi per se stessa, prima
che sia troppo tardi!
“Possiamo considerare l’autotrasformazione
genetica della specie come un mezzo per accrescere l’autonomia individuale,
oppure questa strada metterà a repentaglio l’autocomprensione normativa di
persone che conducono la vita portandosi mutuo ed eguale rispetto?”.
La questione così come la
ha impostata Jürgen Habermas è relativamente semplice: nel diffondersi
progressivo di tecnologie che intervengono, prima della nascita ed in maniera
irreversibile, sui fattori ereditari, si cela un modello d’azione che sottrae
l’uomo alla dimensione costitutivamente intersoggettiva dell’agire e, come nei
modelli eugenetici, lo destina ad un mondo dove la libertà individuale
non è più pensabile.
Diventa allora
fondamentale individuare gli eventuali passi già compiuti lungo questa strada ed
individuare gli eventuali percorsi alternativi per prevenire questa uscita
dell’umanità da se stessa. La posizione di Habermas è riconducibile alla retorica tecnofoba che soffoca il dibattito
bioetico quando questo prova ad uscire dalla ristretta cerchia degli addetti ai
lavori e a incontrare i reali destinatari della rivoluzione biotecnologica, cioè
noi tutti?
Habermas è riconducibile alla retorica tecnofoba che soffoca il dibattito
bioetico quando questo prova ad uscire dalla ristretta cerchia degli addetti ai
lavori e a incontrare i reali destinatari della rivoluzione biotecnologica, cioè
noi tutti?
Senza difficoltà possiamo
rispondere di no perché come tutti i grandi testi questo lavoro di Habermas
insegna a pensare, insegna a impostare i problemi, insegna a interrogarsi.“Un
uomo geneticamente programmato deve vivere nella consapevolezza che il suo
patrimonio ereditario - nell’intento di modificare la struttura del suo
fenotipo - è stato fatto oggetto di manipolazione. Prima di poter esprimere
giudizi normativi su questa situazione di fatto, dobbiamo cercare di capire
quali criteri potrebbero essere compromessi da questa
strumentalizzazione…siccome l’integrità dei singoli individui viene anzitutto a
dipendere dalla modalità rispettosa con cui essi si mettono reciprocamente in
rapporto.” (Habermas 2002, p. 56).

