- di Fausto Vernazzani
- SOMMARIO

 Nihon e no kaiki è il 1938 visto
da Hagiwara Sakutarō, è il suo Ritorno al Giappone,
un poema incasellato nella modernità del Sol Levante, sparso
nel continente asiatico in una cruenta invasione della Cina e prossimo
al farsi strada a suon di bombardamenti nel secondo conflitto mondiale.
Il ritorno al Giappone è un’idea tipicamente
moderna, il lamento di uno scrittore e dei suoi intellettuali
contemporanei schierato contro il processo di occidentalizzazione
avviato dalla restaurazione dell’era Meiji, colpevole di aver
tolto al Giappone proprio ciò che lo rendeva, appunto,
Giappone, con la sua inamovibile storia millenaria. L’idea
stessa di uno stato nipponico scomparso nell’approssimarsi
della piena globalizzazione è nata dalle incredibili
comodità importate dall’Ovest. Con la schiena
poggiata sui cuscini di un divano europeo si è formata una
tradizione filtrata con occhi diversi da quelli di chi quello stato lo
visse prima dell’apertura forzata imposta
dall’Ammiraglio Perry nel 1853. Il “ritorno al
Giappone” fu un tratto che accomunò vari
scrittori, non tutti disposti come Jun’ichiro Tanizaki (1886
– 1965) a riconoscere, ma non per forza accettare, la ferma
presenza della cultura Occidentale, statunitense più di
altre, nel Giappone del XX secolo. Dall’alto del presente
guardare questo specifico aspetto del passato rende ancor
più curiosa la lettura di Norwegian Wood
di Haruki Murakami, pubblicato in patria nel 1987 e arrivato in Italia
solo nel 1993 col titolo Tokyo Blues, prima di
essere riassestato nei suoi caratteri originali nella nuova edizione
Einaudi. Murakami scrive un romanzo che rispecchia
l’Occidente letterario e anziché abbracciare la
propria fascinazione per l’Europa e gli Stati Uniti la fa sua
con sottigliezza. Citandola a gran voce ne prende gli schemi e con un
calcolo elegante dà come risultato un’opera
giovanile di pregevole fattura. La nostalgia è la chiave
d’apertura, Toru Watanabe è in viaggio in Europa
quando sente delle note a lui molto familiari, quelle dei Beatles e
della loro Norwegian Wood dall’album Rubber
Soul (1966), su cui si troverà a viaggiare per
tornare indietro nel tempo ai suoi giorni a Tokyo. Gli anni Ottanta
cedono il passo ai Sessanta della contestazione studentesca, successiva
all’evento che cambiò per sempre la sua vita: la
morte di Kizuki, l’amico dell’infanzia, con cui
aveva saldato un sottinteso patto per un futuro in compagnia, insieme
alla sua fidanzata, Naoko. Una felicità e un futuro
sottratti per il suo improvviso suicidio. Sfuggire al vuoto per lui
è possibile allontanandosi dalla sua città e
facendosi accogliere da Tokyo, un college qualsiasi, non importa la
qualità né la materia di studio, quanto basta
sono i libri in cui affondare e un’esistenza diretta verso il
futuro per semplice inerzia. A interrompere il passaggio è
l’amore, la riscoperta di un rapporto nuovo con Naoko,
ragazza frantumata dal suicidio di Kizuki in ritiro
spirituale in montagna, e Midori, giovane indipendente e collega di
studi di Watanabe; tra le due divide la sua storia, con
sincerità per entrambe e scarsità di sogni da
raccontare. Mai senza un libro tra le mani o nei pensieri. Toru
Watanabe è Il giovane Holden, il libro e
non solo il protagonista, è l’incarnazione delle
pagine di Jerome D. Salinger e allo stesso tempo il Nick Carraway de Il
grande Gatsby, l’uomo che condivide
l’intimità timida tra due persone
finché una di queste non è strappata a questa
terra. È in viaggio verso La montagna incantata
di Thomas Mann, lassù dove Naoko cerca in qualche modo di
ricucire la propria mente. Norwegian Wood
è un mosaico letterario posto sullo sfondo di un Giappone
che da poco ha superato gli anni raccontati da Nagisa Ōshima col
classico Racconto crudele della giovinezza (1960).
È pura passione messa in scena. Il fine lavoro di Murakami
è parte di un largo intreccio, una lettura collegata alla
propria educazione che rende il mondo personale
come scrisse Cormac McCarthy in The Sunset Limited
(2008). La vita di Watanabe è il riflesso della sua
educazione. Di qui la grande difficoltà: come trasferire un
lavoro così personale, come del resto ogni opera letteraria
degna di questo nome, in un’opera cinematografica che ne sia
adattamento? Per molti anni Murakami si è rifiutato di far
avvicinare chicchessia ai suoi lavori, finché Tony
Takitani non fu ceduto e trasposto sul grande schermo e un
promettente regista vietnamita si è affacciato alla sua
porta. Tran Anh Hung si offrì per potersi sedere sulla
spalla del gigante Murakami, con un curriculum fatto di allori raccolti
nei maggiori festival europei: il suo esordio Il profumo
della papaya verde vinse la Camera d’Or al Festival
di Cannes, il successivo Cyclo fece suo il Leone
d’Oro alla Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia, il quarto gli riempì il set di star internazionali
e panasiatiche come Josh Hartnett, Elias Koteas, Shawn Yue e Lee
Byung-hun. Sulla carta Tran Anh Hung era destinato al successo e forse
grazie a questo sopportò con facilità le ritrosie
dei giapponesi a cui un regista vietnamita non andava giù.
Nihon e no kaiki, ancora lui, resuscita sulla bocca del
pubblico a cui interessa vedere un giapponese trasporre sul grande
schermo un loro classico contemporaneo, un po’ come negli
Stati Uniti si levò subito un gran chiasso non appena la
prominente mascella di Kurt Russell fu oscurata all’idea che
l’inglese Tom Hardy potesse prendere il ruolo di Snake
Plissken nel remake di 1997: Fuga da New York.
Adattare è un lavoro a cui si giunge da autori e spettatori
attraverso un bivio: soddisfare le aspettative e i desideri del
pubblico o tentare la più impervia via lastricata dal
proprio mondo personale. Il solito dilemma. Fedeltà alla
linea oppure sperare di poter arrivare in cima alle spalle del gigante
non da nano come vorrebbe la citazione in una delle sue tante
sfumature, ma da gigante a sua volta. Il rischio fa parte di entrambi,
la storia del cinema ha visto dalle poltroncine miriadi di fallimenti e
tonnellate di successi. Tran Anh Hung con Norwegian Wood
ha optato all’apparenza per la fedeltà: seguire
pedissequamente la narrazione scritta di Murakami e trasformarla in
immagini, scegliendo di rinunciare però ai tratti esteriori
che sulla carta caratterizzano i personaggi e la storia, rendendo la
fedeltà uno sbiadito atto d’amore. Spaccando il
film in mille pezzi per cercare una scena fedele fin nel midollo
è un’impresa degna di Noè. Esistono
frammenti identici, come l’interruzione della lezione sulle
tragedie greche, ma talmente piccoli da essere irrilevanti. Sono
immagini svuotate, volti umani privi di connotati definiti, solo ombre
delle pagine di Murakami, personaggi estratti e gettati in luoghi
decontestualizzati: il periodo storico, la natura stessa del ricordo
sono annullati in favore di luoghi che non siano altro che la cornice
della loro attività mentale. Chiusi tra quattro mura oppure
tra i quattro lati dello schermo quando sguinzagliati negli spazi
aperti.
Nihon e no kaiki è il 1938 visto
da Hagiwara Sakutarō, è il suo Ritorno al Giappone,
un poema incasellato nella modernità del Sol Levante, sparso
nel continente asiatico in una cruenta invasione della Cina e prossimo
al farsi strada a suon di bombardamenti nel secondo conflitto mondiale.
Il ritorno al Giappone è un’idea tipicamente
moderna, il lamento di uno scrittore e dei suoi intellettuali
contemporanei schierato contro il processo di occidentalizzazione
avviato dalla restaurazione dell’era Meiji, colpevole di aver
tolto al Giappone proprio ciò che lo rendeva, appunto,
Giappone, con la sua inamovibile storia millenaria. L’idea
stessa di uno stato nipponico scomparso nell’approssimarsi
della piena globalizzazione è nata dalle incredibili
comodità importate dall’Ovest. Con la schiena
poggiata sui cuscini di un divano europeo si è formata una
tradizione filtrata con occhi diversi da quelli di chi quello stato lo
visse prima dell’apertura forzata imposta
dall’Ammiraglio Perry nel 1853. Il “ritorno al
Giappone” fu un tratto che accomunò vari
scrittori, non tutti disposti come Jun’ichiro Tanizaki (1886
– 1965) a riconoscere, ma non per forza accettare, la ferma
presenza della cultura Occidentale, statunitense più di
altre, nel Giappone del XX secolo. Dall’alto del presente
guardare questo specifico aspetto del passato rende ancor
più curiosa la lettura di Norwegian Wood
di Haruki Murakami, pubblicato in patria nel 1987 e arrivato in Italia
solo nel 1993 col titolo Tokyo Blues, prima di
essere riassestato nei suoi caratteri originali nella nuova edizione
Einaudi. Murakami scrive un romanzo che rispecchia
l’Occidente letterario e anziché abbracciare la
propria fascinazione per l’Europa e gli Stati Uniti la fa sua
con sottigliezza. Citandola a gran voce ne prende gli schemi e con un
calcolo elegante dà come risultato un’opera
giovanile di pregevole fattura. La nostalgia è la chiave
d’apertura, Toru Watanabe è in viaggio in Europa
quando sente delle note a lui molto familiari, quelle dei Beatles e
della loro Norwegian Wood dall’album Rubber
Soul (1966), su cui si troverà a viaggiare per
tornare indietro nel tempo ai suoi giorni a Tokyo. Gli anni Ottanta
cedono il passo ai Sessanta della contestazione studentesca, successiva
all’evento che cambiò per sempre la sua vita: la
morte di Kizuki, l’amico dell’infanzia, con cui
aveva saldato un sottinteso patto per un futuro in compagnia, insieme
alla sua fidanzata, Naoko. Una felicità e un futuro
sottratti per il suo improvviso suicidio. Sfuggire al vuoto per lui
è possibile allontanandosi dalla sua città e
facendosi accogliere da Tokyo, un college qualsiasi, non importa la
qualità né la materia di studio, quanto basta
sono i libri in cui affondare e un’esistenza diretta verso il
futuro per semplice inerzia. A interrompere il passaggio è
l’amore, la riscoperta di un rapporto nuovo con Naoko,
ragazza frantumata dal suicidio di Kizuki in ritiro
spirituale in montagna, e Midori, giovane indipendente e collega di
studi di Watanabe; tra le due divide la sua storia, con
sincerità per entrambe e scarsità di sogni da
raccontare. Mai senza un libro tra le mani o nei pensieri. Toru
Watanabe è Il giovane Holden, il libro e
non solo il protagonista, è l’incarnazione delle
pagine di Jerome D. Salinger e allo stesso tempo il Nick Carraway de Il
grande Gatsby, l’uomo che condivide
l’intimità timida tra due persone
finché una di queste non è strappata a questa
terra. È in viaggio verso La montagna incantata
di Thomas Mann, lassù dove Naoko cerca in qualche modo di
ricucire la propria mente. Norwegian Wood
è un mosaico letterario posto sullo sfondo di un Giappone
che da poco ha superato gli anni raccontati da Nagisa Ōshima col
classico Racconto crudele della giovinezza (1960).
È pura passione messa in scena. Il fine lavoro di Murakami
è parte di un largo intreccio, una lettura collegata alla
propria educazione che rende il mondo personale
come scrisse Cormac McCarthy in The Sunset Limited
(2008). La vita di Watanabe è il riflesso della sua
educazione. Di qui la grande difficoltà: come trasferire un
lavoro così personale, come del resto ogni opera letteraria
degna di questo nome, in un’opera cinematografica che ne sia
adattamento? Per molti anni Murakami si è rifiutato di far
avvicinare chicchessia ai suoi lavori, finché Tony
Takitani non fu ceduto e trasposto sul grande schermo e un
promettente regista vietnamita si è affacciato alla sua
porta. Tran Anh Hung si offrì per potersi sedere sulla
spalla del gigante Murakami, con un curriculum fatto di allori raccolti
nei maggiori festival europei: il suo esordio Il profumo
della papaya verde vinse la Camera d’Or al Festival
di Cannes, il successivo Cyclo fece suo il Leone
d’Oro alla Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia, il quarto gli riempì il set di star internazionali
e panasiatiche come Josh Hartnett, Elias Koteas, Shawn Yue e Lee
Byung-hun. Sulla carta Tran Anh Hung era destinato al successo e forse
grazie a questo sopportò con facilità le ritrosie
dei giapponesi a cui un regista vietnamita non andava giù.
Nihon e no kaiki, ancora lui, resuscita sulla bocca del
pubblico a cui interessa vedere un giapponese trasporre sul grande
schermo un loro classico contemporaneo, un po’ come negli
Stati Uniti si levò subito un gran chiasso non appena la
prominente mascella di Kurt Russell fu oscurata all’idea che
l’inglese Tom Hardy potesse prendere il ruolo di Snake
Plissken nel remake di 1997: Fuga da New York.
Adattare è un lavoro a cui si giunge da autori e spettatori
attraverso un bivio: soddisfare le aspettative e i desideri del
pubblico o tentare la più impervia via lastricata dal
proprio mondo personale. Il solito dilemma. Fedeltà alla
linea oppure sperare di poter arrivare in cima alle spalle del gigante
non da nano come vorrebbe la citazione in una delle sue tante
sfumature, ma da gigante a sua volta. Il rischio fa parte di entrambi,
la storia del cinema ha visto dalle poltroncine miriadi di fallimenti e
tonnellate di successi. Tran Anh Hung con Norwegian Wood
ha optato all’apparenza per la fedeltà: seguire
pedissequamente la narrazione scritta di Murakami e trasformarla in
immagini, scegliendo di rinunciare però ai tratti esteriori
che sulla carta caratterizzano i personaggi e la storia, rendendo la
fedeltà uno sbiadito atto d’amore. Spaccando il
film in mille pezzi per cercare una scena fedele fin nel midollo
è un’impresa degna di Noè. Esistono
frammenti identici, come l’interruzione della lezione sulle
tragedie greche, ma talmente piccoli da essere irrilevanti. Sono
immagini svuotate, volti umani privi di connotati definiti, solo ombre
delle pagine di Murakami, personaggi estratti e gettati in luoghi
decontestualizzati: il periodo storico, la natura stessa del ricordo
sono annullati in favore di luoghi che non siano altro che la cornice
della loro attività mentale. Chiusi tra quattro mura oppure
tra i quattro lati dello schermo quando sguinzagliati negli spazi
aperti.
Uno degli esempi più vicini al
concetto di fedeltà è l’equivalente del
seguente passaggio dal libro di Murakami:
“In quella vecchia casa solo la cucina sembrava da poco ristrutturata e tutto, dal lavandino ai rubinetti ai mobili, era nuovo e luccicante. Midori era lì occupata a preparare il pranzo. Qualcosa bolliva nella pentola gorgogliando, e si sentiva un odore di pesce arrosto”.
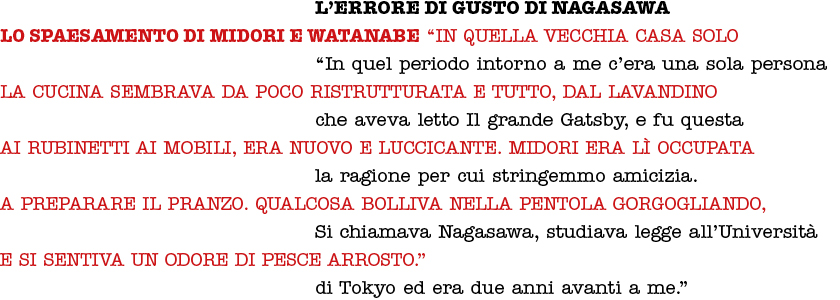
È il pranzo tra Midori e Watanabe, un lungo incontro sentimentale fatto di convenevoli, chiacchiere casuali e soprattutto uno scambio di vuoti: né Midori né Watanabe possono dire di avere una vita piena, entrambi con tragedie a pesare sul cuore, a schiacciare il futuro. Si parla della cucina del Kansai da cui Watanabe proviene e di come Midori, originaria della capitale nipponica, abbia imparato a dominare i fornelli, della fuga in Uruguay del padre di lei, di un’adolescenza passata a volte con lo stesso reggiseno per mesi pur di avere soldi per comprare le padelle giuste. I due ragazzi conversano, arrivano persino a cantare tra un sorso di birra e l’altro, sull’orlo del baratro: un incendio vicino l’abitazione di Midori sembra avvicinarsi, ma nessuno dei due ne è spaventato. Il Giappone è nel caos delle rivolte e loro rispondono col loro presente svuotato di senso. Tran Anh Hung cambia le carte in tavola, però lascia identico il menù servito nella casa di Midori: il tema delle loro discussioni non cambia, è ristretto per ovvie necessità derivate dal lavoro di adattamento, ma quando si tratta di dare voce all’esterno si zittisce. Poco è cambiato rispetto al romanzo se non nel loro rapporto con la società: non è più un incendio ad assediare a breve distanza l’edificio di Midori, non è sulla terrazza che cantano e bevono, bensì è di fronte a una balconata, invasa in conclusione da una forte pioggia. Al fuoco contrappone l’acqua, una forza della natura che alla distruzione del fuoco risponde con malinconia. Il regista opta per l’incrocio di sguardi, evita con forza di portare i suoi attori a relazionarsi con attività altre da loro, limitandone peraltro le potenzialità. Annulla il rapporto con i media, creando una versione cinematografica del romanzo dona allo schermo di destinazione lo status di medium incontrastato sia dall’interno che dall’esterno della storia. Le letture su cui Watanabe continua a concentrarsi sono meri oggetti scenici, occupano il profilmico per raccontare un singolo tratto del carattere del proprietario, non reagiscono con le mille sfumature con cui potrebbero descrivere il mondo: Watanabe legge perché chiuso in sé stesso.
Seguendo il filo del discorso una scena in particolare
è da considerarsi forse la più importante, la
manciata di secondi che davvero racconta le decisioni stilistiche di
Tran Anh Hung e sottolinea il grosso lavoro di sottrazione effettuato.
Così si presenta nel libro di Murakami l’incontro
tra Watanabe e il suo amico più stretto, sempre che
così si possa definire un rapporto basato sulla stima, senza
particolare affetto: “In quel periodo intorno a me
c’era una sola persona che aveva letto Il grande Gatsby, e fu
questa la ragione per cui stringemmo amicizia. Si chiamava Nagasawa,
studiava legge all’Università di Tokyo ed era due
anni avanti a me”. Nagasawa è agli antipodi
rispetto a Watanabe. È ambizioso, sognatore, desideroso di
costruirsi una posizione di potere da cui esercitare il suo volere con
regolarità. Persegue la strada delle relazioni
internazionali, sognando una posizione nel mondo della diplomazia, un
percorso difficile da afferrare che richiede un enorme sforzo da parte
degli studenti. La disciplina è fondamentale, gli errori
devono essere annullati. Ecco perché Nagasawa non legge
libro che non abbia almeno trent’anni di vita, avvicinarsi a
testi giovani può portare a commettere un “errore
di gusto”, come lui lo chiama, e a porsi in cattiva luce di
fronte ai superiori. Galeotto fu Francis Scott Fitzgerald e il suo Il
grande Gatsby, ammirato tanto da Watanabe quanto da Nagasawa,
avido lettore di grandi classici, da cui lui stesso nasce, come
dimostra la felice intuizione di Giorgio Amitrano, autore della
prefazione dell’edizione Einaudi. Nagasawa altri non
è se non lo Steerforth ammirato dal giovane David
Copperfield di Charles Dickens, un idolo all’occhio del
più giovane, un uomo di fascino e statura sociale, macchiato
da un animo viscido. L’attrazione palpabile nel romanzo di
Dickens sarà sostituita dal loro andare a caccia di ragazze
con cui condividere inutili notti in hotel degradanti. Il Norwegian
Wood filmico trasforma Nagasawa: il primo incontro
è su due poltroncine nella hall, sigarette tra le dita e
voce narrante a descriverlo, finché al secondo nelle stanze
di Watanabe il buon Nagasawa non scioglie la gloria presentandosi con
poche battute in cui la lettura è definita una perdita di
tempo. Frase accompagnata dal gesto della sua mano di sfogliare il
libro di Watanabe e subito dopo gettarlo nel cestino più
vicino. Niente Gatsby, Nagasawa al cinema non
commetterà mai alcun errore di gusto perché tutto
ciò che ora lo rappresenta è il suo incredibile
potere sulle donne. Tran Anh Hung condanna a morte il personaggio.
Watanabe è privato del mondo materiale, secondo il regista
vietnamita l’esistenza del suo protagonista è data
solo dal contatto fisico con l’unica persona con cui riesce a
sentirsi sé stesso, a riscoprire il futuro di un passato
uccisosi dentro un fetido garage.
Il sesso con Naoko, il sorriso di Midori, l’amore insomma
è l’unica linfa vitale del film, il resto assume
il ruolo di contorno, come se a farci compagnia dovesse essere solo una
voce fuori campo, una mente dotata di una memoria fin troppo selettiva
dedita ad accompagnarci solo là dove ha piacere di occupare
il suo tempo. Così un dialogo avvenuto per Murakami nella
stanza su nel ritiro di Naoko, con tanto di testimone nella fumatrice
Reiko, anche suonatrice della Norwegian Wood da cui
arriva il titolo, è scaraventato sui fili d’erba
al vento: dove niente e nessuno può interromperli, con i
confini imposti dalla macchina da presa a difenderli da ogni possibile
distrazione. Un’immagine stupenda che tradisce il talento di
Tran Anh Hung, l’unica forse in cui la presa di distanza
rende con efficacia uno dei momenti più forti e toccanti
dell’opera di Haruki Murakami.
L’autore de Il profumo della papaya verde
è insomma arrivato da esterno: né giapponese
né figlio degli Stati Uniti d’America. Nato a
Đà Nẵng, vissuto in Vietnam fino ai dodici anni, quando vide
Saigon cadere e chiudere la guerra che martoriò il suo paese
per lunghissimo tempo, ha presentato una visione per certi versi
apocalittica della riduzione necessaria per rendere un’opera
non universale, ma globale. Spoglia dei riferimenti che la collocano
nello spazio e nel tempo, identificata solo dalla lingua. Tran Anh Hung
in un certo senso ha cercato di essere fedele al messaggio di Murakami
dimenticando come alla mente debba corrispondere un corpo. Il suo Norwegian
Wood ne è privo, è appunto una voce
narrante senza immagini capaci di parlare da sé, in coro, se
non con poche brevi eccezioni.
ASCOLTI
— The Beatles, Rubber Soul, EMI, 2009
LETTURE
— Charles Dickens, David Copperfield, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2003.
— Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby, Mondadori, Milano, 2011.
— Cormac McCarthy, Sunset Limited, Einaudi, Torino, 2008.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood, Einaudi, Torino, 2013.
VISIONI
— Nagisa Ōshima, Cruel Story of Youth, Eureka, 2015 (home video).
— Trần Anh Hùng, Norwegian Wood, Soda Pictures, 2011 (home video).