- di Roberto Paura
- SOMMARIO
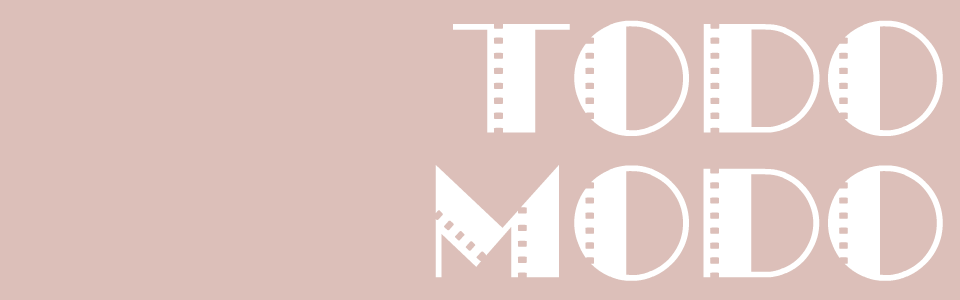
 Se si apre il dizionario del giornalista Stefano Grassi
dedicato al “caso Moro” (Il caso Moro. Un
dizionario italiano) – quasi ottocento pagine in
cui tutte le piste possibili relative a questo snodo decisivo della
storia della Repubblica sono seguite e analizzate con
l’ossessione sintomatica di un desiderio di impossibile
esaustività – si trova anche una voce dedicata a Todo
modo. La cosa può apparire bizzarra, ma in
realtà il film di Elio Petri tratto dal romanzo breve di
Leonardo Sciascia è legato a doppio filo al drammatico
destino del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: a lui
s’ispirò Gian Maria Volonté per calarsi
nei panni del Presidente, l’enigmatico ed evanescente
protagonista della pellicola, con una capacità imitativa
tale che si preferì buttar via la prima parte del girato
perché si temeva che altrimenti non avrebbe mai passato il
filtro della censura; e d’altro canto la scena con cui si
chiude il film, in cui il Presidente in ginocchio è freddato
da un colpo di pistola alla nuca, diventò due anni dopo
così spaventosamente profetica, in seguito alla scoperta del
cadavere di Moro ucciso proprio da diversi colpi di pistola, da rendere
– scrive Grassi – “di fatto
«invisibile» il film per molti anni”
(Grassi, 2008). Ma l’ombra di Moro seguì sia
Volonté che Sciascia: il primo tornò a
interpretare il personaggio, questa volta senza pseudonimi, nel film di
Giuseppe Ferrara Il caso Moro del 1986; il secondo,
in qualità di deputato dei Radicali, partecipò ai
lavori della Commissione Moro e nel 1978 pubblicò (quattro
anni dopo il suo Todo modo) L’affaire
Moro. La sua impressione era che “l’affaire
Moro fosse già scritto, che fosse già compiuta
opera letteraria, che vivesse ormai in una sua intoccabile
perfezione” (Sciascia, 1994). Si riferiva, con queste parole,
all’ineluttabilità del destino del presidente
della DC, ma anche al suo precedente romanzo, che citava nella
prefazione attraverso le parole dello studioso Giorgio Galli nella sua Storia
della Democrazia Cristiana, per il quale Todo modo –
film e libro – rappresenterebbe la parabola del
“processo degenerativo di questa sorta di filosofia della
prassi conservatrice”. Secondo Sciascia: “nel vuoto
di riflessione, di critica e persino di buon senso in cui la vita
politica italiana si è svolta”, il suo romanzo e
il film che ne è stato tratto “non potevano
apparire che anticipazioni, che profezie; se non addirittura istigazioni”
(Sciascia, 1994).
Se si apre il dizionario del giornalista Stefano Grassi
dedicato al “caso Moro” (Il caso Moro. Un
dizionario italiano) – quasi ottocento pagine in
cui tutte le piste possibili relative a questo snodo decisivo della
storia della Repubblica sono seguite e analizzate con
l’ossessione sintomatica di un desiderio di impossibile
esaustività – si trova anche una voce dedicata a Todo
modo. La cosa può apparire bizzarra, ma in
realtà il film di Elio Petri tratto dal romanzo breve di
Leonardo Sciascia è legato a doppio filo al drammatico
destino del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: a lui
s’ispirò Gian Maria Volonté per calarsi
nei panni del Presidente, l’enigmatico ed evanescente
protagonista della pellicola, con una capacità imitativa
tale che si preferì buttar via la prima parte del girato
perché si temeva che altrimenti non avrebbe mai passato il
filtro della censura; e d’altro canto la scena con cui si
chiude il film, in cui il Presidente in ginocchio è freddato
da un colpo di pistola alla nuca, diventò due anni dopo
così spaventosamente profetica, in seguito alla scoperta del
cadavere di Moro ucciso proprio da diversi colpi di pistola, da rendere
– scrive Grassi – “di fatto
«invisibile» il film per molti anni”
(Grassi, 2008). Ma l’ombra di Moro seguì sia
Volonté che Sciascia: il primo tornò a
interpretare il personaggio, questa volta senza pseudonimi, nel film di
Giuseppe Ferrara Il caso Moro del 1986; il secondo,
in qualità di deputato dei Radicali, partecipò ai
lavori della Commissione Moro e nel 1978 pubblicò (quattro
anni dopo il suo Todo modo) L’affaire
Moro. La sua impressione era che “l’affaire
Moro fosse già scritto, che fosse già compiuta
opera letteraria, che vivesse ormai in una sua intoccabile
perfezione” (Sciascia, 1994). Si riferiva, con queste parole,
all’ineluttabilità del destino del presidente
della DC, ma anche al suo precedente romanzo, che citava nella
prefazione attraverso le parole dello studioso Giorgio Galli nella sua Storia
della Democrazia Cristiana, per il quale Todo modo –
film e libro – rappresenterebbe la parabola del
“processo degenerativo di questa sorta di filosofia della
prassi conservatrice”. Secondo Sciascia: “nel vuoto
di riflessione, di critica e persino di buon senso in cui la vita
politica italiana si è svolta”, il suo romanzo e
il film che ne è stato tratto “non potevano
apparire che anticipazioni, che profezie; se non addirittura istigazioni”
(Sciascia, 1994).
Questa inquietante
sovrapposizione di realtà e fiction è tipica di
quegli eventi destinati a rappresentare traumi irrisolti della memoria
collettiva: l’assassinio di J.F. Kennedy o
l’attentato dell’11 settembre 2001 sembrano ai
nostri occhi, esattamente come il caso Moro, più film che
episodi reali, al punto che da qualche parte nella nostra coscienza
traumatizzata s’insinua il dubbio di non assistere a un fatto
davvero accaduto ma a una fiction: una finzione o un’opera
letteraria, per dirla con Sciascia. Da qui parte tutta la
concatenazione di idee che alimenta le tesi complottiste: tutte le
ferite aperte della nostra Storia possono essere rilette come il
risultato di un complotto, una costruzione a tavolino che niente lascia
alla casualità che invece percepiamo in un primo momento,
che rende plausibile un evento altrimenti talmente implausibile da
sembrare romanzesco, irreale. Il Presidente ucciso da una revolverata e
Aldo Moro freddato dai colpi delle Brigate Rosse nel bagagliaio della
Renault 4 rossa diventano tutt’uno: dove finisce
l’anticipazione, la profezia, e quindi
l’invenzione, e dove inizia la realtà?
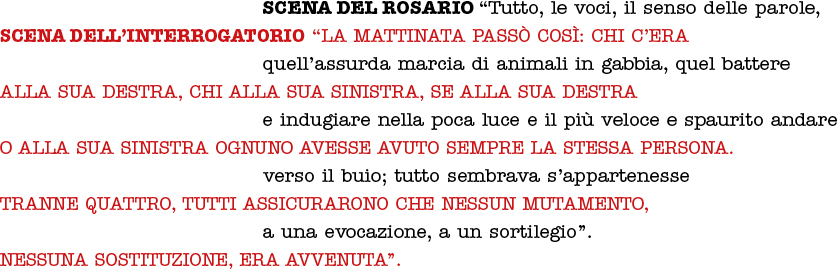
Todo modo ha risentito certamente del
trascorrere del tempo. Il romanzo appare, al lettore odierno, un giallo
ai limiti del divertissement, su cui si staglia
all’orizzonte una riflessione sulla corruzione del potere,
quello religioso come quello politico, e della loro commistione; il
film che Petri ne trasse nel 1976 (riproposto finalmente in dvd nel
2015) può essere goduto come un’opera di
fantapolitica, sullo stesso piano del suo magnifico La decima
vittima tratto dal romanzo di Robert Sheckley (cfr. in questo
numero). Certamente i lettori del 1974 e gli spettatori del 1976
dovettero comprendere molto più intuitivamente il senso
profondo di quelle opere, strettamente intrecciato con la cronaca
politica. Pertanto è necessario, per capire davvero Todo
modo, ricostruire le vicende che ne ispirarono la
realizzazione. Il 13 febbraio 1974 i responsabili amministrativi dei
partiti al governo – DC, PSI, PSDI, PRI – finirono
nel mirino della magistratura di Genova per un giro di sovvenzioni da
parte delle compagnie petrolifere intenzionate a impedire
l’introduzione dell’energia nucleare nel paese.
Questi soldi, versati da anni alle casse dei partiti, venivano
presentati come aiuti concessi spontaneamente per sostenerne
l’operato democratico, ma in realtà erano legati
all’effettiva adozione di politiche vantaggiose per i
petrolieri, i quali s’impegnavano in cambio a versare ai
partiti il 5% sui vantaggi derivanti, proporzionalmente al loro peso
politico. È un sistema che dimostrava una connivenza
inquietante e scandalosa tra politica e affarismo in un periodo in cui
la Dc di Amintore Fanfani chiedeva agli italiani sacrifici legati
all’austerity energetica, tra cui la
chiusura anticipata dei cinema e dei locali e le domeniche a piedi.
L’eco
di questo scandalo ispirò certamente Sciascia quando,
all’interno del suo romanzo, fa scoprire al procuratore
“un mazzo così di fotocopie di assegni”
(Sciascia, 2003) firmati dalla prima vittima della vicenda,
l’onorevole Michelozzi, a tutti i partecipanti al ritiro
spirituale, tutti esponenti del partito di governo: “Lui
ragiona così: Michelozzi dava a costoro del denaro non
perché se ne andassero a donne o corressero a depositarlo in
Svizzera; glielo dava per il Partito, per le correnti nel Partito, per
le sezioni, le clientele, i singoli clienti” (ibidem).
Anche
il film di Petri gira tutto intorno alla commistione tra potere
pubblico e capitali privati: in una delle più spassose
scene-chiave, il Presidente chiede ai suoi colleghi di partito di dare
conto di tutte le aziende statali e private con cui hanno rapporti, tra
consulenze, presidenze, posti in consiglio d’amministrazione,
quote azionarie. Ne emerge un profluvio di sigle fantozziane e una
serie di accuse reciproche su chi abbia mangiato di più.
L’onorevole Ventre cerca di fare il sunto: “Ma
allora questo discorso vale anche per Caprarozza, che era presidente
dell’Urgep, ma attraverso la Tuttogas di Fatigò,
che era proprietaria del 50% delle azioni della Urgep, si collegava con
la Arabic di Voltrano, proprietaria del 68% delle azioni Tuttogas.
Quindi Caprarozza è in pericolo, e anche io… In
quanto presidente della Visir che è proprietaria del
più grosso pacchetto azionario della Tulip di
Fatigò, collegata tramite la Modern Bank alla Crom di
Michelozzi!” (Petri, 2015).
Non c’è solo lo scandalo petroli, nel
1974. Il 12 e 13 maggio l’Italia si recava alle urne per il
referendum abrogativo della legge sul divorzio. La DC, naturalmente,
era per l’abrogazione, in linea con le indicazioni di
Oltretevere, ma com’è noto quasi il 60%
votò No. È un terremoto, una svolta politica
radicale. Paolo VI, che più di tutti ha voluto il
referendum, ne esce profondamente amareggiato. All’indomani
dell’approvazione della legge, nel 1970, aveva scritto un
appunto al suo segretario di stato: “Far sapere
all’Ambasciatore d’Italia che la promulgazione
della legge sul divorzio produrrà vivissimo dispiacere al
Papa: per l’offesa alla norma morale, per
l’infrazione alla legge civile italiana, per la mancata
fedeltà al Concordato e il turbamento dei rapporti fra
l’Italia e la Santa Sede” (cit. in Vian, 2004). Le
elezioni dell’anno successivo videro il Pci arrivare a
un’incollatura dalla DC e l’Italia si
colorò di “giunte rosse”. Il
democristiano Massimo De Carolis, fresco di gambizzazione delle Brigate
Rosse, profetizzava: “Stiamo morendo. Ma ci rimpiangerete. Io
vi dico che rimpiangerete la DC!” (cit. in Pansa, 2004).
È
insomma chiara nel paese la sensazione di essere a un
“doloroso bivio”, come lo definisce il Presidente
nel film di Petri. Il partito che ha governato l’Italia negli
ultimi trent’anni è oggettivamente in
disfacimento, come gli scheletri nella cripta dell’albergo
Zafer dove i personaggi di Todo modo si rinchiudono
per i loro esercizi spirituali. C’è soprattutto la
sensazione che la Dc sia stata abbandonata dalla Chiesa, che fino ad
allora è stata la sua principale azionista. Riuniti per fare
il punto sulle morti misteriose dei loro colleghi, i vertici del
Partito nel film si chiedono: “E se già la Chiesa
volesse prendere le distanze da noi? Dal Partito?”. Per uno
dei presenti, “sarebbe il colmo
dell’ingratitudine” . Per un altro, invece, bisogna
tenere conto che “la Chiesa gioca sempre
d’anticipo; ora fiuta la crisi generale”. E allora
l’onorevole Schiavò arriva a formulare
un’ipotesi: “E se tutti, dico tutti, industriali,
preti, CIA, ecc. ecc. si fossero messi d’accordo per
liquidarci?” (Petri, 2015).
Ecco lo
scenario in cui si muove il film di Petri e su cui indugia Sciascia nel
suo romanzo. Qui Don Gaetano parla molto chiaramente al protagonista,
il Pittore: quando questi gli chiede “che bisogno hanno i
suoi amici di governare, di comandare: con la sua benedizione se non
addirittura per suo mandato?” (Sciascia, 2004) il prelato gli
risponde che quelli “non sono miei amici” e
aggiunge: “Il nostro più grande errore, il
più grande errore che sia stato commesso da coloro che hanno
governato, o che hanno creduto di governare, la Chiesa di Cristo,
è stato quello di identificarsi, ad un certo momento, con un
tipo di società, con un tipo di ordine” (ibidem).
La soluzione è quindi “distruggere,
distruggere…”. Ma cosa? La società,
naturalmente, con cui la Chiesa fino ad allora ha fatto affari: quella
governata dal Partito, dalla Democrazia Cristiana. Il
“divorzio” che nell’Italia reale si
consuma tra DC e Vaticano si trasforma, nel romanzo di Sciascia, in una
specie di resa dei conti finale di cui Don Gaetano si fa artefice e
carnefice, uccidendo man mano i vertici del Partito che ospita a
Zafer.
Nel film di Petri, il complotto si fa ancora più
vasto. La Chiesa è solo una pedina. Il resto lo fa
“l’America”, come suggerisce
l’onorevole Schiavò. È
l’America che vuole un cambio di governo, preferendo al
Presidente il suo avversario, “Lui”,
com’è chiamato nel film: forse il leader
dell’opposizione o più probabilmente di una delle
tante correnti, ora ritenuta più affidabile rispetto al
vecchio establishment in dismissione. Per compiere questo rovesciamento
di regime, ecco la “strage di Stato”, che per una
volta non colpisce vittime innocenti – il 1974 è
anche l’anno di piazza della Loggia e del treno Italicus
– ma i vertici del paese: “Quattro ministri
attualmente in carica, nove sottosegretari, tredici onorevoli, sei
senatori, quattro presidenti di società a partecipazione
statale, nove vicepresidenti, tre direttori generali, cinque presidenti
di istituti finanziari e assicurativi, tre alti magistrati, due
direttori di giornali, tre presidenti di giunte regionali”
(Petri, 2015), come sciorina con vanto lo speaker dello Zafer. La
trappola è ben architettata: mentre fuori il paese
è colpito da una misteriosa epidemia, che simboleggia la
cancrena politica, e ricorda l’antefatto del Decameron,
nell’albergo-monastero ecco riunirsi la crème
de la crème politico-istituzionale. Don Gaetano
non le manda a dire: “Ma quanto credete che vi
rimanga?”, urla durante uno dei suoi deliranti sermoni.
“Il potere uccide!” (ibidem).
E durante la refezione sussurra al Presidente: “Ma
l’inferno è qui vicino, è sottoterra,
ci siamo dentro. E io sono qui per accompagnarvici” !”
(ibidem).
Don Gaetano
compie la sua missione con la convinzione che essa serva a far uscire
la Chiesa dalla stessa condizione drammatica in cui si trova il paese.
Nel romanzo di Sciascia, il prete paragona la Chiesa alla Zattera della
Medusa, alla deriva tra le onde dell’oceano, e su cui i
superstiti si danno al cannibalismo pur di sopravvivere.
Così è anche il Partito. C’è
un’inquietante specularità tra le due istituzioni,
sembra suggerire Sciascia, ma la Chiesa intende liberarsi da
quest’immagine di disfacimento che lo specchio le restituisce
riflettendosi nella politica dell’Italia. Ecco allora il
ruolo di Don Gaetano, che si definisce un “prete
cattivo”, per poi chiarire: “La sopravvivenza, e,
più che la sopravvivenza, il trionfo della Chiesa nei
secoli, più si deve ai preti cattivi che ai buoni.
È dietro l’immagine dell’imperfezione
che vive l’idea della perfezione: il prete che contravviene
alla santità o, nel suo modo di vivere, addirittura la
devasta, in effetti la conferma, la innalza, la
serve…” (Sciascia, 2004). Con questa sorta di
olocausto sacrificale, allora, la Chiesa potrà tornare alla
sua vera essenza, liberarsi dalla zavorra che la sta trascinando sul
fondo.
Ma mentre Sciascia conclude la storia con il
rinvenimento del cadavere di Don Gaetano, forse suicida, forse ucciso
dal Pittore, la voce narrante che rappresenta l’uomo comune,
Petri si spinge a elaborare una sorta di “teoria del
tutto” del complottismo in cui anche altri poteri forti
partecipano alla spartizione delle spoglie (“Dove
c’è un cadavere, lì ci sono le
aquile”, ricorda Don Gaetano citando il Vangelo [Petri,
2015]). A un certo punto il Presidente viene preso da parte da un
gruppo di americani travestiti da preti e suore e scortato nei
sotterranei di Zafer per essere messo al corrente di quanto sta
accadendo. Allora decide di prestarsi a portare a compimento la
mattanza a modo suo, come è giusto attendersi da un
Presidente che aspira al “settennato”: depistando,
disseminando falsi indizi e proponendo teorie alternative per
confondere le acque. Quando presenta al procuratore Scalambri la sua
ipotesi sugli omicidi, tutti legati alle sigle delle aziende con cui i
suoi colleghi sono in affari, che vanno a formare la frase
“Todo modo para buscar la voluntad divina”, questi
nel film gli chiede: “Chi le ha suggerito
quest’ipotesi pazzesca?”. Il Presidente svicola:
“Lasci stare, sono persone che se ne intendono”
(Petri, 2015). Impossibile, con l’occhio di oggi, non mettere
a confronto questa scena in cui il Presidente presenta
un’assurda ipotesi di comodo suggerita dagli
“Americani” per nascondere la verità,
con il ruolo che giocherà Steve Piczenik, il consulente del
Dipartimento di Stato americano coinvolto nel caso Moro, che in anni
recenti confermerà il ruolo di “manipolazione
strategica” del suo paese nella vicenda “al fine di
stabilizzare la situazione dell’Italia” (cit. in
Ludovico, 2013). Quando il Presidente viene portato via dal
“commando” americano sotto mentite spoglie,
balbettando di avere “many, many, many doubts” su
tutta l’operazione, oggi noi vediamo piuttosto Aldo Moro con
la faccia di Gian Maria Volontè chiedersi, come egli fece
nelle sue lettere dalla prigionia: “Vi è forse,
nel tener duro contro di me, un'indicazione americana e
tedesca?” (Moro, 2009).
In sostanza dunque Todo
modo rispondeva, all’epoca, all’esigenza
di rovesciare le parti come in un sadico carnevale, in cui le vittime
delle stragi di Stato sono gli stessi politici; una sorta di
sublimazione di un’insofferenza profonda nutrita dalla pancia
del paese nei confronti dell’establishment politico
dell’epoca. Ma l’omicidio Moro, quattro anni dopo
l’uscita del romanzo di Sciascia e due anni dopo il film di
Petri, trasformava improvvisamente quella fiction in realtà.
Una realtà drammatica, traumatica, dalla quale siamo
lontanissimi dal riprenderci, tant’è che
un’ennesima commissione d’inchiesta parlamentare
sulla vicenda è ancora in corso, a quasi
quarant’anni di distanza. Se il film di Petri è
scomparso così a lungo dagli schermi, è
perché rappresenta la nostra cattiva coscienza, dando voce
ai nostri desideri, ma anche alle nostre inquietudini più
profonde.
LETTURE
— Giorgio Galli, Storia della DC 1943-1993: mezzo secolo di Democrazia cristiana, Kaos Edizioni, Milano, 2007.
— Stefano Grassi, Il caso Moro. Un dizionario italiano, Mondadori, Milano, 2008.
— Marco Ludovico, L’esperto Usa: “Così manipolammo il caso Moro”, Il Sole 24 ore, 1° ottobre 2013.
— Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, Einaudi, Torino, 2009.
— Giampaolo Pansa, La caduta di Fanfani, La Repubblica, 8 maggio 2004.
— Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Adelphi, Milano, 1994.
— Leonardo Sciascia, Todo modo, Adelphi, Milano, 2003.
— Gian Maria Vian, Montini e il divorzio trent’anni dopo, “Vita e Pensiero”, n. 3, 2004.
VISIONI
— Giuseppe Ferrara, Il caso Moro, CG Entertainment, 2005 (home video).
— Elio Petri, Todo modo, CG Entertainment, 2015 (home video).
— Elio Petri, La decima vittima, CG Entertainment, 2008 (home video).