- di Andrea Sanseverino
- SOMMARIO

 Al di là della scelta
di riportare (quasi) fedelmente un’opera letteraria oppure di
proporre una trasposizione più vicina a tempi e luoghi
attuali, una questione preliminare va risolta da parte di registi e
sceneggiatori, ossia come giocare quella complessa partita tra le
potenzialità della scrittura e quelle della macchina da
presa. Si fa riferimento, innanzitutto, alla possibilità che
chi scrive ha di narrare con tanta facilità e anche in
maniera rapida, ad esempio, stati d’animo insondabili
all’obiettivo, facendo ricorso a metafore o al lesto recupero
di ricordi. La scrittura, infatti, illumina spesso la
profondità dei pensieri e la concatenazione degli stessi. La
macchina da presa, tuttavia, concede al regista di offrire allo
spettatore, influenzandolo non poco, un’immagine della
situazione raccontata che lascia poco spazio alle
perplessità di chi guarda, le stesse che colgono, invece,
chi legge. Si potrebbe dire che le capacità sintetiche di un
mezzo facciano da controcanto a quelle analitiche dell’altro,
e viceversa. Non sono moltissimi i titoli di libri e pellicole a essi
ispirati che possono vantare un equilibrio solido tra le due forze
narrative evocate, ma tra essi si può annoverare Mephisto.
Storia di una carriera, scritto da Klaus Mann (pubblicato nel
1936) e dal quale nel 1981 il regista ungherese István
Szabó trasse un film interpretato da Klaus Maria Brandauer,
vincendo l’Oscar e il David di Donatello per la miglior
pellicola straniera. Il secondogenito di Thomas Mann narrò
del talentuoso attore di provincia Hendrik Höfgen che
raggiunge la fama sulle tavole dei palcoscenici berlinesi attraverso la
protezione del Presidente dei Ministri Hermann Göring, di cui
diventa pedina nella famelica sfida fra lui e il ministro della
propaganda Joseph Goebbels: al pari di Faust, che, non seguendo il
monito di Lutero, “pensò che il diavolo non era
così nero come lo si dipinge e nemmeno l’inferno
così caldo come si racconta” (Spies, 1980), il
protagonista stringe di fatto un mefistotelico patto col criminale
regime delle camicie brune, rinnegando gli ideali politici e artistici
di un tempo, quelli che lo avrebbero condotto ad allestire spettacoli
per operai e lavoratori dei cantieri navali all’insegna del
Teatro Rivoluzionario. La consacrazione della propria fama, attraverso
i complimenti di Göring, avviene mentre Hendrik
Höfgen veste i panni di Mefistotele (o Mephisto), espediente
che concede all’autore del romanzo la possibilità
di esaltare la natura faustiana dell’intesa coi nazisti e,
allo stesso tempo, l’ambiguità dello stesso
protagonista.
Al di là della scelta
di riportare (quasi) fedelmente un’opera letteraria oppure di
proporre una trasposizione più vicina a tempi e luoghi
attuali, una questione preliminare va risolta da parte di registi e
sceneggiatori, ossia come giocare quella complessa partita tra le
potenzialità della scrittura e quelle della macchina da
presa. Si fa riferimento, innanzitutto, alla possibilità che
chi scrive ha di narrare con tanta facilità e anche in
maniera rapida, ad esempio, stati d’animo insondabili
all’obiettivo, facendo ricorso a metafore o al lesto recupero
di ricordi. La scrittura, infatti, illumina spesso la
profondità dei pensieri e la concatenazione degli stessi. La
macchina da presa, tuttavia, concede al regista di offrire allo
spettatore, influenzandolo non poco, un’immagine della
situazione raccontata che lascia poco spazio alle
perplessità di chi guarda, le stesse che colgono, invece,
chi legge. Si potrebbe dire che le capacità sintetiche di un
mezzo facciano da controcanto a quelle analitiche dell’altro,
e viceversa. Non sono moltissimi i titoli di libri e pellicole a essi
ispirati che possono vantare un equilibrio solido tra le due forze
narrative evocate, ma tra essi si può annoverare Mephisto.
Storia di una carriera, scritto da Klaus Mann (pubblicato nel
1936) e dal quale nel 1981 il regista ungherese István
Szabó trasse un film interpretato da Klaus Maria Brandauer,
vincendo l’Oscar e il David di Donatello per la miglior
pellicola straniera. Il secondogenito di Thomas Mann narrò
del talentuoso attore di provincia Hendrik Höfgen che
raggiunge la fama sulle tavole dei palcoscenici berlinesi attraverso la
protezione del Presidente dei Ministri Hermann Göring, di cui
diventa pedina nella famelica sfida fra lui e il ministro della
propaganda Joseph Goebbels: al pari di Faust, che, non seguendo il
monito di Lutero, “pensò che il diavolo non era
così nero come lo si dipinge e nemmeno l’inferno
così caldo come si racconta” (Spies, 1980), il
protagonista stringe di fatto un mefistotelico patto col criminale
regime delle camicie brune, rinnegando gli ideali politici e artistici
di un tempo, quelli che lo avrebbero condotto ad allestire spettacoli
per operai e lavoratori dei cantieri navali all’insegna del
Teatro Rivoluzionario. La consacrazione della propria fama, attraverso
i complimenti di Göring, avviene mentre Hendrik
Höfgen veste i panni di Mefistotele (o Mephisto), espediente
che concede all’autore del romanzo la possibilità
di esaltare la natura faustiana dell’intesa coi nazisti e,
allo stesso tempo, l’ambiguità dello stesso
protagonista.
Tornando a quell’articolato confronto tra le
potenzialità analitiche e quelle sintetiche sia della penna
che della macchina da presa, si considerino un paio di scene di Mephisto.
Innanzitutto quella della lezione di ballo che Hendrik Höfgen
intrattiene con la sua amante Juliette, figlia di un ingegnere di
Amburgo e di una donna di colore del Congo, che lei dice avere nobili
origini: Juliette, dal carattere violento e incline al troppo bere, ha
il ruolo dialetticamente dominante in una situazione che dalla danza
porta alla lotta, e da questa all’amplesso. Klauss Mann rende
la fisicità di lei attraverso immagini che richiamano a una
rude fierezza, che la macchina da presa comunque rende, ma anche con
una sconcertante similitudine con i macabri riti attribuiti alla
tradizione del continente materno, richiamo che l’obiettivo
stavolta non può concedere; una similitudine che marca
vigorosamente i rapporti di forza fra i due. “La nera
cominciò ad armeggiare intorno al giradischi. Sentendo la
musica jazz che cominciava a diffondere d’un tratto i suoi
ritmi disse in tono rude: «Comincia!».
Digrignò contemporaneamente le file di denti sin troppo
candidi, roteando gli occhi truci: questa era esattamente
l’espressione che egli ora s’aspettava da lei. Il
suo volto si ergeva di fronte a lui come l’orribile maschera
di un dio straniero che troneggia maestoso in mezzo alla foresta, in un
luogo ben nascosto, ed esige, mostrando i denti e facendo roteare gli
occhi, sacrifici umani. Glieli portano, ai suoi piedi sprizza il
sangue, con il naso camuso ne annusa l’odore dolce e
familiare e agita un poco il busto imponente al ritmo selvaggio e
frenetico di un tam–tam. Intorno a lui i suoi sudditi,
già in preda all’estasi, eseguono una danza
gioiosa. Agitano braccia e gambe, saltellano, si dondolano, barcollano:
le loro urla si trasformano in un gemito voluttuoso, il gemito diventa
un respiro affannoso, e già si lasciano cadere fino a
prostrarsi ai piedi della divinità nera che amano e ammirano
con tutta la loro forza – come fanno uomini che amano e
ammirano solo colui al quale hanno sacrificato il loro bene
più prezioso: il sangue” (Mann, 1992). Le parole
di Mann, tuttavia, non rendono come la pellicola il gioco felino dei
passi dei due danzatori sui nuovi ritmi oltreoceano, gli stessi che di
lì a qualche anno avrebbero incontrato il monito di
Goebbels, né la sonorità della risata di Juliette
che accompagna le frasi di scherno rivolte a Hendrik Höfgen,
sottolineando la dote della maestra di conoscere i punti deboli del
carattere del succube allievo. Poco dopo, quando la severa insegnante
accusa Hendrik di essere solo una maschera, negandogli di fatto
un’anima, questi, attenendoci alla versione italiana del
film, curata da Valerio Zurlini, si difende: “Ma
anch’io ho pelle, e ossa, e il peso del mio corpo, e
ciglia, e unghie, proprio come te! […] Anch’io
soffro se fa freddo, anch’io ho fame e sete”, per
poi contraddirsi, come spesso fanno gli amanti in certe occasioni in
cui la logica cede ai sensi, asserendo, sempre più travolto
dalla passione: “Ma i miei occhi non sono i miei occhi, e le
mie gambe non sono le mie gambe, e la mia faccia non è la
mia faccia, e il mio nome non è il mio nome,
perché sono un attore. Lo sai, Juliette, che
cos’è un attore? Un attore non è che
una maschera, una maschera tra la gente”. È il
preludio al sesso, in cui tutta la corporeità dei due, non
più insegnante e allievo, non più padrona e
servo, si fondono in una sola figura, che difficilmente la penna
può rendere più della macchina da presa.
Quest’ultima, tuttavia, si arrende alle
potenzialità della prima in una sequenza successiva, in
corrispondenza delle pagine dedicate al matrimonio di Hendrik
Höfgen con Barbara Bruckner, figlia di un Consigliere noto per
la sua posizione di prestigio nell’ambiente
accademico–letterario in patria e nel continente, ma
già inviso per l’influenza marxista che, si
diceva, aleggiasse nei suoi lavori di storico.
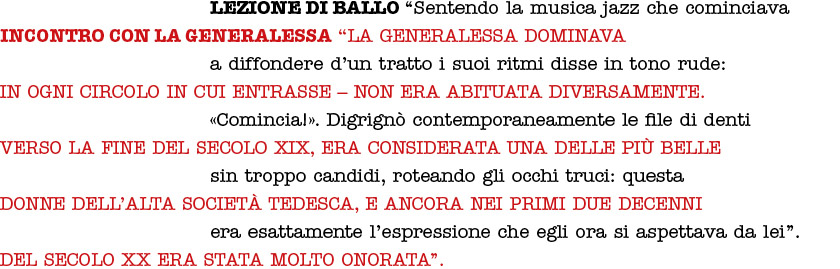
In particolare il riferimento va all’incontro tra l’attore con la nonna materna della sposa, un’elegante anziana donna, un tempo consorte di un Generale e per questo nota come la Generalessa. La brevissima sequenza di Szabó differisce per delle sfumature nei dialoghi rispetto al romanzo, ma dove si ferma l’obiettivo incede la penna ad illuminare questa figura minore ma non priva di un certo peso, almeno per quanto riguarda la pagina scritta. Attraverso una sorta di curriculum vitae delle esperienze legate agli incontri culturali con personaggi di rilievo della sua epoca, le righe di Mann fanno della Generalessa l’archetipo di una figura molto apprezzata nel mondo della Mitteleuropa, il cui sogno s’era infranto con la tragedia della Grande Guerra, e che Hitler stava per sostituire con l’incubo del Lebensraum, lo spazio vitale. Della donna l’autore di Mephisto scriveva: “La Generalessa dominava in ogni circolo in cui entrasse – non era abituata diversamente. Verso la fine del secolo XIX, era considerata una delle più belle donne dell’alta società tedesca, e ancora nei primi due decenni del secolo XX era stata molto onorata. Tutti i grandi pittori dell'epoca le avevano fatto un ritratto. Nel suo salotto principi e generali si erano incontrati con poeti, compositori e pittori. Per molti anni, a Monaco e a Berlino, si era parlato quasi altrettanto dell’intelligenza e dell'originalità della Generalessa che della sua bellezza. Poiché suo marito – morto già da alcuni anni – aveva goduto della simpatia delle più alte autorità e, inoltre, era stato ricco, le si perdonavano opinioni, sentimenti e atteggiamenti che in ogni altra persona sarebbero stati giudicati eccentrici fino alla sconvenienza. Perfino il Kaiser aveva notato la sua bellezza; per questo poté, già nell’anno 1900, esprimersi in favore del diritto di voto alle donne. Sapeva a memoria lo Zarathustra e a volte ne recitava interi brani, fra l’addolorata meraviglia dei suoi ospiti aristocratici, che lo ritenevano un testo vagamente socialista. Aveva conosciuto Franz Liszt e Richard Wagner; aveva tenuto una corrispondenza con Henrik Ibsen e Björstjerne Björnson. Verosimilmente, era contraria alla pena di morte. Al suo contegno, in cui si univano una libera spensieratezza e un’imperturbabile solennità, non si poteva non perdonare tutto” (Mann, 1992).
Quanto rilevato sul complesso rapporto fra sceneggiatura e romanzo ha con Mephisto una declinazione particolare, dal momento che a tale confronto si aggiunge quello con la storia, in quanto la figura di Hendrik Höfgen è ispirata alla vicenda umana e professionale dell’attore Gustaf Gründgens, un tempo amico dell’autore nonché cognato (fu sposo fino al 1929 di Erika Mann), divenuto anche Consigliere di Stato e Intendente del Teatro di Stato. Anche la storia del cinema lo ricorda, soprattutto per la sua partecipazione in un ruolo di rilievo in M – Il mostro di Düsseldorf. Mephisto è dunque uno Schlüsselroman, ossia un romanzo a chiave, ma nonostante l’artificio della finzione, la pubblicazione del testo, soprattutto in patria, fu molto travagliata, con ricorsi sia alla Corte Federale e che alla Corte Costituzione dell’allora Repubblica Federale Tedesca: un processo che vedeva contrapposto il diritto di personalità, che tutelava Gründgens, alla libertà di espressione artistica, che sosteneva le ragioni di Klaus Mann; controversia durata anche dopo il decesso di entrambi, resa ancora più complessa sia da una sorprendente dichiarazione dell’autore che rifiutava l’etichetta Schlüsselroman per la propria opera, sia perché, come scrisse l’editore Berthold Spangenberb, uno dei narratori della disputa legale, sotto un certo profilo essa si risolveva in una sgradevole contrapposizione tra “un esiliato [e] un altro dignitario del Terzo Reich che aveva aiutato dei perseguitati politici e, tramite il suo collaborazionismo, aveva salvato, agli occhi i molti uomini della sua generazione, la tradizione del teatro tedesco al di là dello stesso Terzo Reich” (Spangenberb, 1992). Dal punto di vista dell’interpretazione, quella di uno straordinario Klaus Maria Brandauer, si ha, dunque, un attore che recita la parte di un attore, innescando un gioco doppio che diventa triplo considerando il legame che sotteso fra il personaggio e un altro attore, Gründgens, benché, per le ragioni ricordate, su molte copie circolate del romanzo si poteva leggere, dopo l’ultima riga, il monito “tutti i personaggi di questo libro rappresentano tipi, non sono ritratti” (Klauss Mann, 1992).
Per quanto riguarda alcune scelte narrative, il regista opta, come spesso accade per gli adattamenti da testi letterari, per una riduzione delle figure in gioco, le stesse talvolta seguono destini più o meno differenti da quelli propinati loro dallo scrittore, ma sia Szabó quanto Mann perseguono strettamente l’obiettivo di delineare la natura ambiguamente debole del protagonista. Lo scrittore ne La svolta. Storia di una vita aveva affermato a riguardo: “L’attore che io presento ha ingegno, ma, all’infuori di ciò, ha poco che parli in suo favore. Manca specialmente di quelle virtù morali che si sogliono raggruppare sotto il nome di “carattere”. Invece di carattere codesto Hendrik Höfgen ha ambizione, vanità, sete di celebrità, smania di impressionare. Non è un uomo; è un commediante. Valeva la pena di dedicare un romanzo a un simile individuo? Sì, perché il commediante diventa l’esponente, quasi il simbolo di un regime burattinesco, falso, assurdo. Nel regno dei bugiardi e degli spostati il mimo trionfa. Mephisto è il romanzo di una carriera nel Terzo Reich” (Mann, 1962). “L’artista è un uomo. Come tale prende parte alla storia. Dunque «fa parte» degli avvenimenti, li determina e li interpreta insieme. Se tutto questo è indivisibile nell’uomo e dall’uomo, per l’artista lo è in misura maggiore” (De Marchi, 1997), aveva sentenziato Szabó, in una intervista nei primi giorni di marzo del 1976, ma sia lui che Klaus Mann, nelle rispettive opere, abbandonano Hendrik Höfgen all’irrequietezza di un incerto futuro nonostante lo straordinario successo, che nel mentre cresceva nella misura in cui i suoi colleghi fuggivano dalla nazione o sparivano nel nulla. Il regista ungherese, tuttavia, circa vent’anni più tardi, aggiunse idealmente, con la pellicola A torto o a ragione, un nuovo capitolo alla rappresentazione del compromesso degli uomini d’arte con il sanguinario potere di Hitler, Göring e Goebbels, vale a dire quello della messa in stato d’accusa, e il relativo diritto alla difesa, dopo la caduta del regime: tratto da Taking sides del drammaturgo e sceneggiatore Ronald Harwood (opera in Italia nota col titolo Colpevole innocenza o La torre d'avorio), il Faust di turno stavolta è esplicito, ossia il direttore d’orchestra Wilhelm Furtwängler, duramente interrogato da un maggiore dell’esercito statunitense perché gli Alleati vincitori non gli perdonarono la stretta di mano a Goebbels, l’altro semidio (così scriveva di lui Klaus Mann in Mephisto), quello che trasformò la settima arte in una delle più spietate macchine propagandistiche del XX secolo.
ASCOLTI
— Wilhelm Furtwängler, The Legend, EMI Classics, 2012.
LETTURE
— Bruno De Marchi Szabó, una vita a Budapest, in Bruno De Marchi, István Szabó, Il Castoro Cinema – La Nuova Italia, Firenze, 1997.
— Ronald Harwood, La torre d'avorio, Einaudi, Torino, 2002.
— Klaus Mann, La Svolta. Storia di una vita, Il Saggiatore, Milano, 1962.
— Klaus Mann, Mephisto. Storia di una carriera, Feltrinelli, Milano, 2006.
— Berthold Spangenberb, Prefazione all’edizione economica Rowohlt (1980), in Klaus Mann, Mephisto. Storia di una carriera,
— Garzanti, Milano, 1992.
— Johann Spies, Storia del dottor Faust, ben noto mago e negromante, Garzanti, Milano, 1980.
VISIONI
— Fritz Lang, M – Il mostro di Düsseldorf, Koch Media, 2015 (home video).
— István Szabó, A torto o a ragione, CG Enterainment, 2005 (home video).
— István Szabó, Mephisto, General Video, 2006 (home video).