- di Chiara Ribaldo
- SOMMARIO
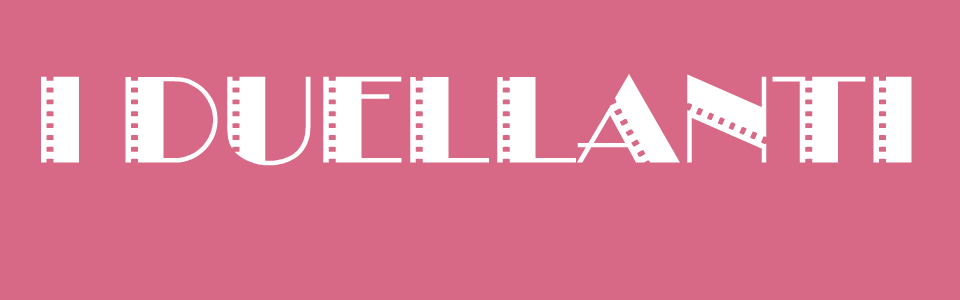
 L’abisso dell’animo umano nasconde
orribili mostri. Follia, disperazione, solitudine, paura. E in quel
lungo e periglioso girovagare tra mondi lontanissimi, che è
stata la sua esistenza, Joseph Conrad è riuscito a dare loro
una forma, una storia, corpi e volti che ci sembra di poter toccare,
che, pur nella loro distanza temporale, abbiamo l’impressione
di conoscere intimamente nei turbamenti, nelle pause di pensiero, nei
tumulti del cuore, come uno specchio incollato sulle nostre facce.
L’abisso dell’animo umano nasconde
orribili mostri. Follia, disperazione, solitudine, paura. E in quel
lungo e periglioso girovagare tra mondi lontanissimi, che è
stata la sua esistenza, Joseph Conrad è riuscito a dare loro
una forma, una storia, corpi e volti che ci sembra di poter toccare,
che, pur nella loro distanza temporale, abbiamo l’impressione
di conoscere intimamente nei turbamenti, nelle pause di pensiero, nei
tumulti del cuore, come uno specchio incollato sulle nostre facce.
Difficile
restituire in prosa l’indecifrabilità
dell’essere – è una navigazione quasi
sempre controvento e senza nord – e, tuttavia, il compito di
farci udire, di farci sentire, di farci soprattutto vedere, attraverso
e dentro le parole, è assolto da Conrad con grande maestria,
grazie ad una scrittura terribilmente moderna e impressionistica.
È anche per una simile ragione che i suoi romanzi,
più e meglio di altri, si prestano a diventare narrazioni
per immagini, traduzioni cinematografiche fedeli, non tanto e non solo
alla struttura narrativa, quanto al principio che li ha mossi, a quella
linea d’ombra che travalica oceani ed epoche e che segna
ineluttabile la sorte di ogni uomo sulla terra. Gettati nel mondo
disarmati, soldati di una guerra che non possono vincere, questo il
fato dei protagonisti del piccolo volume, I duellanti,
ispirato a fatti straordinariamente reali e contenuto nella raccolta Un
gruppo di sei. Più che un racconto militare e
storico, un trattato antropologico sulla vacuità e la
violenza della natura umana. Non un tentativo di indagarne le ragioni,
ma piuttosto un percorso verso l’accettazione di un difetto
congenito, dell’imperfezione come assunto ontologico.
“Napoleone I, la cui carriera ebbe il carattere di un duello contro l’intera Europa, disapprovava il duello fra gli ufficiali del suo esercito (…) Tuttavia, (…) due ufficiali, simili ad artisti dementi che si sforzino di indorare dell’oro o di imbiancare un giglio, proseguirono una contesa privata attraverso quegli anni di carneficina universale” (Conrad, 2009).
Sedici anni e sei duelli tra Russia, Germania e Francia, con
sciabole, spade, pistole, tra i boschi, in sella a un cavallo, dentro
una stalla, nel retro di una casa, in ritirata tra i cosacchi,
inebriati di vino, amori e stupidità, mentre sullo sfondo va
in scena l’epopea napoleonica con i suoi generali e i suoi
cadaveri. Gabriel Florian Feraud e Armand D’Hubert sono due
giovani Ussari dell’esercito di Napoleone, dissimili e
inconciliabili in ogni aspetto del loro essere: meridionale il primo
che “pareva nato ubriaco per il sole della sua terra di
vigneti” (ibidem), settentrionale il
secondo il quale “era nato sobrio sotto cieli acquosi di
Piccardia” (ibidem); popolano
l’uno, aristocratico l’altro; Feraud ha la pelle
d’ebano e una statura piccola, capelli nerissimi,
D’Hubert è slanciato, chioma bionda, occhi di un
azzurro glaciale. Due piani paralleli che il destino beffardo ha
inclinato affinché si trovassero fianco a fianco nel duello
collettivo che è la guerra, l’uno contro
l’altro in singolari quanto irrisoluti tenzoni.
La
prima volta che si scontrano, D’Hubert sta per arrestare
Feraud a causa di un precedente duello con il nipote del sindaco di
Strasburgo, è l’inizio di un conflitto di classe.
Esplode come un fulmine un rancore antico, che per Gabriel Florian va
placato con il sangue nobile di Armand, una lama a colmare il senso di
inadeguatezza e l’umiliazione di ammettere a se stesso di non
essere altro che un piccolo guascone arrabbiato, figlio di un fabbro.
Traviati
dalla vanità, tale scopo sarà però
disatteso. Quella ferocia deliberata, di cui neanche una belva sarebbe
capace, resta appiccicata alle loro uniformi, moltiplicandosi a ogni
fendente. Precipitati in una causa senza orgoglio alcuno, i due
ufficiali finiscono per far aderire le loro intere vite agli
appuntamenti sul terreno di lotta, tra una campagna napoleonica e
l’altra. La ragione del duello è diventata,
dunque, il duello stesso. Per questo, il trionfo finale del generale
D’Hubert sullo storico nemico ha il sapore di una sconfitta.
Un tranello aveva svelato tutta l’indegnità della
vita vissuta fino a quel momento: “Così a
quell’uomo calmato dal vittorioso esito di un duello, la vita
apparve spoglia del suo fascino, semplicemente perché non
era più minacciata” (ibidem).
Quando,
nel 1977, Ridley Scott decide di realizzare la trasposizione
cinematografica del libro di Conrad, firmando il suo primo
lungometraggio, probabilmente ha ancora negli occhi le spettacolari
sequenze di Barry Lyndon (1975) di
Stanley Kubrick. Le scene dei duelli, infatti, sembrano straordinari
tableau vivant, resi ancora più suggestivi
dall’uso del campo lungo e da una fotografia pittorica
influenzata nell’alternanza di luci e ombre dalle opere di
Caravaggio, Rembrandt e Friedrich.
Scott e lo sceneggiatore Gerald Vaughan Hughes costruiscono il
film attorno a uno storyboard scrupoloso, fedele quanto più
possibile al romanzo, senza però tradire il medium che
utilizzano. Alleggerito delle sue connotazioni politiche e sociali, la
pellicola si concentra sui duelli, restituiti con dovizia di
particolari e arricchiti dalla spettacolarità delle
coreografie, riducendo i dialoghi alle battute più rilevanti
e inserendo un personaggio femminile non presente nell’opera
letteraria, Laura, amante giovanile di D’Hubert, interpretata
dall’attrice londinese Diana Quick. Non un’eroina
in senso moderno, lo sarà due anni dopo la Ellen Ripley di Alien,
ma una donna comunque attuale consapevole di sè, coraggiosa,
malinconica, protagonista di una delle scene più
significative del film.
Dopo il secondo duello in cui
D’Hubert viene colpito gravemente al petto dalla spada di
Feraud, Laura, che è donna di truppa, si prende
amorevolmente cura dell’uomo ferito, fino alla sua
guarigione, cercando di scrutare le ragioni di tale astio, diventato
oramai leggendario tra i soldati, e implorando più volte
l’ufficiale di porvi rimedio, di “fare la
pace”, anche se sa bene che la mano del burattinaio
è una sola, quella di Gabriel Feraud. Per questo, una sera
decide di recarsi da sola al suo accampamento identificandosi come la
donna che vive con Armand D’Hubert. A quel nome il tenente,
come in preda ad uno spasmo o ad un riflesso incondizionato, impugna la
spada apostrofando la donna con parole sarcastiche e di sfida:
“Conosco un uomo che fu pugnalato a morte da una donna quando
meno se lo aspettava”. Laura, che ha in sé, anche
se in forma embrionale, tutte le qualità della donna
scottiana, risponde con una battuta profondamente e tristemente
attuale: “Conosco una donna che fu picchiata a morte da un
uomo, ma lei questa fine se l’aspettava”.
In
piedi di fronte al nemico dell’uomo che ama, circondata da
alti ufficiali e donne di guarnigione che, come lei, vivono di
“oboli e occasionali amicizie”, non può
che smascherare con le parole la reale natura dello scontro ed
è una verità che non piace affatto a Feraud,
accecato e già sconfitto da una vanità delirante,
come scrive Conrad, dall’ossessione verso
un’impresa fallimentare fin dal suo concepimento.
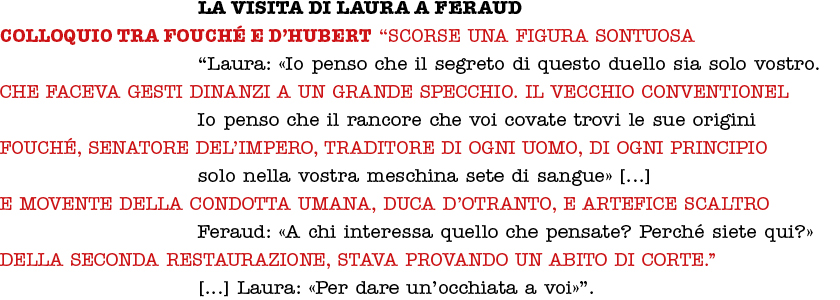
Laura: “Nessuno sa capire perché infierite su Armand, la gente suppone che sia un segreto tra voi. Io penso che il segreto sia solo vostro. Io penso che il rancore che covate trovi le sue origini solo nella vostra meschina sete di sangue”
Feraud: “A chi interessa quello che pensate?”
Laura: “A nessuno”
Feraud: “E allora perché siete qui?”
Laura: “Per dare un’occhiata a voi”
È un dialogo di un vigore straordinario, quello tra Laura e Feraud, misurato nei respiri, infiammato dagli accenti, quell’“io penso” ripetuto due volte con apparente sicumera tuona come uno sparo, così la battuta finale, che assume tutto il peso morale di una sentenza.
Se Conrad lascia le figure femminili sullo sfondo,
Scott e Hughes le promuovono, danno loro un peso e una direzione nel
caos in cui invece abitano i caratteri maschili, affidando a un
personaggio totalmente inventato per il grande schermo il duplice ruolo
di testimone e giudice. L’occhiata all’uomo,
piccolo, assetato di sangue, che tiene in ostaggio il suo amato Armand
e l’occhiata all’uomo di cui è
innamorata e a cui si costringe a dire “addio”,
parola che scriverà con il rossetto sulla lama della
sciabola appena affilata del suo amato e già pronta per
l’ennesimo duello. Uno sguardo fugace, appunto, alle piccole
cose terrene, all’insensatezza, alla banalità. Uno
sguardo pietoso, arrabbiato, ma pieno d’amore, uno sguardo di
cui solo le donne sono capaci.
In questa parentesi narrativa
Scott sceglie di racchiudere tutto l’universo di senso
conradiano, lasciando che il resto del film aderisca al testo in modo
quasi pedissequo.
La prossimità tra i due
linguaggi è in parte merito di una scrittura estremamente
visuale colma di particolari che poco spazio lasciano alla libera
immaginazione. Esempio perfetto di siffatta aderenza è la
scena del colloquio tra il ministro della polizia Joseph
Fouché e il generale D’Hubert.
È
il 1815, il secondo regno di Napoleone è finito, il re
è tornato sul trono e le liste di proscrizione hanno
disegnato un cappio sul collo di molti ufficiali della Vecchia Guardia,
tra cui il bonapartista incallito Gabriel Florian Feraud.
Armand,
a Parigi per incontrare il sovrano, apprende dalla conversazione tra
due sconosciuti seduti accanto a lui in un caffè della
prossima condanna a morte del suo vecchio rivale e anche di come questo
si ostini ad additarlo pubblicamente come “l’uomo
che non aveva mai amato l’Imperatore”
(2009, p. 78). Spinto dall’ombra dell’ignominia e
dal rimpianto per quel passato bellicoso, D’Hubert riesce ad
ottenere un’udienza privata con Fouché, ministro
del re e presidente della Commissione Speciale, allo scopo di
cancellare il nome di Feraud da quella lista.
“Il generale barone D’Hubert fu introdotto bruscamente senza preavviso. Nella penombra del gabinetto del ministro, dietro scrittoi, tavole e sedie, tra due fasci di candele che ardevano nei loro candelabri, scorse una figura sontuosa che faceva gesti dinanzi a un grande specchio. Il vecchio conventionel Fouché, senatore dell’Impero, traditore di ogni uomo, di ogni principio e movente della condotta umana, duca d’Otranto, e artefice scaltro della Seconda Restaurazione, stava provando un abito di corte” (ibidem).
Frank Tidy, direttore della fotografia, dipinge la scena come un quadro di Caravaggio, la luce delle candele scava i volti dei due attori, Albert Finney nei panni di Fouché e Keith Carradine in quelli di D’Hubert, trasformandole in maschere contratte, mentre la scenografia di Peter Hampton restituisce la ricchezza della rappresentazione offerta dal libro. Persino i dialoghi, asciugati per infondere maggiore ritmo, non sono differenti da quelli scritti da Conrad settant’anni anni prima.
“Vostro parente, quel Feraud?” chiede Fouché assai sorpreso da quella richiesta. “No. Nient’affatto parente” risponde Armand, ma il ministro lo incalza “amico intimo?”. Qui Scott traduce la risposta retorica presente nel romanzo – “Intimo…sì. Vi è fra noi un legame intimo di natura tale che m’impone come un punto d’onore il tentare…” (ibidem) – con un ironico e pungente: “no, io non direi, c’è stata una lunga conoscenza”.
Accontentatosi della risposta evasiva del generale, il duca estrae da un cassetto del suo scrittoio un foglio e qui la scena, nello scambio di battute tra i due, è una copia fedele di quello che leggiamo.
Dal romanzo:
“Vediamo un po’, Feraud … Ah, eccolo. Gabriel Florian (…) Ecco il vostro uomo (…) Il generale D’Hubert si raddrizzò come se fosse scampato a una malattia contagiosa. «Devo pregare Vostra Eccellenza di tenere rigorosamente segreto il mio intervento. È per me della massima importanza che egli mai non sappia…» «Chi andrà ad informarlo, vorrei saperlo?», disse Fouché, alzando uno sguardo curioso sul viso rigido e immobile del generale D’Hubert. «Prendete una di queste penne, e cancellate il nome voi stesso»” (ibidem).
Dal film:
Fouché: “Sì, ecco il vostro uomo, Feraud, Gabriel Florian. Vivrà in provincia sotto la sorveglianza della polizia, questo è evidente, però vivrà. Prendete una penna, amico mio, e cancellate il nome. Non posso mica fare tutto io”.
D’Hubert: “Vorrei pregarvi di mantenere segreto il mio intervento, soprattutto col generale Feraud”.
Fouché: “Il generale Feraud, vivo o morto, non vale un attimo del mio tempo”.
L’incontro tra il ministro e il generale assume nel romanzo connotazioni politiche molto forti, che nella pellicola sono invece ridotte, emerge però la complessità delle emozioni provata da D’Hubert nella scelta di salvare l’uomo che potrebbe ucciderlo e che lo ha tenuto prigioniero per quindici anni, imbrigliato, come un cavallo, a un ridicolo e selvaggio capriccio. Sono sufficienti pochi secondi, un primo piano sul volto stanco, arreso, afflitto, di Armand/Carradine per comprendere il peso delle parole di Joseph Conrad: “«Niente di meno che una vita», rispose D’Hubert.
«E l’ho ottenuta. Bisognava farlo. Eppure mi pare che non potrò mai perdonare a quell’uomo il bisogno che ho sentito di doverlo salvare»” (ibidem).
È il cinema. È la letteratura. Forse, semplicemente, l’uomo.
LETTURE
— Joseph Conrad, La linea d’ombra, Mondadori, Milano 1999.
— Joseph Conrad, Il Negro del “Narciso”, Rizzoli, Milano 1960.
— Joseph Conrad, I duellanti, Passigli Editori, Firenze 2009.
VISIONI
— Stanley Kubrick, Barry Lyndon, Warner Home Video, 2008 (home video).
— Ridley Scott, I duellanti, Paramount, 2003 (home video).