VISIONI / L.O.V.E. / di Maurizio Cattelan / Milano, Piazza degli Affari
Per leggere
le contrade della vita
e quello che vita non è
di Antonello Tolve
“La storia delle tecniche artistiche, è
l'indicazione data da Gianni Carlo Sciolla, si svolge" "[…]
analogamente alla storia dei materiali […], tra il polo
della tradizione a quello dell'innovazione. Essa, nel suo insieme
è fatta [...] di periodi di stasi, ma anche di variazione e
di novità improvvise. In questa storia vanno considerati, da
ultimo, anche gli arretramenti e i ritorni a forme tecniche precedenti,
motivate e sostenute da finalità culturali molto precise.
Alludo, più precisamente, ai recuperi revivalistici del
passato, messi al servizio di nuovi orientamenti di gusto di una
determinata epoca. Si pensi, per esempio, alla riscoperta delle
tecniche pittoriche classiche del Settecento; al recupero dei sistemi
di lavorazione medievale nello storicismo ottocentesco e all'uso dei
materiali come delle tecniche arcaiche del decadentismo tra Otto e
Novecento; infine al ripristino di determinate tecniche incisorie
medievali da parte dell'Espressionismo novecentesco” (Sciolla, 2001, p.
35; 2009, pp. 45 e segg.). Naturalmente, ciò che
è innovativo oggi diventa tradizionale
o magari obsoleto domani. Questo perché
i materiali, come le tecniche e gli strumenti dell'arte seguono un
andamento metamorfosico: legato, cioè, ad un divenire
costante di metodi, espressioni e stili.
Seguendo queste
indicazioni, non parrà strano imbattersi, nel panorama
creativo attuale, in una moltitudine di artisti che trasformano in
tecniche e materiali alcuni argomenti o discipline decisamente
extraestetiche o extrapoetiche, quali l'economia, il diritto, il
marketing, la matematica, la fisica, la medicina, la psicoanalisi e la
scienza in generale. Nuove modalità immaginifiche ed
esecutive, queste che, per dirla con Angela Vettese, “non sono giochi
immotivati ma naturali riflessi del modo in cui si vive, si produce, si
consuma, ci si scambiano le informazioni” (Vettese, 2010, p. V).
Già
con l'analisi formalista proposta da
Šklovskij, ad esempio, i materiali extraestetici –
e per primi quelli di ordine musicale, sociale e politico –
entrano a far parte a pieno diritto nel vocabolario dei materiali usati
per la concreta realizzazione dell'opera grazie ad una percezione
protratta mediante ostacoli (Šklovskij, 1929, pp.
7-23) con lo scopo di organizzare un effetto straniante
capace di trasformare e deformare l'abitudinario e l'abituale in un
nuovo stupore per il mondo, in una nuova
verità capace di toccare, con maggiore e rinvigorita
efficacia, il fruitore di turno. “L'abitudine”, ha evidenziato Todorov,
“ci impedisce di vedere, di sentire gli oggetti, bisogna deformarli se
si vuole che riescano a trattenere il nostro sguardo: il fine delle
convenzioni artistiche sta proprio in questo” (Todorov, 1968, p. 14).
Così
accanto al marmo, alla plastica, al silicone o all'acciaio, ci sono, ad
esempio, lo spazio, il tempo, il mercato, l'economia e la
comunicazione, lavorate queste ultime con strumenti diversi, ma con
atteggiamenti simili e con il desiderio di trasformare il materiale
dallo stato grezzo in forma e formula efficace a produrre ed esternare
l'idea dell'artista. (Jeff Koons, ad esempio, ha applicato al proprio
formulario artistico la regola delle Quattro P
– Product, Price, Place
e Promotion – facendo del marketing
un nodo forte e felice del proprio lavoro).
All'interno
di questo panorama, Maurizio Cattelan (Padova, 1960) è
esponente cardinale di un percorso evolutivo che trasforma il mercato
dell'arte in opera d'arte mediante stratagemmi che trovano spesso nei
meccanismi del motto di spirito – quei
meccanismi che elogiano un sistema legato all'analogia, al paradosso, a
formule metaforiche e metonimiche, a processi di condensazione, di
spostamento, di ellissi e a tutte quelle metodologie che originano un
atto creativo liberatorio (Sigmund Freud)
–, alcuni materiali utili a cortocircuitare, parodiare e
mettere in rilievo determinati luoghi e territori del sistema presente,
dell'arte e della vita.
Artista legato ad uno stile versatile
e camaleontico grazie al quale riesce a tratteggiare ogni tipo di
problematica attuale, Maurizio Cattelan schiude un discorso formale, di
stampo espressivo e rappresentativo, che, in forme spesso provocatorie
e stranianti sollecita il pubblico ad uno sguardo
differente su icone e simboli della società contemporanea e,
in particolare, sulle differenti figure di quello che Arthur Danto ha
definito l’Artword (Danto, 1964, pp.
571-584). Di un territorio in cui sfilano figure che dettano e
determinano le regole e le sorti dell'arte contemporanea.


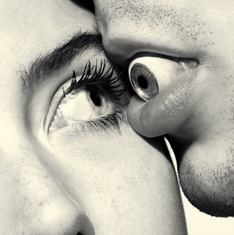




Partendo
da un vocabolario d'impostazione concettuale (Barilli, 2006, pp.
149-152) – fortemente intriso di venature estetiche che fanno
i conti con lo spiazzamento, il non sense e
l'ironia – Maurizio Cattelan [l'unico artista italiano
(Barilli, 2007, pp. 528-529) che ha saputo saltare il fosso analitico tout
court] apre dunque un percorso che calibra il mirino estetico
su panorami visivi densi di significato, aperti al mercato e al sistema
dell'arte, ma anche a quella che è stata definita una mitologia
quotidiana (Perretta, 1991, p. 40), appropriandosi del
messaggio mediatico e trasformandolo in comunicazione creativa tesa ad
inclinare, non senza amplificarli, i canali della comunicazione di
massa.
Figlio d'una generazione che ha attraversato i
territori tortuosi del neoconcettuale, Cattelan formula,
così, una propria storia paraconcettuale
(vicina al concettuale, ma già lontana da ogni tautologia)
per trasformare la materia, qualunque essa sia, da stato spesso e
pesante a stato leggero e pensante. Difatti, se con l'Untitled
[opera in cui Cattelan ripercorre l'importanza del taglio (e
l'insegnamento) di Lucio Fontana per presentare una tela –
tagliata su tre punti – che riformalizza la "Z" di Zorro] del
1986, l'artista è ancora legato ad un forte prefisso
concettuale [come anche in Stadium 1991 presentato
negli spazi della Galleria d'Arte Moderna di Bologna (1991), un
lunghissimo tavolo da calcetto con undici giocatori senegalesi e undici
giocatori scelti tra le riserve], già con Strategie
del 1990, o con A Perfect Day del 1993 (dove
attacca al muro, con lo scotch da imballaggio, il suo gallerista
Massimo De Carlo), Cattelan avvia il proprio discorso sul sistema
dell'arte. Nello stesso anno (1993), invitato per la prima volta ad una
Biennale di Venezia, Cattelan scardina e critica il sistema stesso
della Biennale – e delle esposizioni
in generale – nonché
le difficoltà che incontrano gli artisti per poter esporre
in un circuito tanto blindato e manipolato dalle multinazionali
dell'arte, mettendo in scena, questa volta, Lavorare
è un brutto mestiere: performance in cui l'artista
vende ad un'agenzia pubblicitaria il proprio spazio espositivo. E
sempre per la Biennale – questa volta la 49a, curata da
Harald Szeemann – con La Nona Ora,
scultura ambientale realizzata nel 1999, l'artista propone un lavoro
che ritrae Giovanni Paolo II su un enorme tappeto rosso atterrato e
sfinito sotto il peso di un meteorite. (“Inutile dirlo, il lavoro, al
centro di molte e non meno accese polemiche, è stato esposto
alla Royal Academy di Londra e a Varsavia, e battuto da
Christiès nel 2001 per la cifra record di 886 mila dollari,
all'epoca equivalenti a due miliardi di lire” (Vivimilano.it., 2006).
Interrogandosi ancora una volta sui concetti di vernissage,
di spazio espositivo, di exhibition,
di spettacolarizzazione dell'arte, di potere delle
multinazionali, di ipocrisia e di comunicazione globale, sempre nel
1999, dal 10 al 17 novembre, assieme a Jens Hoffmann, Cattelan cura la
fantomatica 6th Carribean Biennial,
un evento senza precedenti di cui “tutto il mondo dell'arte
internazionale che conta, parla” (Politi, 2000, p. 51). Trasformando la
curatela in prefisso interrogativo sulla curatela stessa e analizzando
la complessa organizzazione di potere che sponsorizza l'esibizione,
l'artista propone così una Biennale – solitaria,
senza precedenti e senza successive edizioni – durante la
quale invita una serie di artisti (Olafur Eliasson, Douglas Gordon,
Mariko Mori, Chris Ofili, Gabriel Orozco, Elisabeth Peyton, Tobias
Rehberger, Pipilotti Rist, Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija e
Vanessa Beecroft) a trascorrere circa due settimane di villeggiatura
gratis ai Caraibi, nell'isola di St. Kitts, senza lavorare, senza
produrre e senza esporre alcuna opera, lasciando in bianco
il popolo dell'arte accorso per l'occasione.




Premendo sempre sul mercato e trasformando la scena oscena dello spettacolo in
formula integrativa e in materiale dell'arte, assieme a Ali Subotnick e
Massimiliano Gioni, Cattelan apre a New York, sulla 20esima
strada, The Wrong Gallery, uno
spazio (un progetto) espositivo di un metro quadro che, dopo tre anni
di attività (2002-2005), riapre, poi, in una versione in
scala 1.6, presso la Rubell Family Collection di Miami (Bonami,
Spector, Vanderlinden, 2000).
Poi, invitato a curare, con
Massimiliano Gioni e Ali Subotnick la 4. Berlin Biennale für
zeitgenössische Kunst (2006), Von Mäusen
und Menschen / Of Mice and Men [Uomini
e Topi, titolo che richiama senza mezzi termini l'omonimo
romanzo di John Steinbeck] (Steinbeck, 1937), Cattelan, partendo sempre
da uno zoccolo duro del sistema dell'arte – questa volta
dalla Gagosian Gallery, tra le più potenti e influenti al
mondo [una galleria che vanta tre succursali a New York con un quarto
spazio dedicato interamente allo Shop, una a
Beverly Hills, due a Londra, una a Roma, una a Ginevra, una a Parigi,
una ad Atene e due uffici a La Jolla e ad Hong Kong] (Thompson, 2009)
– predispone una serie di eventi nella fantomatica filiale
berlinese – ubicata in Auguststrasse 50A – della
galleria di Larry Gagosian.
Occasioni e luoghi,
questi, attraverso i quali Cattelan propone una pressione creativa che
sfonda ogni perbenismo per interrogare a punta di lancia le maglie
dell'arte e del mercato. Di una globalità legata a preamboli
scandalistici e a un'arte “politicamente corretta, giusta, perfetta
perché realizzatasi pienamente nel mercato, gaudente nel suo
esercizio dell'esserci è talmente in linea con i “desideri”
del mondo da riuscire persino a fare del proprio narcisismo e
divertimento un'opera d'arte, nel grande rispetto e nell'ammirazione
dei potentati artistici” (Scudero, 2001).
Critica d'arte che
prende corpo, l'arte è, per Cattelan, riflessione sull'arte
e sul sistema dell'arte. Esperimento, esercizio e congiunzione estetica
(a volte anche furba linea di fuga di chi, secondo alcuni, dal
sistema dell'arte, scompone il sistema dell'arte pur restandone
invischiato) atta a scardinare il circuito artistico mediante trucchi
stilistici che bersagliano astutamente l'universo istituzionale
– di qualsiasi estrazione e natura – e promuovono
una nuova libertà capace di reinventare il ruolo
dell'artista all'interno di un sistema di scambi di ruoli
dopo la fine dei grandi racconti.
“Dal tema dell'insofferenza
per la scuola in quanto modulo dell'autoritario della trasmissione del
sapere, al rifiuto cronico del lavoro come punizione quotidiana,
Cattelan”, evidenzia Francesco Manacorda, “mette in scena una sequenza
di gesti paradigmatici volti a destabilizzare il sistema di regole
assolute, deprimenti e tragiche, a cui non ci accorgiamo neanche
più di aderire. […]. Dalla scuola tale
atteggiamento beffardo si trasferisce a leader politici o
autorità religiose fino a infiltrarsi nel sistema dell'arte
contemporanea con i suoi canoni” (Manacorda, 2008, p. 8).
Artista,
curatore, gallerista, manager. Cattelan prende di mira i ruoli e le
funzioni del sistema dell'arte per stravolgerli dall'interno mediante
operazioni e relazioni interpersonali che si fanno, il più
delle volte, relazioni estetiche, nessi, formule
atte a eccentricizzare il ruolo preso in esame per dilatarlo e
smagliarlo.
Dall'orsetto – Senza titolo
(Untitled), 1993 – presentato nella galleria
Massimo De Carlo dove gli spettatori potevano guardare soltanto
dall'esterno perché la porta della galleria, per
l'occasione, era stata murata ai galleristi Raucci/Santamaria
costretti, nel 1993, in occasione della personale Tarzan e
Jane, ad indossare, per tutta la durata della mostra, due
costumi da leone, dal Massimo De Carlo appeso nella propria galleria (A
Perfect Day, 1999) a Errotin, le vrai lapin
(1994), dove l'artista fa indossare a Emmanuel Perrotin –
responsabile di Ma Gallerie di Parigi – il costume di un
coniglio rosa a forma di pene, Cattelan stravolge il rapporto
artista-gallerista per sottolineare la scelta dell'artista, essere
privilegiato in grado di riscattare l'opera dal suo essere oggetto con
valore estetico, di incrinare il gallerista al gusto dell'artista.
“Le
strategie con cui Cattelan si introduce ed opera nel sistema
dell'arte”, ha evidenziato Giorgio Verzotti in una ricognizione sul
lavoro dell'artista, “non si accontentano di svolgere i ruoli e le
funzioni normalmente assegnate. Molte di esse vengono elaborate in
clandestinità, come l'artista stesso dichiara, con uno
scambio e una sovrapposizione di ruoli al limite dell'abusivismo”. Nel
1991, ad esempio, dispone, appunto, uno Stand abusivo
ad Arte Fiera (Bologna), mentre nel 1992 “progetta la Fondazione
Oblomov e coinvolge privati per sovvenzionare un artista, al quale
è richiesto di non esporre per un anno intero” (Verzotti,
Cattelan, 1999, pp. 25-26). Sarcastico, ironico
e trasgressivo, Maurizio Cattelan “crea sculture e mette in scena
azioni davanti alle quali lo spettatore rimane sorpreso, allibito o
perplesso” (Pesapane, 2008, p. 122).
L'originalità,
legata ad un buon grado di frizzo e canzonatura,
è proposta anche in occasione della Laurea Honoris Causa
conferitagli il 30 marzo 2004 (lo stesso anno dello straordinario Untitled,
tre bambini impiccati ad un ramo di quercia) dalla facoltà
di Sociologia dell'Università di Trento dove
l’artista, identificandosi con un asino, realizza, appunto, Un
asino tra i dottori.
In occasione della personale
– Contro le ideologie (2010) –
organizzata a Milano, tra Palazzo Reale e Piazza Affari, ritornando sui
prefissi del mercato globale, l'artista propone un nuovo avvincente
scenario che suscita immediato scandalo, scalpore e chiasso
mediatico.


È L.O.V.E. la pietra miliare
dello scandalo, una monumentale scultura in marmo di Carrara (alta ben
undici metri) che raffigura una mano con le dita mozzate a esclusione
del dito medio, alzato e puntato prepotentemente verso il cielo.
“In
termini di microstoria sociologica”, è l'analisi proposta da
Giovanni Lista, “[...] l'atto di mostrare il dorso della mano con il
dito medio esteso e le altre dita chiuse, appare nella comunicazione
gestuale fin dall'antichità. Il gesto è
documentato già nel IV secolo a.C. ne Le Nuvole di
Aristofane, e in seguito nella letteratura latina del I secolo d.C.,
definito digitus medius da Quintiliano, digitus infamis da Persio
Flacco, digitus impudicus da Marziale” (Lista, 2010, p. 10).
Trasformando
l'indice di borsa in medio di borsa,
l'artista assume un atteggiamento analitico nei confronti della
situazione attuale del mercato globale, per farsi portavoce di un
pensiero collettivo condiviso. Con Cattelan, difatti, l'arte ritorna
alla storia, ad un bisturi creativo che fa i conti con la
quotidianità per elencare un progetto riflessivo che va contro
la comunicazione (Mario Perniola, 1994) e si proietta in un
discorso visivo che si fa scandalo, cortocircuito teso a sottolineare i
vizi privati e le pubbliche virtù di un panorama sociale,
economico e politico davvero scomodo, sgradevole, imbarazzante.
L'offesa
alla morale, l'oltraggio al pudore, l'azione vergognosa o immorale sono
strumenti che Cattelan adopera per creare una centrifuga distruttiva
nei confronti di un conformismo imperante che devitalizza la
riflessione e sopprime il giudizio. L'artista non vuole scandalizzare
– l'artista è sempre l'istigatore nella
rivolta delle cose (Šklovskij) – ma
illuminare lo stato delle cose e farsi portavoce d'un sentimento
collettivo, d'un'idea comune.
Ad una trasparenza che
occulta, persuade (Packard, 1957) e rende
invisibili alcuni meccanismi di potere politico, economico e mediatico,
Cattelan contrappone uno scavo (Foucault) che
mostra, grazie ad una sana trasparenza frontale, il sistema
autoritario, corrodendolo dall'interno.
Archeologo
del presente e dell'attualità, Maurizio Cattelan svolge,
così, indagini su problematiche scottanti proponendo allo
spettatore una galassia estetica metaforicamente secca, senza vie di
scampo, sarcastica e spigolosa per bersagliare ogni perbenismo, ogni
totalitarismo, ogni forma di dittatura.
Marcel Duchamp, Lucio
Fontana, Manzoni, Alighiero Boetti, Kosuth, Kunellis, De Dominicis.
Cattelan preleva dalla storia dell'arte attuale – e
particolarmente dalle “belle e argute “pensate””
(Barilli R., 2007, p. 528) di Piero Manzoni e di Gino De Dominicis
– alcuni ingredienti trasformandoli e riattualizzandoli
mediante formule visive che citano, con disinvoltura, l'arte e la vita
per aggredire l'episodio storico attuale e inoculare nello spettatore
il germe della verità. “I salti di dimensione, i passaggi da
un livello di significato all'altro sono tonificanti”, suggerisce
Barilli lettore di Cattelan, “allargano i canali della mente e dei
sensi: questo è in fondo il fine principale dell'estetica,
se non dell'arte” (Barilli, 2007, p. 529).
Tuttavia con
Cattelan l'arte non è soltanto discorso (analisi e
costruzione del proprio linguaggio) ma anche controdiscorso (legame con
gli altri saperi) che dialoga con il mondo della vita e dei mille
significati che la riguardano (Trimarco, 1992). Interrogando e mettendo
in questione il contesto dell'arte, Cattelan propone operazioni che non
solo prelevano l'oggetto per attribuirgli lo statuto artistico (come fa
Duchamp con lo scolabottiglie) ma asporta anche
alcuni problemi dominanti della società quotidiana e del
sistema dell'arte per trasformarli in ragionamento artistico, in
preambolo felice per la costruzione dell'opera. Anche il recente
progetto editoriale ideato assieme a Pierpaolo Ferrari segue queste
mosse stilistiche. Toilet paper, questo il titolo
(un titolo che la dice lunga), pubblicata dalla Deste Foundation for
Contemporary Art di Atene e con il sostegno della Fondazione Nicola
Trussardi di Milano, è un magazine di sole immagini che fa
il verso (ma analizza anche dall'interno) al mondo delle riviste
patinate e a tutta una sfilata di critici e curatori autoreferenziali e
narcisistici. Una ulteriore operazione messa in campo dall'artista si
fonda sullo sconfinamento, o meglio sullo spostamento e prolungamento
dell'io. Di un'io, cioè, che si riappropria della propria
forza evocatrice e si vaporizza linguisticamente in una serie di
interventi visivi in cui la ripetizione, la centralizzazione o la
vaporizzazione determinano atteggiamenti spettacolari e
spettacolarizzanti in cui l'io, appunto, cerca sempre, prepotentemente
un'identità e un nome.
Dal Lessico
familiare del 1989 a Supermoi (Identikit)
del 1993, per giungere, via via, agli Spermini del
1997 e a Mini-me del 1999, Cattelan, difatti, non
appare soltanto iconicamente nelle sue opere, ma si pone anche come
proposizione linguistica, come sostituzione e traduzione dell'io in
qualcosa d'altro, un neon angolare che rappresenta la scritta Cattelan
(1994), appunto, o la rivisitazione di una pubblicità
d'alcolici trasformata, Absolut Cattelan (1997), ad
esempio.
Amato e osannato, odiato e criticato,
Maurizio Cattelan resta, tuttavia, uno dei pochi artisti in grado di
trasformare (attraverso Der Witz und seine Beziehung zum
Unbewußten – Il motto di spirito e la sua relazione
con l'inconscio, appunto) i problemi che appesantiscono la
storia in corpi leggeri, profondi, pensanti per leggere le contrade
della vita e quello che vita non è.

LETTURE
× Barilli R., Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005, Feltrinelli, Milano 2006.
× Barilli R., Storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze, Bollati Boringhieri, Torino 2007.
× Bonami F., Spector N., Vanderlinden B., Maurizio Cattelan, Phaidon Press, London 2000.
× Danto A. C., The Artworld, in “The Journal of Philosophy”, vol. 61, n. 19, American Philosophical Association Eastern Division, Sixty-First Annual Meeting, Oct. 15, 1964.
× De Rosa M. R., Gianni Carlo Sciolla. Storia e critica d'arte del Novecento, a cura di M. R. La Città del Sole, Napoli 2009.
× Lista G., Digitus impudicus, estratto da Ligeia, in Exibart onpaper, a. IX, n. 69, novembre-dicembre 2010.
× Manacorda F., Maurizio Cattelan, Electa, Milano 2006.
× Packard V., The Hidden Persuaders, David McKay Company, New York 1957; trad. it., I persuasori occulti, Einaudi, Torino, 1958.
× Perniola M., Contro la comunicazione, Torino, Einaudi, 2004.
× Perretta G., Medialismo, Roma (Galleria Paolo Vitolo), 26 ottobre/30 novembre 1991, Studio Tipografico, Roma 1991.
× Pesapane G., Arte relazionale, in F. Bernardelli, Arte contemporanea, vol. V, Anni Novanta, Electa / L'Espresso, Milano 2008.
× Politi G., in "Flash Art", a. XXXIV, n. 219, dicembre-gennaio 2000.
× Sciolla G. C., Studiare l’arte, Utet, Torino 2001.
× Scudero D., Cosa si nasconde dietro la “Global-Art”, in LaCritica.net / Rivista telematica di arte, design e nuovi media, a. 2001, www.lacritica.net, n. 4. Šklovskij V., Iskustvo kak priëm, in O teorii prozy, “Federatsiia”, Mosca 1929; ora in Todorov, 1968.
× Steinbeck J., Of Mice and Men, Viking Penguin, New York 1937, trad. it. Uomini e topi, Bompiani, Milano 2001.
× Thompson D., The $12 Million Stuffed Shark. The Curious Economics of. Contemporary Art, Palgrave Macmillan, New York 2008; trad. it., Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea, Mondadori, Milano 2009.
× Todorov T., Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Édition du Seuil, Paris 1965; trad. it., I formalisti russi, Einaudi, Torino, 1968.
× Trimarco A., Il presente dell'arte, Tema Celeste, Siracusa 1991.
× Verzotti G., Maurizio Cattelan, in Maurizio Cattelan, Castello di Rivoli / Charta, Milano 1999.
× Vettese A., Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari 2010.
× Vivimilano.it, Chi è Maurizio Cattelan?, milano.corriere.it.






