|
Se, seguendo le teorie di Marshall McLuhan, le tecnologie
sono estensioni del nostro corpo, nonché amplificazioni dei nostri sensi, in
questo caso abbiamo una tecnologia che non è più relativa ad un senso
particolare, ma ad un organo, il più importante del nostro corpo: il cervello.
La possibilità di demandare la nostra memoria ad un elemento esterno al nostro
corpo, riporta alla mente le riflessioni di Locke sul
concetto di persona e di io. Locke proponeva l’esempio del
mignolo: se lo perdiamo e continuiamo ad avere coscienza di noi, nonché il
corpo continua a vivere, quell’estensione del nostro corpo non è depositaria
della nostra coscienza/consapevolezza. Nel momento in cui però, riflettiamo
oggi, tutto il nostro bagaglio di conoscenze, presenti e passate, è
trasportabile in un elemento esterno al nostro corpo (si pensi ad esempio ad
una periferica di memorizzazione mignolo-USB),
allora l’interrogativo che dobbiamo porci è nuovamente dove risieda l’io. Si
pensi anche al racconto di Sydney Shoemaker, sul
caso del signor Brownson, ovvero il trapianto di cervello del signor Brown nel
corpo del signor Johnson. Il nuovo soggetto è identificabile, in quanto
riconosciuto dagli altri, come il signor Johnson ma questo essere non sa chi
siano le persone che lo salutano. Il corpo di Johnson possiede la memoria e le
coscienze di Brown. Riportando l’esempio ai giorni nostri, se abbiamo la
possibilità di trasferire la nostra conoscenza su un dispositivo esterno, chi
siamo noi? Dov’è il nostro io? Mettiamo che si abbia su di un
dispositivo la memoria del Sig. Brown; mettiamo anche che questo dispositivo
sia in grado di riconoscere i volti delle persone che incontro (nei fatti
esiste); ebbene, io saprò immediatamente tutte le informazioni che Brown aveva
delle persone che incontro. La memoria altrui si muove con me e, per
estensione, la mia stessa memoria si muove indipendentemente da me. È come la
musica digitale che oggi si muove senza alcun supporto fisico e materiale
determinato. La nostra memoria, come un mp3, è solo un file, un insieme di bit,
di informazioni. Platone e Socrate discutevano della scrittura come strumento
di comunicazione della conoscenza senza la presenza fisica dell’emittente: oggi
la riflessione resta valida con le ovvie aggiunte. Non è più una situazione di
trasmissione della parola orale ma di tutto il patrimonio mentale di una
persona (questo trasferimento della memoria è riscontrabile anche nella
cinematografia nel pluri-citato Matrix).
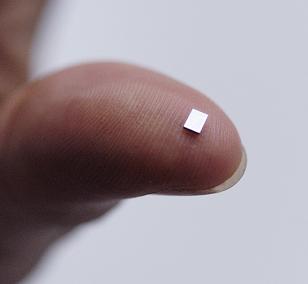 Eppure, questa testimonianza digitale porta a
riflettere su un altro aspetto che
collega le tecnologie digitali alla memoria. Come ricorda Lev Manovich, il
digitale permette di ricreare oggetti reali al computer. Si pensi ai numerosi
film di fantascienza (ma di recente anche di altri generi) nei quali persone,
cose, animali, piante vengono ricreate al computer e poi montate in relazione
ad attori e ambienti naturali. L’analista russo sottolinea inoltre come sia
necessario “peggiorare” l’aspetto di questi elementi ricreati affinché,
all’occhio umano, appaiano il più naturali possibili, con le imperfezioni che
siamo abituati a vedere nel mondo circostante. Il digitale è troppo perfetto e
si deve adeguare al naturale. Eppure, questa testimonianza digitale porta a
riflettere su un altro aspetto che
collega le tecnologie digitali alla memoria. Come ricorda Lev Manovich, il
digitale permette di ricreare oggetti reali al computer. Si pensi ai numerosi
film di fantascienza (ma di recente anche di altri generi) nei quali persone,
cose, animali, piante vengono ricreate al computer e poi montate in relazione
ad attori e ambienti naturali. L’analista russo sottolinea inoltre come sia
necessario “peggiorare” l’aspetto di questi elementi ricreati affinché,
all’occhio umano, appaiano il più naturali possibili, con le imperfezioni che
siamo abituati a vedere nel mondo circostante. Il digitale è troppo perfetto e
si deve adeguare al naturale.
Questa possibilità di creare oggetti che appaiano del
tutto reali implica evidentemente un cambiamento nella gestione della memoria.
Spesso si parla di falsificazione, ovvero l’inserire elementi che non
appartengono al contesto nel quale sono inseriti: per intenderci, si pensi alla
famosa foto scattata il giorno della liberazione di Berlino. Un soldato russo,
ritratto con una bandiera in mano, che sventola sul panorama della città
tedesca, ancora in fiamme. Negli ultimi anni sono stati espressi dubbi sulla
veridicità di questa foto e, dopo diverse analisi, tecniche e storiche, si è
scoperto essere un falso: il soldato era effettivamente a Berlino con una
bandiera, ma la foto (orologi scomparsi e i fumi sullo sfondo) sono stati
aggiunti in fase di sviluppo della foto. Ancora, era stato il fotografo a
portare la bandiera al soldato e dirgli di mettersi in posa. Questo episodio
testimonia come siano state consegnate alla memoria storica e collettiva, dei
falsi, degli eventi che non si sono veramente verificati. È su questa scia che
si dubita ancora dei filmati sul primo atterraggio sulla Luna da parte degli
Americani. Ed oggi con il digitale è possibile modificare perfettamente
un’immagine senza lasciare traccia: è possibile creare dei fotomontaggi più che
perfetti, reali. E dunque, il pericolo è ancora più grave: cosa verrà
consegnato alla nostra memoria futura? Potremmo essere testimoni passivi di
eventi che non si sono mai verificati. Si ricorda un po’ quanto viene
rappresentato in film come Blade Runner, dove nell’automa viene registrato un
passato non suo – ma lui è convinto di esserne invece padrone; e come non
ricordare il pluri-citato e analizzato Matrix, con una realtà del tutto
artificiale, eppure reale per chi la vive (dacché il reale è tutto ciò che
viene percepito dall’essere umano).
|

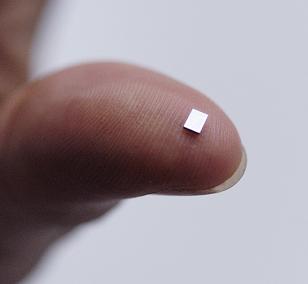 Eppure, questa testimonianza digitale porta a
riflettere
Eppure, questa testimonianza digitale porta a
riflettere