|
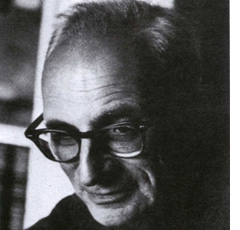 Claude Lévi-Strauss fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi
degli anni Settanta, in Francia, o, per meglio dire, a Parigi, tra gli
intellettuali e gli studenti delle Università parigine era già una
specie di mostro sacro, un autore di cui era obbligatorio conoscere la
vita, le opere principali e aver letto almeno i libri che lo avevano
reso famoso anche presso il grande pubblico, Tristi Tropici e Il pensiero selvaggio: il primo, un racconto di viaggio che si inseriva in una lunga tradizione francese, basti pensare alle Lettere persiane
di Charles-Louis de Montesquieu, e che raccontava dei suoi viaggi di
etnologo in Brasile, presso comunità, come i Nambikwara; il secondo,
uno sguardo eccentrico che dona l'occasione di una visita nel
sottosuolo inquietante del pensiero, dove il progetto d'universalità
della filosofia occidentale appare come “ideologia”, pratica
antropofagica di una coscienza singola o di una certa cultura. Claude Lévi-Strauss fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi
degli anni Settanta, in Francia, o, per meglio dire, a Parigi, tra gli
intellettuali e gli studenti delle Università parigine era già una
specie di mostro sacro, un autore di cui era obbligatorio conoscere la
vita, le opere principali e aver letto almeno i libri che lo avevano
reso famoso anche presso il grande pubblico, Tristi Tropici e Il pensiero selvaggio: il primo, un racconto di viaggio che si inseriva in una lunga tradizione francese, basti pensare alle Lettere persiane
di Charles-Louis de Montesquieu, e che raccontava dei suoi viaggi di
etnologo in Brasile, presso comunità, come i Nambikwara; il secondo,
uno sguardo eccentrico che dona l'occasione di una visita nel
sottosuolo inquietante del pensiero, dove il progetto d'universalità
della filosofia occidentale appare come “ideologia”, pratica
antropofagica di una coscienza singola o di una certa cultura.
A
seguire le sue lezioni al Collége de France non c'erano le folle di
fans che seguivano, attratti magari dall'oscurità del linguaggio, lo
“sciamano” Jacques Lacan: potevi però incontrare intellettuali e
studiosi come Julia Kristeva, Michel Serres, Jean Marie Benoist,
Francoise Hèritier, Paul Henri Stabl, André Green, Jacques Derrida,
impegnati a partecipare attivamente ai suoi “seminari” con interventi
importanti che sarebbero stati sviluppati in saggi su riviste come Tel Quel
o in libri. I suoi seminari erano sostanzialmente dei laboratori dove
problemi e questioni di grande rilevanza per numerose discipline, come
la filosofia, l'antropologia, la sociologia, la psicologia, la
letteratura, venivano affrontati da angolazioni diverse che potevano
così confrontarsi e anche scontrarsi vivacemente, perché la convinzione
di Lévi-Strauss era che il sapere si costruisce attraverso lo scontro
“caldo” delle posizioni, come in un crogiuolo dove metalli diversi si
fondono e si amalgamano dando luogo a qualcosa di nuovo e anche di
inatteso.
Come professore non era né accomodante né accogliente:
come dicevano i suoi allievi aveva uno sguardo che gelava sulle labbra
ogni sorriso. Proprio il modo in cui guardava l'interlocutore colpiva
anche al primo incontro: era come se guardasse attraverso
l'interlocutore qualcos'altro che non si capiva bene dove fosse, se
dentro o oltre. Parlava pesando tutte le parole; nessuna era superflua;
ogni frase aveva una compiutezza cristallina, fosse una affermazione o
una domanda. La vastità della sua cultura era addirittura sconvolgente:
riusciva a tenere insieme le culture di tutto il mondo, da quella
occidentale, a quella indiana, cinese, araba, fino alla cultura dei
gruppi umani più sperduti dell'Africa, dell'Amazzonia, dell'Indonesia.
Ma non si limitava alla fenomenologia: il suo sguardo arrivava
direttamente alle strutture elementari, ai concetti universali che si
riproponevano identici, anche se diversamente vestiti, al “pensiero”
che articolava ogni cultura, anche la più apparentemente strana e
diversa, in modo “strutturalmente” costante. Lo schema fondamentale era
condensato in una frase che fa da introduzione a Il Pensiero selvaggio:
“Se c'è una “capacità di pensiero” da qualche parte, ce ne deve essere
dovunque”. L’antropologia, per Lévi-Strauss, era la disciplina
fondamentale, nel senso che delimitava lo spazio di azione di tutte le
altre discipline, relativamente alle “scienze umane”, anche se,
volendo, avrebbe potuto assorbirle tutte, come appare chiaro in Antropologia strutturale,
la raccolta dei suoi scritti più teorici. Nel secondo capitolo,
“L’analisi strutturale in linguistica e in antropologia”, prendendo
come punto di partenza l’organizzazione in sistema dei fatti
linguistici, così come è stato stabilito dalla fonologia, scrive: “In
un altro ordine di realtà, i fenomeni di parentela sono fenomeni dello
stesso tipo dei fenomeni linguistici”. Ma questo non significa, come
molti hanno interpretato, che la fonologia sia lo schema di
riferimento, in termini strutturali, di tutte le scienze umane, perché
questo primato spetta all’antropologia, in quanto studio delle
strutture fondamentali che reggono l’interazione, lo scambio, tra
soggetti umani/sociali. In qualche modo si riallaccia agli studi di
Marcel Mauss che aveva individuato alla base di tutte le possibili
forme di scambio il triplice obbligo, radicato anche a livello
simbolico nella mente umana, di dare, ricevere, ricambiare, che fondava
ogni principio di reciprocità e da cui dipendono le relazioni di
solidarietà tra gli uomini.
L’antropologia, come la geologia e la
linguistica, come scienza delle relazioni invarianti, diventa una
disciplina capace di cogliere le strutture profonde, universali,
a-temporali e necessarie, al di là della superficie degli eventi,
sempre ingannevole, e al di là dell’apparente arbitrarietà degli
elementi che costituiscono ogni società. A queste strutture non si
accede attraverso la fenomenologia, la descrizione empirica, ma
attraverso la costruzione di modelli. Qui è evidente il riferimento
alla matematica di Evariste Gaulois e alla sua teoria dei gruppi e di
campi, come pure alla teoria olistica secondo cui il tutto precede le
parti. I modelli sono sistemi di relazioni logiche tra elementi, sulle
quali è possibile compiere esperimenti, ossia trasformazioni, in modo
da individuare ciò che sfugge all’osservazione immediata. I modelli, in
pratica, servono a mettere in luce le strutture che formano l’ossatura
logica della realtà. La struttura non è però una semplice forma, ma è il contenuto stesso colto in una organizzazione logica concepita come proprietà del reale.
Nello
studio dei miti queste posizioni teoriche trovano la loro completa
esplicitazione. Perché i miti non sono espressione di sentimenti o
spiegazioni pseudo scientifiche di fenomeni naturali o riflessi di
istituzioni sociali, né sono privi di regole logiche. Come spiegare che
i contenuti dei miti appaiono arbitrari, eppure presentano forti
somiglianze nelle più diverse culture del mondo intero? Per
Lévi-Strauss la risposta sta nel fatto che il mito è l’espressione
dell’attività inconscia dello spirito umano e si struttura come un
linguaggio. Come la funzione significativa di una lingua non è
direttamente collegata ai suoni, ma al modo in cui i suoni sono
combinati tra loro, così anche i miti sono formati di unità costitutive
minime, le cui combinazioni avvengono secondo precise regole e danno
luogo ad unità significanti. Il compito di uno studio scientifico dei
miti consiste nel mostrare non come gli uomini costruiscano dei miti,
ma come i miti si pensano negli uomini, e a loro insaputa.
Ma
Lévi-Strauss non si ferma all’analisi dei miti. Egli fu tra i primi a
porsi il problema dell’efficacia simbolica dei poteri magici e degli
incantesimi fuori dalle logiche superficialmente riduzionistiche della
psicologia americana degli anni Cinquanta. L’incantesimo dello stregone
degli indiani Cuna, che letteralmente nomina il dolore attribuendo nomi
ai vari mali, si rivela efficace proprio perché descrivendo e dando
nomi dona significato, scioglie l’estraneità del male. Lo stregone è
colui che mette in collegamento mondi che stanno su piani diversi. Ma
questo accade in ogni cultura, anche nella nostra, perché, in generale
una cultura costruisce nella sua storia e per essa una intersezione
originale, un nodo di connessioni ben preciso e particolare. Ciò che
differenzia le culture è la forma dell'insieme dei collegamenti, il suo
andamento, il suo posto e così pure i suoi cambiamenti di stato, le sue
fluttuazioni. Ciò che le culture hanno in comune, e che le costituisce
come tali, è l'operazione stessa di collegare, di connettere. Ecco come
emerge l'immagine del tessitore, fondamentale per Lévi-Strauss, nei
miti come nell'etnologia, di colui che lega, annoda, e costruisce ponti
tra spazi radicalmente diversi. Di colui che dice cosa accade tra
queste cose. Di colui che inter-viene a vietare. Di colui che
inter-viene, nelle rotture e nelle crepe, tra le varietà tutte chiuse
in se stesse. Anche il pensiero ha come regola fondamentale
l'interconnessione, il collegamento, la cucitura, la saldatura, così
come, specularmente, la separazione, la divisione, il taglio.
L'etnocentrismo,
ad esempio, si basa su una operazione razionale ma scorretta, di
separazione tra noi e tutti gli altri. Già Platone, nel Politico,
notava: “Abbiamo fatto come se, volendo dividere in due il genere
umano, facessimo la divisione alla maniera della maggior parte delle
genti di qui, che separano la razza ellenica da tutto il resto in
quanto formante una unità distinta e, riunendo tutte le altre razze
sotto la denominazione unica di barbari, benché esse siano
innumerevoli, non si mescolino le une con le altre e non parlino la
stessa lingua, si fondano su questa denominazione unica per guardarle
come una sola specie”.
Molti errori si nascondono nella struttura
stessa del pensiero: il problema dell'uomo è prendere coscienza delle
arbitrarietà che si celano anche dietro e sotto i discorsi più
logicamente splendenti.
:: letture ::
Lévi-Strauss C., Tristi tropici, Mondadori, Milano, 1988.
Lévi-Strauss C., Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano, 1964.
Lévi-Strauss C., Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 1966.
Montesquieu Charles-Louis de, Lettere persiane, Rizzoli, Milano, 1984.
Platone, Il politico, in Tutti gli scritti, Bompiani, Milano, 1997. |

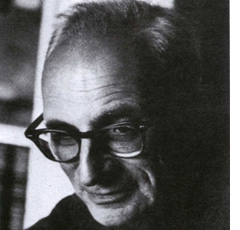 Claude Lévi-Strauss fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi
degli anni Settanta, in Francia, o, per meglio dire, a Parigi, tra gli
intellettuali e gli studenti delle Università parigine era già una
specie di mostro sacro, un autore di cui era obbligatorio conoscere la
vita, le opere principali e aver letto almeno i libri che lo avevano
reso famoso anche presso il grande pubblico, Tristi Tropici e Il pensiero selvaggio: il primo, un racconto di viaggio che si inseriva in una lunga tradizione francese, basti pensare alle Lettere persiane
di Charles-Louis de Montesquieu, e che raccontava dei suoi viaggi di
etnologo in Brasile, presso comunità, come i Nambikwara; il secondo,
uno sguardo eccentrico che dona l'occasione di una visita nel
sottosuolo inquietante del pensiero, dove il progetto d'universalità
della filosofia occidentale appare come “ideologia”, pratica
antropofagica di una coscienza singola o di una certa cultura.
Claude Lévi-Strauss fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi
degli anni Settanta, in Francia, o, per meglio dire, a Parigi, tra gli
intellettuali e gli studenti delle Università parigine era già una
specie di mostro sacro, un autore di cui era obbligatorio conoscere la
vita, le opere principali e aver letto almeno i libri che lo avevano
reso famoso anche presso il grande pubblico, Tristi Tropici e Il pensiero selvaggio: il primo, un racconto di viaggio che si inseriva in una lunga tradizione francese, basti pensare alle Lettere persiane
di Charles-Louis de Montesquieu, e che raccontava dei suoi viaggi di
etnologo in Brasile, presso comunità, come i Nambikwara; il secondo,
uno sguardo eccentrico che dona l'occasione di una visita nel
sottosuolo inquietante del pensiero, dove il progetto d'universalità
della filosofia occidentale appare come “ideologia”, pratica
antropofagica di una coscienza singola o di una certa cultura.