BUSSOLE | QDAT 63 | 2016
LETTURE / I VENERDÌ DEL PETRARCA
di Francisco Rico, Adelphi, Milano, 2016 / pp. 219, € 14,00
Una giornata molto particolare
di Maria Cristina d'Alisa
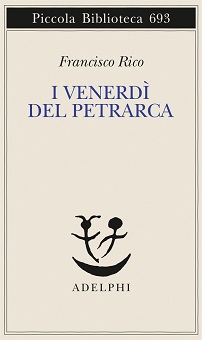
“La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c’è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con la raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù. L’altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l’altra provvisoria e quando il tempo della sua sosta è finito la schiodano, la smontano e la portano via, per trapiantarla nei terreni vaghi d’un’altra mezza città” (Calvino, 1996). Così, nel 1971 Italo Calvino descrive Sofronia, una delle cinquantacinque città invisibili del suo omonimo romanzo. Due mezze città, una del tirassegno e delle giostre, l’altra dei muri di pietra e dei frontoni di marmo. Dove la menzogna? Dove la realtà? In nessuna o in entrambe. L’una in attesa dell’altra e della vita, che ricominci tutta intera.
Il motivo del doppio ricorre in tutta la letteratura, l’arte, la cultura da secoli, quale espressione di identità scissa, dibattuta tra aspirazioni immaginose e pulsioni minacciose, nell’infinita eventualità di soluzioni contrastanti, che manchino la perfetta esecuzione di un destino dall’uomo stesso prefisso. E da secoli percorriamo pagine e storie di identità vibranti di doppi, tripli, multipli, generati dalla tensione a liberarsi dai vincoli oppressivi del vivere quotidiano o dall’opposta ambizione alla costruzione di un sé che, con piglio sovrano, tali vincoli li regga e li domini. Tema, d’altronde, attualissimo quello del timore e del desiderio di sperimentare la magia della trasformazione, che sposa appieno l’anonimato e il confine fluido del post moderno, a partire dal gioco dei contrari della rete. E qui torniamo alla Sofronia di Calvino, non a caso inserita nell’ordine delle città sottili, il cui confine, appunto, sottile, fluido tra due mezze città, riconosce una sopravvivenza necessaria di entrambe le metà, pena l’apnea dell’una nella rincorsa dell’altra.
Se, però, sul proscenio del doppio avanza la timida figura di Francesco Petrarca, inattesa filiazione e deformazione di se stessa nella filigrana delle sue parole, entusiasmante diventa il tentativo di smascherare chi su quel famoso Monte Ventoso aveva intravisto cose che noi umani….
I venerdì del Petrarca, pubblicato di recente dalla collana Piccola Biblioteca Adelphi, nasce come un’indagine in tal senso condotta da Francisco Rico, filologo catalano da tempo interessato agli studi umanistici, su di una costruzione di sé da parte del preumanista per definizione, Francesco Petrarca, per l’appunto.
Nella premessa del testo Rico rimarca una differenza vincolante tra l’attività del romanziere e quella del filologo: “Tu [romanziere, ndr] costruisci una narrazione immaginando dei personaggi […]. A me, invece, tocca fornire un senso a dei dati”. Allora, che resta da fare? Non oltrepassare il documento nella ricerca di consonanze e antitesi tra dati pervenuti? Ebbene, no. Rico obietta come il filologo abbia “l’obbligo di comprendere ed illuminare i chiaroscuri della materia bruta che si trova tra le mani”. Ma questo con la restrizione di non inventare personaggi, bensì di comprendere uomini. Se poi dell’uomo in questione sappiamo essenzialmente attraverso la sua stessa voce, se l’opera letteraria di Petrarca si determina come principale fonte per abbozzare la sua biografia perché nei suoi scritti ha raccontato quasi ogni episodio lo riguardasse, il discrimine tra verità e costruzione del sé diventa, non a caso, sottile.
“L’uomo piglia a materia anche se stesso, e si costruisce, sissignori, come una casa. Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? […] io non mi riconosco nella forma che mi date voi, né voi in quella che vi do io”. (Pirandello, 1994). Se, di certo, è innata in ciascuno l’urgenza di costruire, trasformare, adattare l’io cosciente a un copione di riferimento, come Pirandello, primo tra tutti, teorizzò, per Petrarca il discorso declina verso direzioni inaspettate. Petrarca, più di Dante o di altri letterati medievali, ci ha rifilato impietosamente le sue letture, gli incontri illustri con i Colonna, i Visconti e altre famiglie signorili di mezza Italia, le sue passioni stravaganti per giardinaggio e monete antiche, la simpatia per la politica ribollente di Cola di Rienzo, le amicizie dal sapore ora mistico e ora laico, gli amori beatamente metafisici e quelli turpemente libidinosi. Dal Canzoniere ai Trionfi, passando per il Secretum e le Lettere, nei “titoli di coda” non ci si può sbagliare, ogni pagina è di, su, con … Francesco Petrarca. Ma qui si apre una questione delicata. Pochi sembrano aver avuto la precisa intenzionalità dell’Aretino nell’animare un’azione scenica in cui la pagina scritta determinasse la vita o fosse da essa determinata. Eh, sì, perché Petrarca visse talvolta degli eventi come immaginava li avesse scritti. Di converso, scrisse eventi come immaginava li avesse vissuti.
Rico circoscrive un punto preciso da cui avviare un’indagine sul fenomeno della costruzione piuttosto che della narrazione del sé, nell’ambito della generosa produzione attribuibile all’Aretino. Un punto preciso, il venerdì. E bando a prevedibili spasmi. Perché, scrive Rico “i tanti venerdì del Petrarca riconoscibili come qualcosa di più di una semplice coincidenza cronologica sono un caso estremo ma non unico. Nulla di ciò che racconta Petrarca è letterale, nulla è innocente”. Dietro le quinte del suo lavoro letterario si può assistere a una matematica dispositio in cui numeri, nomi, eventi si intrecciano in un significato che travalica il significante e determina un disegno d’insieme ideato a priori. Partiamo dal Canzoniere, da quel primo venerdì.
Benedetto sia'l giorno, e'l mese, et l'anno
et la stagione, e'l tempo, et l'ora, e'l punto
e'l bel paese, e'l loco ov'io fui giunto
da'duo begli occhi che legato m'ànno
(Petrarca, 1985)
Chiesa di Santa Chiara ad Avignone, fatalità di un incontro. Una donna dai biondi capelli, una brezza di primavera, il figlio di Venere a combinare destini, una freccia che scocca lunga la traiettoria del caso, e la vita cambia, con quel pensiero che si avvita ossessivamente su di una strana melodia L-a-u-r-a, l’a-u-r-a, l-a-u-r-e-a. Una donna, un sospiro, un’incoronazione al profumo d’alloro. Un sapido gioco di rimandi. Proviamo a ricostruire la data esatta di quel tempo non comune, prendendo le mosse da qualcuno degli indizi analizzati da Rico.
Or volge, Signor mio, l'undecimo anno
ch'i' fui sommesso al dispietato giogo
[…]
Miserere del mio non degno affanno;
reduci i pensier vaghi a miglior luogo;
ramenta lor come oggi fusti in croce
(ibidem)
La data per eccellenza sembrerebbe coincidere con un venerdì, il giorno della crocifissione di Cristo, quello in cui più sarebbe risaltato come “giovenile errore” (ibidem) l’amore per Laura piuttosto che per quel Dio a cui Petrarca premeva di affidare la bussola, da sempre disorientata, di se stesso. Un venerdì qualsiasi. Non il venerdì santo. Verosimilmente, nella convinzione che tutti i venerdì ammonissero a misurare la giusta distanza dallo sviamento. Eppure…
mille trecento ventisette, a punto
su l'ora prima, il dì sesto d'aprile,
nel laberinto intrai, né veggio ond'esca
(ibidem)
Il sonetto CCXI ci proietta verso il 6 aprile del 1327. Un lunedì, nel calendario storico del 1327. Non un venerdì. Ed è qui che si stende la penombra dell’umano dubbio. Petrarca non poteva non sapere che quel giorno, scandito con tanta nettezza di dettagli, fosse un lunedì. Era un cappellano e arcidiacono, consultava tavole pasquali, aveva dimestichezza con i computi ecclesiastici, era un uomo la cui memoria aveva spesso sfidato date e dati. Sarebbe stato un incidente troppo banale o un’amnesia dalla crudeltà sinistra. Ma, dietro quella svista apparente, intravediamo il suo scalpello intento furtivamente ad arabescare la materia della sua stessa vita. Quel 6 aprile 1327 “non si riferiva a un venerdì di quel calendario che condivideva con il resto dei comuni mortali”, precisa Rico. Era una sua costruzione, il venerdì, il giorno in cui, a prescindere da ogni esattezza pitagorica, si sarebbe dovuto celebrare quell’incontro e, con esso, tutti gli eventi capitali della propria parabola esistenziale.
Il rebus non si arresta alla data di incontro. Il 19 maggio 1348, Petrarca viene raggiunto a Parma dalla notizia della morte di Laura. Ai margini di un manoscritto contenente le opere del poeta Virgilio, a lui molto caro, il Virgiliano ambrosiano, scrive:
“Laura, a lungo cantata per la fama delle sue virtù nei miei versi, mi apparve per la prima volta davanti agli occhi sul principio della mia giovinezza, nell’anno del Signore 1327, sesto giorno del mese di aprile, ad Avignone, nella chiesa di Santa Chiara, ora del mattutino, e nella stessa città, stesso mese di aprile, stesso giorno sesto e stessa ora prima, ma dell’anno 1348, quella luce fu strappata alla luce” (citato in Rico, 2016).
Laura scompare nello stesso giorno dell’incontro, eodem menso Aprili, eodem die sexto, nello stesso mese di aprile, nello stesso giorno sesto. A sfogliare un calendario del tempo, l’indice si poserebbe su di una domenica. E, però, se con dies sextus Petrarca ardisse a un nuovo depistaggio di date e intendesse non il sesto giorno del mese, ma un venerdì? Domenica, primo giorno della settimana liturgica, perché giorno di resurrezione; ora, 1,2,3,4… un rapido conto a sei ci porterebbe al venerdì, dies sextus. Scenario quanto mai intrigante, a cui Rico ammicca come ulteriore, possibile, conferma di un altro fatidico venerdì, quello di una sottrazione.
“Il venerdì del Petrarca […] non è il venerdì nefasto della superstizione popolare – scrive Rico – né solamente il venerdì devoto del cristiano: è il giorno che non passa inosservato, senza far sentire la propria singolarità […] È quindi uno degli archetipi e termini di paragone che servono a Francesco per situarsi nel mondo”. Allora, Rico ci sottopone una trama di molteplici sequenze, tutte obbedienti al simpatico capriccio del venerdì.
Giovanni, il figlio della “sconvenienza”, viene a mancare il giorno 10 luglio. O, almeno, è quello che le fonti ci riferiscono. Perché Petrarca ne colloca la fine tra “il 10 o il 9 luglio, nel mezzo della notte tra venerdì e sabato”. Neppure allora Petrarca molla la presa rispetto al dogma del venerdì. Ancora, il venerdì è giorno deputato, ai digiuni, alle penitenze, alla rifinitura dei suoi scritti; è il giorno in cui riceve a Valchiusa l’ispirazione del poema epico che gli valse l’incoronazione romana del 1341, l’Africa, incoronazione della cui notizia viene a sapere il 1º settembre 1340, neanche a dirlo, un venerdì. E la girandola dei venerdì, tra quelli santi, quelli mezzi santi, quelli ordinari e quelli da tirarsi dietro pure qualche imprecazione di un lettore dal commento chiassoso, ruota trionfalmente nell’estasiato incanto del suo giostraio.
Ma è realmente da interpretare come gioco leggero, questo vivere nella ricorrenza del venerdì? Andiamo alla lettera IV 1, 55-60 delle Familiares, all’illusionistica ascesa al Monte Ventoso, quella per cui tutti avremmo scommesso su di un fragoroso scivolone di Petrarca, lungo l’indesignabile crinale di quell’altura (come della vita).
La scoperta motivazione di quel viaggio sta nell’ulissiaca curiositas di vedere da quel rilievo la meraviglia di un confine alpino, ma quella cima, una volta raggiunta, riserva la sorpresa di un esame di coscienza fatalmente significativo.
Petrarca focalizza il doppio che è in lui, quella gioventù abbandonata alla colpa dei bassi piaceri terreni, alla cecità dell’accidia, alla stupita seduzione dell’amore, in dibattito contro il suo incalzante rovescio, “Ciò che ero solito amare, non amo più […] Amo tuttavia, ma contro voglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza” (Petrarca, 1994). Da qui l’intenzione di un rinnovamento che superi il conflitto del doppio, che sbaragli ogni fragilità inappagata e inquieta, le piaghe di un amore tutto terreno per Laura e per la gloria poetica, per cedere il passo a quell’alieno iperspazio che solo l’ascesi sa promettere.
Ora, che questo dibattimento non abbia mai conosciuto soluzioni definitive, perché Petrarca a dormire sugli “allori” a lui tanto cari non avrebbe mai rinunciato, in questa sede poco conta. Il dato è un altro. La data, 26 aprile 1336. Ancora un venerdì. Gli studi petrarcheschi ammettono che la data di composizione di una lettera così determinante nella conversione alla spietata tirannia dello spirito fosse stata di gran lunga posteriore, primi anni Cinquanta del Trecento. Questo implica che l’Aretino si sia cercato intenzionalmente l’ennesimo venerdì utile per collocarvi la sua rivoluzionaria proposizione di vita. Però qui non meraviglia l’ormai snervante scelta del venerdì, ma il fatto che quella collocazione temporale, scrive Rico, fosse un “dato privato, invisibile ai lettori, che aveva significato esclusivamente per Petrarca”. Quel venerdì acquisisce un senso solo per l’autore, compete alla sua intimità. Perché allora una scelta simile perfino laddove lo sguardo del lettore non potrà mai arrivare? Rico una spiegazione se la dà, e ha il colore pungente di un sussulto. Ve lo ricordate il Francesco Petrarca dalla bella pagina perfettamente cesellata negli intarsi di un sonetto? Quello dalla lingua virtuosistica e così incomprensibilmente struggente per noi tra i nostri banchi di scuola? Sì, quello che si è inventato la lirica d’amore, ma nell’insostenibile aspirazione a dimenticarselo, questo amore, in nome di un’utopia avventurosa, sulla rotta del Paradiso e nella garanzia del nome del Signore? Ebbene, dimentichiamoci tutti il nitore di quella perfezione. Petrarca era uno di noi, pur con l’opzionale risorsa della chiacchiera preziosa. Uno che provava a vivere la vita così come se l’era scritta nei suoi testi, per aggrapparsi alla rassicurante certezza di una data, un giorno, una lettura importante, una citazione dotta, che ascrivessero un perimetro alla sua natura e a quel tempo fugace, pronto a esplodere in ogni direzione. Identico a sé, nell’immagine affidata alle sue pagine; sempre diverso da sé, nella irreversibile fragilità e arrendevolezza della sua quotidiana essenza. Tremendamente disperato mentre insegue, nella logica rigorosa del venerdì, un’armonia a sé negata e un arresto alla metamorfosi del tempo. Una perfetta costruzione di sé che di perfetto contempla solo l’imperfezione di un’anima fragile, nella riprova avvilente, quanto più illustre l’esempio, che non si vive mai come si pensa (figuriamoci, come si scrive!).
Il sospetto è un altro, quanto il poeta sia riuscito davvero nel suo intento. Ma qui la domanda va girata a “Giovannino” il gaudente. Lo stesso Rico, nel saggio Ritratti allo specchio, ci racconta di una amicizia affezionata tra Petrarca e Boccaccio, pur in un rapporto di netta disparità. Per il poeta aretino il novelliere di Certaldo é “a volte come un servitore e a volte come un fratello. Un fratello minore e meno dotato, al quale senza dubbio si vuole un bene dell’anima, ma della cui docilità si beneficia e si abusa perfino […], dinanzi al quale si controllano le confidenze che gli si fanno e l’intimità che gli si accorda” (Rico, 2012). In Petrarca, viceversa, Boccaccio, quel buontempone!, ravvisa un padre e un maestro, un “divinus homo”, un “celestis homo” (ibidem), e ci fermiamo qui, nella sconfinata prospettiva di qualche eccetera di troppo. Eppure, Boccaccio non ha accesso privilegiato agli scritti dell’Aretino. Pertanto, deve accontentarsi solo di quanto di Petrarca pubblicato, pagine su cui si dimena goffamente tra lodi superlative, non avendo letto neanche poi tutto e neanche poi molto. Ma al novelliere Petrarca sta trasmettendo, pur nella bonaria accettazione di un qualem tu me tibi fingis, “come tu mi vuoi” (ibidem), una ben sorvegliata immagine di sé. E Boccaccio ci casca.
Rico ci riporta, non a caso, alcuni passi del De vita, una biografia encomiastica che Boccaccio dedica al Petrarca, in cui la descrizione dell’Aretino va ben oltre la più ossequiosa deferenza e la più miracolosa idealizzazione:
Il poeta Francesco di Petracco, uomo illustre oltre che splendido per stile di vita e dottrina, si è affermato con inclita fama in tutto il mondo sotto il pontificato di Benedetto XII.
Cristiano scrupolosissimo, tanto che a stento potrebbe credersi se non per evenienza e conoscenza. Solo dalla libidine è stato, non dico tutto vinto, ma alquanto molestato; però se a volte gli accade di soccombervi, almeno egli ha saputo […] fare cautamente quanto non ha potuto castamente. (ibidem).
Il De vita fu redatto durante gli anni quaranta del Trecento, ancor prima della conoscenza diretta dei due, avvenuta all’incirca negli anni Cinquanta, ma tradisce un fascino crescente per quel poeta che pure il Certaldese aveva potuto immaginarsi attraverso poche letture e ancor meno notizie. L’atmosfera è quella da “santo, subito”. Francesco, integro in pensieri, parole, opere e (perfino!) omissioni. Perché anche nel peccato sa mantenersi, se non casto, cauto. Paradigma impareggiabile di ogni bene, viene descritto a Valchiusa come in un processo intrapreso vissuto e concluso, di assoluta perfezione, “l’uomo giusto che non si dedica ad altro che alle cose eterne” (ibidem). La stessa Valchiusa prossima al Ventoso, quella – nei fatti – di un’ascesa un po’ zoppicante dell’Aretino, al punto da doverla allineare a un rassicurante venerdì.
Ma la mitizzazione non si ferma qui. Rico presenta lo stesso Corbaccio, satira antifemminile scritta negli anni della maturità dal Certaldese, come emulazione di un’opera cruciale del Petrarca, il Secretum. Se quest’ultima inscena un dialogo segreto tra Francesco e Agostino, grazie a cui il poeta si propone poi la rinuncia eterna ai vizi mondani, primi fra tutti, quella passione irrimediabile per Laura e la gloria poetica, Boccaccio nel Corbaccio sembra parimenti ritrattare e ribaltare completamente il contenuto “prosaico” del Decamenon e la passione per quelle donne a cui pure le novelle andavano in dedica. Con un solo proposito, affidarsi unicamente ai suoi studi. E, se noi sospettiamo che Giovannino fosse stato colto dal timore attardato di chissà quale dies irae, altri, più informati di noi, ascrivono la folgorazione alla carica di chierico ricevuta in tarda età. Viceversa, Rico ci proietta oltre. “Il Corbaccio è il Secretum di Boccaccio” (ibidem). Ecco, dunque, che i quarant’anni, presi a momento di svolta fin dalle biografie bibliche, stranamente accomunano il rinnovamento di entrambi i protagonisti delle opere in questione. Questo, malgrado sappiamo per certo che Petrarca e Boccaccio scrissero le opere del cambiamento ben oltre, per l’appunto, i loro quarant’anni. Veniamo alla tematica, entrambi diventano testimoni d’accusa delle loro stesse profane miserie? Nessuna protesta, ad ambedue resta solo spazio per il beneficio provvidenziale del mea culpa. In questi richiami, Rico ci vede più di una impertinente coincidenza. Verosimilmente Boccaccio non lesse mai il Secretum, ma ne fu reso partecipe dalle conversazioni con Petrarca. Pertanto, “non dobbiamo piuttosto presumere che […] Petrarca avesse necessariamente cercato di plasmare Boccaccio, come fece in tanti altri ambiti, a immagine e somiglianza della sua stessa biografia ideale?” (ibidem). Insomma, Petrarca ci pare aver vinto la sfida “di costruirsi in personaggio ideale e ad edificarsi, in vita, un mausoleo” (Santagata, 1992).
Eccoci al punto, Petrarca ha saputo suggerire un’immagine misurata di sé, mai tradendo l’imprevisto, il capriccio, l’arbitrio di quell’intima fragilità bisognosa, invece, del punto fermo di qualche venerdì come riferimento e come certezza. Boccaccio si affida a quella perfezione strombazzata, e la devozione al modello idealizzato diventa cieca e definitiva. Dove la verità? Dove la menzogna? L’interrogazione di partenza, la Sofronia calviniana, le due metà, una che attende l’altra, e che la vita ricominci tutta intera. Sì, perché, in fondo, ci piace immaginarceli così, quei due, nell’Oltretomba… Giovannino, col fiatone delle mille e una crapula, a inseguire, incespicante, l’apollineo Francesco. Francesco, alla caccia del primo venerdì utile per seminare quel gran seccatore, fuggirsene nelle Isole dei Beati e godersi finalmente il fine settimana. Né caste e né caute.
LETTURE
— Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano, 1996.
— Francesco Petrarca, Canzoniere, Oscar Mondadori, Milano, 1985.
— Francesco Petrarca, Le Familiari, Archivio Guido Izzi, Roma, 1994.
— Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Feltrinelli, Milano, 1993.
— Francisco Rico, Ritratti allo specchio, Antenore, Roma-Padova, 2012.
— Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, il Mulino, Bologna, 1992.
