BUSSOLE | QDAT 63 | 2016
LETTURE / L’ARTEFICE
di Jorge Luis Borges / Adelphi, Milano, 2016 / pp. 220, € 12,00
Quando un cieco vede Dio
di Livio Santoro
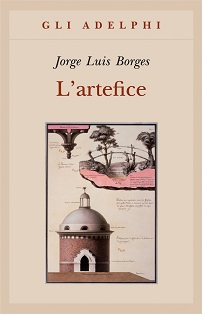
Come tutte le idee, anche quella che per noi riassume l’immagine di Jorge Luis Borges esibisce una serie di attributi, elementi parziali che concorrono a descrivere o designare un insieme regolativo più grande. Tra questi attributi (s’intenda quelli propri dell’eidetico Borges), c’è ovviamente la cecità, quel “lento crepuscolo estivo”, come lo stesso Borges ebbe a definirla nel suo Abbozzo di autobiografia (1998) e in una delle sue famose Conversazioni americane (1984), avuta con Dick Cavett nel 1980, che gradualmente, negli anni, lo pose per prossimità dalla parte della dissolvenza infinita propria di un occaso similmente ideale: la sua cecità, fardello genetico o semplice eredità degli avi, non fu infatti totale, non fu oscurità del nero sul nero; fu invece “nebbia luminosa […] grigiastra o bluastra” (ibidem), forse simile a quella che s’imprime senza possibilità di rimedio negli specchi, quando questi terribili eppure cari strumenti di moltiplicazione del reale invecchiano grazie all’ossidazione dell’argento vetusto.
Il ruolo che la cecità assunse nel lavoro letterario di Borges, infatti, non è per nulla secondario, se è vero che anche a tale attributo dobbiamo, a partire dal 1955 circa, il suo ritorno in età matura alla poesia, già frequentata ampiamente nell’avanguardistica gioventù da ultraista, e il suo rinnovato rivolgimento verso la prosa brevissima: in entrambi i casi prende corpo la tendenza di Borges a scrivere in mente, senza il confortante supporto materiale della carta e della penna, ma soltanto con quello diafano ed evanescente proprio della memoria.
“Una delle principali conseguenze della mia cecità” scrive infatti Borges nel succitato Abbozzo di autobiografia “fu il mio graduale abbandono del verso sciolto in favore della metrica classica. Anzi, la cecità mi fece tornare alla poesia. Poiché non potevo più fare una prima stesura, dovevo affidarmi alla memoria. Ovviamente è più facile ricordare dei versi piuttosto che della prosa, e ricordare un metro regolare piuttosto che versi sciolti” (Borges, 1998).
Certo, è pur vero che Borges non è mai stato avvezzo alla narrazione lunga e totale caratteristica del romanzo, avendo invece sempre preferito l’arte del dettaglio (come tra gli altri ricorda Alan Pauls nel suo Il fattore Borges, da poco pubblicato in traduzione qui da noi), della sintesi e del singolo momento come cifra di un’intera esistenza narrativa: la pratica gratificante, mai rivolta alla stesura di pagine inerti, del saggio narrativo breve, del racconto e di quella che abbiamo poi imparato a chiamare microfinzione.
Tuttavia L’artefice, raccolta appena ristampata da Adelphi di prose brevissime e poesie in metrica tradizionale (sonetti italiani ed elisabettiani, quartine di endecasillabi rimati) di cui adesso vogliamo parlare, è esattamente un libro figlio della condizione imposta a Borges dalla sopraggiunta cecità, almeno stando alle parole dello stesso autore. Scritto (pensato, assemblato, ricordato) nel 1960, quando lo scrittore aveva ormai varcato la soglia del suo sessantesimo anno di età, L’artefice racchiude molti appunti vecchi degli anni precedenti e molti stesi ex novo.
Si tratta di un libro che, all’epoca della sua originaria uscita, interruppe il silenzio editoriale di Borges, un libro espressamente richiestogli dall’editore Emecé: fu proprio questi a suggerire a Borges di cercare tra i suoi scaffali e i suoi cassetti tutti quei fogli sparsi e quelle note che sicuramente esistevano e che egli mai aveva messo in un ordine coerente, per dare così alle stampe un libro nuovo, e quindi soddisfare l’appetito del mercato e degli affamati lettori. Nonostante una simile genesi, o forse proprio grazie a essa, Borges, che seguendo il suggerimento dell’editore cercò tra cassetti e scaffali, assemblò un volume che lui stesso non ha esitato a definire “il mio lavoro più personale e forse, a mio gusto, il migliore” (Borges, 1998). Esattamente per quanto si è detto finora, L’artefice è un libro che di certo non lascia sorpreso il lettore borgesiano: vi albergano infatti tutti i temi più intimi della produzione di Borges, già affrontati da differenti prospettive nei suoi testi precedenti e ovviamente rielaborati poi nel futuro che sarebbe venuto con gli altri volumi. Il sogno, per esempio, o l’ineffabile essenza del tempo ritratta in elegie e commenti eraclitei. Ma anche l’innocente ferocia dei pugnali e dei carnefici, il ricorso al truce quanto affascinante mondo della mitologica norrena, il gusto per l’apocrifo e, infine, la discussione ironica, travestita da classica riflessione ontologica, sull’essenza dell’essere e di Dio, e sulle capacità logiche e conoscitive che, in quanto umani, ci sono date per accedervi.
Prendiamo proprio l’ultimo tema della riflessione ontologica, presentato ne L’artefice tramite soprattutto una squisita prosa breve, forse tra le più conosciute di Borges. Si tratta di Argumentum ornithologicum, un piccolo pseudo-saggio che può forse rappresentare la misura dell’intero lavoro dell’argentino e che di certo può essere qui riportato per intero. Ecco cosa dice Argumentum ornithologicum:
“Chiudo gli occhi e vedo uno stormo di uccelli. La visione dura un secondo o forse meno; non so quanti uccelli ho visto. Era definito o indefinito il loro numero? Il problema implica quello dell’esistenza di Dio. Se Dio esiste, quel numero è definito, perché Dio sa quanti uccelli ho visto. Se Dio non esiste, quel numero è indefinito, perché nessuno ha potuto contarli. In questo caso, ho visto meno di dieci uccelli (diciamo) e più di uno, ma non nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre o due uccelli. Ne ho visti un numero fra dieci e uno, un numero che non è nove, né otto, né sette, né sei, né cinque, eccetera. Questo numero intero è inconcepibile; ergo, Dio esiste”.
Tralasciando la discussione sulla natura divina delle manifestazioni ornitologiche su cui Borges ha pure spesso insistito, si prenda per esempio Il Simurg (Borges e Guerrero, 2006) o Il Simurg e l’Aquila (Borges, 2001), restiamo sul nostro Argumentum.
Nel leggerlo ci si sarà resi conto che a Borges sta a cuore parodiare, con il dovuto senso del rispetto per chi comunque ha fatto letteratura, letteratura per di più immortale, gli animatori del dibattito sugli universali di matrice scolastica, l’estenuante giustificazione di Dio che ha fiaccato il pensiero occidentale per centinaia di anni, rinchiudendolo in ombrosi monasteri fin quando, proprio da quei monasteri, alcuni eretici assennati cominciarono a guardare al mondo in maniera rinnovata e meno conforme alla tradizione. L’Argumentum ornithologicum sembra infatti fare il verso alla vecchia dichiarazione cui Anselmo d’Aosta, quello che poi per la cristianità sarebbe diventato Sant’Anselmo, aveva affidato la sua fideistica (chiaro!) prova ontologica dell’esistenza di Dio, che ora riportiamo fedelmente e con la necessaria pedanteria:
“Ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere solo nell’intelletto. Infatti, se esistesse solo nell’intelletto, si potrebbe pensare che esistesse anche nella realtà, e questo sarebbe più grande. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste solo nell’intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Il che è contraddittorio. Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore e nell’intelletto e nella realtà. […] E questo ente esiste in modo così vero che non può neppure essere pensato non esistente. Infatti si può pensare che esista qualche cosa che non può essere pensato non esistente; e questo è maggiore di ciò che può essere pensato non esistente. Onde se ciò di cui non si può pensare il maggiore può essere pensato non esistente, esso non sarà più ciò di cui non si può pensare il maggiore, il che è contraddittorio. Dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste in modo così vero, che non può neppure essere pensato non esistente. E questo sei tu, o Signore Dio nostro” (Anselmo d’Aosta, 1969).
Che cosa ha fatto dunque Borges entrando a gamba tesa (come si direbbe se non si avesse contezza del contesto in cui ci si muove), dopo secoli dalla sua estinzione, nel dibattito ontologico di gusto scolastico sull’esistenza di Dio? Ha inteso forse soltanto prendersi gioco del povero Anselmo, di tutti i suoi amici, monaci o meno, e dell’arrogante utilizzo della formula conclusiva “quod erat demonstrandum”? Ha inteso ridicolizzare un certo tipo di pensiero cocciuto volto all’inveterata giustificazione dell’assoluto per supportare fini mondani di potere e dominio?
Fino in fondo, forse, non lo sapremo mai. Sappiamo però che, nel suo Argumentum, Borges espone un ragionamento formalmente e logicamente corretto che, stando ai parametri scolastici, potrebbe senza problemi comparire in un compendio di ontologia medievale: utilizza infatti l’argomentazione sillogistica, il principio di non contraddizione, la dimostrazione per assurdo, il succitato come volevasi dimostrare e, soprattutto, termina con la dimostrazione incontrovertibile dell’esistenza di Dio.
La faccenda potrebbe chiudersi qui, se non fosse che Borges inserisce nel suo breve scritto un elemento spaesante che, se contestualizzato nel volume in cui l’Argumentum compare, ci porta verso dissimili lidi di ermeneutica. Parliamo dell’incipit del testo, un principio di gioco gustoso che fin dal principio ci rende dubbiosi: “Chiudo gli occhi e vedo uno stormo di uccelli” dice il narratore. Dunque la visione degli uccelli da cui ha origine tutto è, come risulta chiaro, successiva alla chiusura degli occhi. Al che il lettore è portato a chiedersi: si tratta di una visione reale o di una visione fittizia, di un’immagine che fotografa un pezzo della realtà così com’è data alla percezione o di un’immagine che proviene dal mondo intrapsichico del narratore? E vi è reale differenza, per dimostrare l’esistenza di Dio, tra la realtà esterna al soggetto e il suo mondo intrapsichico? E che pensare, poi, quando si sa (ci si rende conto) che l’autore che dà voce al narratore si trova ormai nelle profondità di “un lento crepuscolo estivo”?
Ecco, forse, la vera questione.
LETTURE
— Anselmo d’Aosta, Proslogio, in Opere filosofiche, Laterza, Roma Bari, 1969.
— Jorge Luis Borges, Abbozzo di autobiografia, in Elogio dell’ombra, Einaudi, Torino, 1998.
— Jorge Luis Borges, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma, 1984.
— Jorge Luis Borges, Nove saggi danteschi, Adelphi, Milano, 2001.
— Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero, Il libro degli esseri immaginari, Adelphi, Milano, 2006.
— Alan Pauls, Il fattore Borges, Sur, Roma, 2016.
