- di Adolfo Fattori
- SOMMARIO

“Un telefono squillò nel buio. Quando ebbe suonato tre volte, le molle di un letto gemettero, le dita di una mano si mossero a tentoni sul legno, un piccolo oggetto pesante cadde con un rumore sordo su un tappeto, le molle gemettero ancora, e una voce d’uomo disse:
«Pronto… Sì, con chi parlo… Morto?… Sì… Un quarto d’ora. Grazie»
Un interruttore scattò e un globo bianco appeso al centro del soffitto con tre catene dorate riempì di luce la stanza”
(Hammett, 1980).
Primi piani. L’uno dopo l’altro: un
telefono, una mano che si muove tastoni, una cornetta che viene presa e
sollevata (la immaginiamo: è anche inutile richiamarla per
iscritto). Suoni: lo squillo di un telefono (di quel telefono),
cigolii, un leggero tonfo, una voce umana. Fotografia: il buio, con
qualche lama di penombra che filtra dall’esterno attraverso
una veneziana, giusto per illuminare le dita che brancolano alla
ricerca del telefono; poi il campo si allarga, il quadro si illumina:
la luce, forte, di un lampadario centrale.
Un brano di
sceneggiatura, giusto da rifinire, si direbbe. E invece no:
è il frammento di un romanzo, una scrittura costruita per
essere stampata e venduta in libreria o in edicola.
Pure,
è già pronta per fare da sorgente della scrittura
per il cinema, a riprova di quanto, già dopo poco
più di un trentennio di vita, il cinema ispirasse le
modalità con cui immaginiamo e trascriviamo le storie, nella
loro trasformazione in racconti. E che infatti verrà
trasferita letteralmente nella sceneggiatura di un film.
L’estratto
proviene da Il falcone maltese (The
Maltese Falcon), pubblicato fra il 1929 e il 1930 su rivista,
e poi, sempre nel 1930, in volume da libreria, il terzo romanzo di
Dashiell Hammett, il “fondatore” del poliziesco hard-boiled,
che costruì la sua fama proprio a partire dalle riviste pulp,
in questo caso Black Mask, e da cui vennero tratte
ben tre versioni cinematografiche: nel 1931, nel 1936, poi nel 1941, la
più famosa, uno dei monumenti del cinema classico americano,
se non del cinema tout court. E il fatto che
nell'arco di un solo decennio la produzione, sempre la Warner Bros.,
decise per ben tre versioni dello stesso film è una prima
prova di come questa narrazione fosse destinata a occupare una
posizione stabile nell'immaginario collettivo, a diventare un vero
monumento della cultura di massa, denso com’è di
elementi e luoghi dell’immaginazione cui allude, grazie alla
fedeltà con il romanzo, d’altra parte, ma con in
più la straordinaria potenza evocatrice del cinema in uno
dei suoi momenti di massima espansione.
In Italia
il romanzo sarebbe stato poi pubblicato nel 1953 da Longanesi, e solo
nel 1984 da Mondadori, che però ne cambiò,
chissà perché il titolo in Il falco
maltese, in una traduzione totalmente nuova e finalmente
scorrevole e realistica, rispetto alla legnosità e alla
rozzezza della prima.
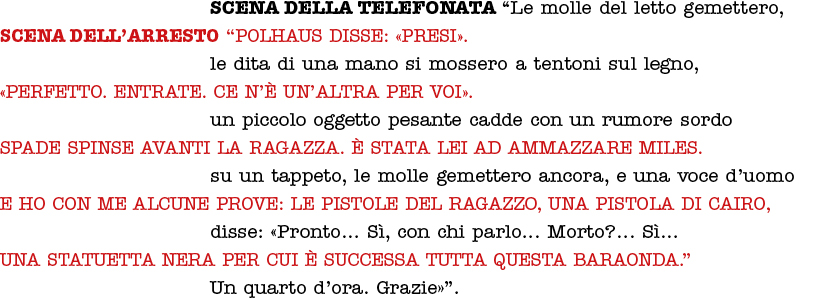
La prima versione (The Maltese Falcon,
stesso titolo del romanzo), diretta da Roy Del Ruth, fedele al romanzo
fin nella riproduzione di molti dei dialoghi, incappò nelle
maglie del “Codice Hays” (il codice di
autodisciplina che si imposero le case di produzione cinematografiche
hollywoodiane per governare i riferimenti al sesso nei film),
così che nel 1934 alcune sequenze furono tagliate (quella
con la protagonista femminile, Bebe Daniels, nuda sotto la doccia,
quelle con dialoghi vagamente allusivi sull'omosessualità) e
quando, nel 1936, la Warner provò a ridistribuire la
pellicola nelle sale nella sua versione originale la censura la
bloccò, inducendo la produzione a girare un nuovo film, un
adattamento ampiamente distante dal romanzo diretto da William Dieterle
(uno dei tanti profughi di talento arrivati dalla Mitteleuropa per
sfuggire ai macellai nazisti) con Bette Davis: Il diavolo e
la signora (Satan Met a Lady, girato in
uno stile leggero, piuttosto lontano dallo spirito del noir),
che però non lasciò particolari tracce.
E
così, alla fine, la Warner nel 1941 decise di produrre un
nuovo film facendo tutto daccapo; prova decisiva di quanto
l’apparato hollywoodiano puntasse sulla forza di quella
narrazione.
Come a volte capita, il mito nasce anche dalle
circostanze e dalle coincidenze: così, per la nuova
pellicola fu scelto come sceneggiatore un giovane John Huston, e il suo
lavoro piacque tanto che gli fu proposta la regia del film. Huston, che
non aveva mai fatto il regista, accettò, regalandoci un
capolavoro, e avviando una carriera che ne avrebbe fatto uno dei
giganti del cinema di tutti i tempi. Discorso simile vale per Humphrey
Bogart, scelto per ripiego, e destinato a diventare per
sempre il volto dell’investigatore Sam
Spade, dopo che George Raft aveva rifiutato la parte di
protagonista non fidandosi di uno sceneggiatore alla sua prima
regia…
La trama ruota intorno ad una favolosa
statuetta dal valore inestimabile: un falcone d’oro
tempestato di pietre preziose e ricoperto di una patina di vernice per
nasconderne il valore, donato nel XVI secolo dai Cavalieri di Malta
all’imperatore Carlo V. Un gruppo di avventurieri
è a caccia del falcone da anni, e pensa di averlo finalmente
individuato. Questa caccia provocherà l’assassinio
di Miles Archer (Jerome Cowan), il socio di Sam Spade che, indagando,
scoprirà tutta la trama e individuerà
l’omicida del socio, Brigid O'Shaughnessy (Mary Astor) la femme
fatale di cui si è innamorato, anche lei a caccia
della statuetta, donna che nel finale consegnerà alla legge.
L’andamento
della sceneggiatura è estremamente fedele
all’intreccio del romanzo, e riesce a renderne il tono teso,
urgente, veloce, scarno, come peraltro nella tradizione della hard-boiled
school, la scuola narrativa “dei duri”
promossa e ospitata da Black Mask.
Rivelazioni, colpi di scena e sorprese che permettono di
ricostruire gli intrighi e il marcio sottostanti alla ricerca
scandiscono il flusso della narrazione, girata pressoché
tutta in interni a causa del basso budget concesso a John Huston, ma
che permise a quest’ultimo e al suo direttore della
fotografia, Arthur Edelson, di assicurare il timbro claustrofobico e
cupo che il regista voleva creare.
Così,
dopo un testo pseudostorico che fa da introduzione dotta e scorre
subito dopo i titoli di testa, in cui viene narrata la storia della
preziosa statuetta, l’ingresso nell’ufficio dei due
private eyes della O'Shaughnessy che li ingaggia
cercando di ingannarli con una storia inventata, l’omicidio
di Archer e la sequenza che abbiamo citato (dal romanzo) più
sopra, la vicenda comincia a viaggiare e si dipana seguendo Sam Spade.
Noi spettatori, sembra, sappiamo tutto quello che sa lui, quello che
vede, ciò che gli viene raccontato. Alla fine, scopriremo
che c’è dell’altro: alla individuazione
dell’omicida del suo socio Spade è arrivato col
ragionamento, e forse nello stesso modo ha capito che la statuetta di
cui si è ritrovato in possesso è un banale falso.
Non lo dichiara esplicitamente, per lui lo fanno i due avventurieri che
la cercavano, ma il sospetto in noi rimane…
La
fusione di azione e ragionamento era un tipico tratto dell’hard-boiled
school, che alla tradizione del giallo
“all’inglese” aggiungeva la consuetudine
al movimento, al duello, al confronto fatto di pugni e pistole presi
dal western, e che farà la fortuna del cinema delle
“giungle urbane”. Los Angeles, prima di tutte le
altre, quando il miglior allievo di Hammett, Raymond Chandler,
reincarnerà Sam Spade in Philip Marlowe trasferendo
l’hard-boiled crime nella
“città degli angeli” e rifinendone e
prosciugandone i tratti in un personaggio disincantato, nichilista,
solitario, e scolpendone definitivamente il mito.
Ecco, la
dimensione mitica che avvolge la pellicola di John Huston è
fatta sicuramente della purezza elementare della storia che viene
raccontata, degli idealtipi che mette in scena, l’eroe, la
donna fatale, la ricerca, l’esotismo, ma anche
dell’aura che tutti i materiali appartenenti più
al profilmico che al film in sé gli conferiscono, dalla
circostanza della prima regia di Huston all’inaugurazione di
un genere narrativo e cinematografico che poi sarebbe stato
sacralizzato dall’incontro di una città (Los
Angeles) e di un personaggio (Philip Marlowe) che si sarebbero poi
spinti fino alla contemporaneità con i romanzi di James
Ellroy e una pellicola come Blade Runner (1982).
La
stessa statuetta usata nel film (siamo sempre nel profilmico)
è diventata un oggetto di culto. Realizzata in due copie,
una delle due è stata venduta in un’asta per
diverse migliaia di dollari, quasi a replicare nella realtà
la vicenda raccontata nel film.
La statuetta del falcone
è un classico “Mac Guffin”, come lo
avrebbe definito Alfred Hitchcock: il maestro spiega con cura
cos’è un “Mac Guffin” a
François Truffaut in Il cinema secondo Hitchcock (1997),
la lunga intervista condotta dallo stesso Truffaut al regista inglese
parlandogli di Il prigioniero di Amsterdam (1940):
“A.H. La famosa clausola segreta era il nostro Mac Guffin. Bisogna che parliamo del Mac Guffin?
“F.T. Il Mac Guffin è un pretesto, non è così?
“A.H. È una scappatoia, un trucco, un espediente.
[…]
“In tutte le storie di spionaggio scritte in questa atmosfera, c’era sempre il furto della pianta della fortezza. Questo era il Mac Guffin.
[…] La cosa non è importante in se stessa e i logici hanno torto a cercare la verità nel Mac Guffin. Nel mio lavoro ho sempre pensato che le «carte», i «documenti», i «segreti» … debbano essere estremamente importanti per i personaggi del film, ma di nessun interesse per me, il narratore… in realtà il Mac Guffin non è niente”
(Truffaut, 1997).
In effetti, il falcone compare tardi, nel film,
quando il capitano della nave su cui era stato portato da Istanbul a
San Francisco, ferito da alcuni colpi di pistola, lo porta a Spade nel
suo ufficio, per poi abbattersi sul pavimento, morto. Nave che
è stata intanto incendiata.
Gli elementi
dell’intrigo, dell’esotico, del misterioso ci sono
tutti, aleggiano nel film come nel romanzo, dandogli corpo e senso, e
riconnettendo il racconto a almeno due secoli di immaginazione
narrativa, dal romanzo gotico al racconto di viaggio e di avventure,
nodi dell’immaginario romantico senza cui il cinema di
Hollywood non esisterebbe.
Materiali che si
coagulano nella statuetta, e nella sua “biografia”,
che sono anticipati, se si vuole, dal testo che introduce il film,
conferendo alla vicenda il tono colto – e evocativo
– di una ricostruzione storica che si perde nei nebbiosi
abissi del tempo e nelle misteriose terre dell’Oriente. Un
po’ come era avvenuto, circa un decennio prima, col
capolavoro di Tod Browning, Freaks (1932) al quale
la produzione, per rispondere alle proteste scandalizzate degli
spettatori, aveva appunto anteposto un testo a scorrimento che
conferiva alla pellicola una dimensione storico-antropologica, peraltro
fantasiosa e improbabile. Un’ulteriore allusione, per la
memoria degli spettatori, alle sfere del misterioso e
dell’esotico.
Il calco su cui sono costruiti
romanzo e pellicola ha un doppio tracciato: le vicende che vengono
rappresentate sullo schermo, e quelle che ne sono per così
dire alle spalle (l’oggetto delle indagini di Spade), che
rimangono opache, e che sarà compito dell’autore
(lo scrittore, il regista) svelare nel finale della storia attraverso
la voce dell’investigatore protagonista. Assicurando
così il colpo di scena di chiusura – la
rivelazione della colpevolezza di Brigid – e lo scioglimento
dei nodi della trama.
Pratica in cui Hammett era
diventato maestro, avendo composto alcuni dei suoi romanzi assemblando
insieme parti di trame dei suoi racconti, ritrovandosi a gestire catene
di eventi e cause sovrapposte, ingarbugliate, contraddittorie, che
poteva sgrovigliare solo assegnando ai suoi investigatori il compito di
mettere in ordine nel finale dei suoi romanzi gli eventi noti ai
lettori con quelli che gli aveva taciuto creando ad hoc catene
plausibili di cause ed effetti.
Brigid
O’Shaugnessy, un altro elemento cruciale. Una donna fatale
idealtipica, manipolatrice, bugiarda, ambigua, letalmente seducente. Ma
che non riuscirà alla lunga a ingannare il suo bersaglio. E
che si riproporrà in tante altre vesti. Come nel caso della
Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwick) di La fiamma del
peccato (Double Indemnity 1944) di Billy
Wilder, sceneggiato dallo stesso regista con, guarda un po’,
Raymond Chandler partendo dal romanzo omonimo di James Cain (in
italiano, La morte paga doppio, 1998, cfr. in
questo numero)…
Siamo nel periodo del trionfo dello star system hollywoodiano,
l’epoca dei divi, in cui ci si poteva
perdere guardando sullo schermo i propri miti, e magari incontrarli nei
locali dei dintorni di Los Angeles: mito e realtà si
confondevano, dando corpo alle riflessioni che Edgar Morin
sviluppò nel 1957 in Le star sulla
cultura di massa e la potenza immaginativa del cinema:
“… le star sono più che oggetti di
ammirazione: sono soggetti di culto […] L’uomo da
sempre proietta su delle immagini i suoi desideri e le sue paure.
Proietta nella propria immagine – il suo doppio –
il bisogno di superarsi nella vita e nella morte. Questo doppio
è detentore di potenze magiche latenti; ogni doppio
è un dio virtuale. Le cose e le persone
dell’universo cinematografico sono immagini, doppi”
(Morin, 1995).
“Le cose e
le persone”. Come la statuetta del falcone: Mac Guffin di
nome e di fatto: come per il film è un
pretesto, così dentro il film
è un falso. Un oggetto privo di valore, se non per
l’immaginazione dello sceneggiatore e dello
spettatore.
Un innesco, insomma. Il vero divo
del film: materia vile, che però regge e nutre il
sogno di gloria e di ricchezza degli avventurieri che lo braccano da
diciassette anni (e, nel mondo reale, dei collezionisti), e che,
scoprendo che è falso, invece di rassegnarsi o arrendersi,
schizzano via a riprendere la loro Quest infinita:
la stessa materia di cui è fatto il cinema, che usa i
materiali del mondo per dare vita a mondi immateriali, fatti di sogni,
di magia.
Qui, nel finale, romanzo e film
divergono bruscamente: lì dove, nel romanzo, vediamo Sam
prepararsi rassegnato ad una discussione con la moglie di Archer, di
cui era stato amante e che aveva lasciato, riportando tutta la vicenda
sul piano prosaico e faticoso della vita quotidiana e delle sue
miserie, nel film, al poliziotto che soppesando la statuetta gli chiede
di cosa è fatta, pesante com’è, Spade
risponde citando William Shakespeare, dalla Tempesta:
“È della materia di cui son fatti i
sogni”. L’aggiunta di John Huston, la chiusura
della sua sceneggiatura, rimanda direttamente alla natura stessa del
cinema: impalpabile, evanescente, come i nostri sogni, luogo di una
ricerca infinita, di un inseguimento continuo ai nostri doppi
immaginari, capace però di trasfigurare e consacrare le vili
materie dell’ordinario e del banale in qualcosa di magico, di
simbolico, di mitico.
LETTURE
— James Cain, La morte paga doppio, Adelphi, Milano, 1998.
— James Ellroy, Los Angeles nera (include i romanzi Le strade dell'innocenza, Perché la notte, La collina dei suicidi),
— Mondadori, Milano, 2001.
— Dashiell Hammett, Il falcone maltese, Longanesi, Milano, 1980.
— Dashiell Hammett, Il falco maltese, Mondadori, Milano, 1984.
— Edgar Morin, Le Star, MCF, Milano, 1995.
— François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, Nuova Pratiche Editrice, Milano, 1997.
VISIONI
— Tod Browning, Freaks, Dynamic Italia - Dynit, 2015 (home video).
— Alfred Hitchcock, Il prigioniero di Amsterdam Corrispondente 17, CG Entertainment, 2016 (home video).
— John Houston, Il mistero del falco, Warner Bros, Entertainment Italia, 2000 (home video).
— Ridley Scott, Blade Runner The Final Cut, Warner Home Video, 2016 (home video).