
di Gennaro Fucile
Strane relazioni si intrecciano nel corso della Storia tra eventi, figure e personaggi, reali, immaginari e di confine; tra oggetti, sogni e modalità di consumo. Trame oscure, a tratti illuminate da dettagli in apparenza insignificanti, connessioni inconcepibili, strane ma vere. Un incrocio piuttosto frequentato tra più sentieri dell’insolito è quello comunemente chiamato Barbie, nome di una bambola/totem prodotta da oltre cinquant’anni da Mattel, azienda statunitense il cui stato maggiore risiede in California. In quella terra, a Berkeley, giunse dalla Windy City con sua madre ancora fresca di divorzio un ragazzino: Philip K. Dick. Aveva circa dieci anni e si era alle soglie del secondo conflitto mondiale. Anni dopo, nel 1962, Dick raccontò un’ucronia, L’uomo nell’alto castello, che nel tempo ha assunto la dimensione di classico del genere, approdando nel 2015 anche in televisione grazie a una creatura che sembra partorita proprio dalla mente dello scrittore di Chicago: Amazon. L’ex libraio che ora progetta droni per le consegne degli ordini, ha infatti attivato anche una divisione, Amazon Studios, che sviluppa fumetti, film e prodotti televisivi, che a sua volta ha varato un adattamento del romanzo in dieci episodi (al momento).
La vicenda narrata da Dick si collocava all’interno di uno dei peggiori scenari immaginabili: la vittoria delle forze dell’Asse e il conseguente dominio del mondo da parte del Terzo Reich, dell’impero del Giappone e in minima parte dell’Italia fascista.
Le cose in questa linea temporale sono andate diversamente, eppure una specie di invasione ariana silenziosa è avvenuta ugualmente, senza ricorso alcuno alla forza, non necessitando di schieramenti di truppe e panzer e di oscurare i cieli con flotte di bombardieri della Luftwaffe e di sganciare atomiche sugli Usa.
Tutto iniziò nella Germania del dopoguerra (cfr. Bazzano, 2008), quando sulla prima pagina dell’edizione domenicale del quotidiano Bild Zeitung, il 24 giugno del 1952 comparve un’illustrazione raffigurante una giovane donna bionda, slanciata, accompagnata dalla didascalia “Voici Lilli”, che ne sottolineava lo charme con il ricorso al francese, forse anche per la somiglianza con una stella nascente del cinema: Brigitte Bardot. Ben presto Lilli conquistò il cuore dei lettori tedeschi, accattivandosene le simpatie; cosicché le vignette per un circa un anno divennero un appuntamento fisso con la donna della domenica a due dimensioni. Il disegnatore Reinhard Beuthin non si accontentò e decise di passare alla versione tridimensionale contattando tale Max Weissbrodt progettista della Hausser Elastolin di Neustadt, azienda che produceva soldatini realizzando lauti affari durante il Terzo Reich e risparmiata dalla fortuna durante i bombardamenti che avevano raso al suolo mezza Germania negli ultimi mesi di guerra. Caduti in disgrazia anche i soldatini, alla Hausser Elastolin si era alla ricerca di un nuovo prodotto di punta e Lilli era la persona giusta per questa missione. Il 12 agosto 1955 sul mercato tedesco viene lanciata la bambola Lilli al prezzo di 29 marchi. Alta ventinove centimetri e mezzo, la bionda, pallida ragazza, resa più seducente dal corredo di abitini appositamente confezionati, non fece presa sulle bambine, ma su un pubblico maschile adulto e il successo fu immediato, al punto da far ampliare il raggio d’azione dell’azienda fino a varcare i confini nazionali. Lilli ora puntava a tutto il mercato europeo di lingua tedesca: Austria e Svizzera. Un anno dopo, nell’estate del 1956, una famiglia statunitense, i coniugi Handler (Ruth ed Elliot) con i figli Barbara e Kenneth, rispettivamente di quindici e nove anni, passeggiano per le vie di una cittadina svizzera a volte indicata come Lucerna, altre come Zurigo o Locarno (sono confusi i ricordi di Ruth Handler). L’assenza di un luogo certo testimonia a favore di un incontro mitico che sancisce l’unione del corpo di Lilli con l’immaginazione di Ruth.

Barbie © Mattel Inc.
La signora Handler vede in una vetrina la bambola ammiccante nella sua confezione e ne acquista una copia prima di rientrare negli States, e ne compera poi altre due a Vienna. È amore a prima vista. Handler è un imprenditore, ha un’azienda con sede a Los Angeles, California. È il 1956, nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti esce L’invasione degli ultracorpi per la regia di Don Siegel, dall’omonimo romanzo di Jack Finney pubblicato l’anno prima (Invasion of the Body Snatchers è il titolo originale). La storia è arcinota, ma merita un cenno in questo contesto: extraterrestri si impossessano dei corpi degli abitanti di una cittadina copiandoli perfettamente mentre, ignare, le vittime dormono e poi eliminano i corpi originali. È la migliore delle pellicole che prendono d’assalto le sale cinematografiche in Usa per l’intero decennio. L’alieno è in agguato e la trasformazione in facsimile umano è la sua arma segreta. Una nuova cosa appare nello stesso anno in Europa, ma poi finirà per ri-sorgere negli Usa: la Pop Art. Il suo atto di nascita è l’agosto 1956 quando alla Whitechapel Art Gallery di Londra è di scena una mostra pioneristica e avveneristica: This Is Tomorrow. Il manifesto della mostra firmato dall’artista Richard Hamilton è un collage composto da ritagli delle riviste d’epoca. I temi raccolti in Just What Was It That Made Yestarday’s Homes so Different, so Appealling, questo il titolo dell’opera, sono concetti universali, campi ristretti e oggetti: l’uomo, la donna, l’umanità, la storia, il cibo, i quotidiani, il cinema, la televisione, il telefono, i fumetti, le parole, il registratore a bobine, le auto, gli elettrodomestici, lo spazio. Il genoma della Pop Art.
Tornando a Handler, l’azienda che ha creato produce mobili per case di bambole e si chiama Mattel, nome che unisce le iniziali del cognome del socio, Harold Mattson e del suo nome di battesimo (Elliot). Ruth spinge per il lancio di una bambola, diversificando così l’attività. Ci vorranno tre anni di studio, di tentativi, di affinamenti progressivi, ma alla fine Ruth la spunterà e un esercito di ragazze bionde, alte ventinove centimetri e mezzo inizierà a invadere prima gli Stati Uniti e poi il mondo. È il 1959, l’anno passato alla storia anche per essere stato quello che ha cambiato la storia dal jazz. Vedranno alla luce in quei dodici mesi album davvero fondamentali: Kind of Blue di Miles Davis; Time Out di Dave Brubeck; Mingus Ah Um di Charles Mingus e The Shape of Jazz to Come di Ornette Coleman, Giant Steps di John Coltrane. A volte gli alieni hanno la pelle nera e c’è un’intera Arkestra a testimoniarlo. È un momento di grande effervescenza negli Usa, anche sul fronte wasp: la space-age prende il volo, impazza la bachelor music, la vera colonna sonora della Pop Art e fra tanti scapoloni salottieri in cerca di relax a base di cocktail e impianti hi-fi, si fa largo quella che nel tempo si imporrà come una zitellona inveterata e vincente.

 È il 9 marzo 1959 quando il primo modello di
bambola messo a punto dalla Mattel fa il suo ingresso sul mercato. Si
chiama Barbie e nasce il 9 marzo 1959 a Willows (Wisconsin), dove
frequenta la Willows High School, come recita la sua biografia. Il vero
nome è Barbara Millicent Roberts; quando appare la prima
volta indossa un costume da bagno zebrato bianco e nero e sfoggia una
coda di cavallo. In terra di California dove è
già sorta l’iperreale Disneyland, di lì
a poco Dick, come si è detto, pubblica la sua visione
ucronica della storia, mentre la Pop Art si impone definitivamente
sulla scena mondiale, con l’esposizione di New York, The New
Realists, che ospitava tutti i talenti della nuova arte, tra cui Robert
Rauschenberg, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, Andy Warhol. Sono i
cambiamenti nell’aria che la giovane Barbie, in apparenza
così algida e distante dalle cose terrene, percepisce,
fiuta, introietta. Lo farà sempre, con il candore tipico
delle bambole. In pieno 1968 ebbe a dire:
È il 9 marzo 1959 quando il primo modello di
bambola messo a punto dalla Mattel fa il suo ingresso sul mercato. Si
chiama Barbie e nasce il 9 marzo 1959 a Willows (Wisconsin), dove
frequenta la Willows High School, come recita la sua biografia. Il vero
nome è Barbara Millicent Roberts; quando appare la prima
volta indossa un costume da bagno zebrato bianco e nero e sfoggia una
coda di cavallo. In terra di California dove è
già sorta l’iperreale Disneyland, di lì
a poco Dick, come si è detto, pubblica la sua visione
ucronica della storia, mentre la Pop Art si impone definitivamente
sulla scena mondiale, con l’esposizione di New York, The New
Realists, che ospitava tutti i talenti della nuova arte, tra cui Robert
Rauschenberg, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, Andy Warhol. Sono i
cambiamenti nell’aria che la giovane Barbie, in apparenza
così algida e distante dalle cose terrene, percepisce,
fiuta, introietta. Lo farà sempre, con il candore tipico
delle bambole. In pieno 1968 ebbe a dire:
“I cambiamenti erano nell’aria. Nel 1961 il ballerino Rudolf Nureyev fuggì dall’Unione Sovietica; nel 1962 il twist ribaltò le convenzioni; nel 1963 Valentina Tereškova fu la prima donna lanciata nello spazio e nel 1964 i Beatles, con le loro camicie senza collo, esplosero all’Ed Sullivan Shows. Tutto e tutti si stavano rinnovando”. (cit. in Bazzano, 2008)
Anche la fantascienza, che dalle pagine della rivista New Worlds, indicava per mano di James Ballard, il cambio di rotta, la via per l’inner space. Dick a sua volta chiuderà il primo cerchio un paio di anni dopo, alla fine del 1964:
“Arrivò Natale. Le piogge cessarono, il viso nel cielo scomparve. Sotto l’albero Phil e Anne (la compagna di Dick all’epoca, ndr) si offrirono l’un l’altra delle buone intenzioni. La più grande delle figlie ricevette una bambola Barbie fornita di diversi abiti, di accessori per le acconciature, di occorrente per il trucco, e di un amichetto di nome Ken. Passato il primo riflesso di sarcasmo che a un veterano di Berkeley quelle rappresentazioni idealmente caricaturali del sogno americano ispiravano, Barbie e Ken affascinarono Dick. Immaginava degli archeologi del futuro, oppure dei marziani, che ricostruissero la nostra civilità a partire da queste sole vestigia. Come fa chiunque si chini su una miniatura, non si stancava dei dettagli, della loro precisione, dei loro difetti. L’asciugacapelli di Barbie sembrava più sofisticato, insomma più realistico di quello di Anne. Il suo reggiseno si agganciava come fosse vero e non si sganciava più facilmente, ma conteneva dei seni senza punte né areola, e se – approfittando del fatto che Anne era di spalle – si faceva coraggio e le abbassava i calzoni, patatrac, niente peli, niente di niente, gli archeologi del futuro avrebbero avuto un bel da fare per sapere come gli umani del XX secolo si riproducessero. Ma forse gli archeologi del futuro non si sarebbero stupiti di niente, per la semplice ragione che sarebbero stati del tutto simili a Ken e Barbie. Ken e Barbie prefiguravano l’umanità di domani destinata a sostituirci. Oppure – perché no? – erano l’avanguardia di un’invasione extraterrestre”. (Carrère, 2006)
Oppure entrambe le cose, perché appare indistinguibile il transito verso il postumano da un corpo non terrestre. Non è l’unico concetto che evapora all’alba della società postmoderna, come suggerisce la radicale riflessione operata da Jean Baudrillard, che prende le mosse proprio dall’analisi del consumo e della comunicazione, della loro centralità assunta in base a “una logica del segno e della differenza” (Baudrillard, 2010). Cuore del suo discorso di partenza è l’oggetto, il sistema che gli oggetti costituiscono, un sistema di segni, espressioni di un linguaggio; ma laddove i referenti reali si emancipano progressivamente lasciandoli liberi di fluttare in una incessante circolazione.
“Fine del lavoro. Fine della produzione. Fine dell’economia politica. Fine della dialettica significante/significato che permetteva l’accumulazione del sapere e del senso. Il sintagma lineare del percorso cumulativo. Fine simultanea della dialettica valore di scambio/valore d’uso, che sola rendeva possibile l’accumulazione e la produzione sociale. Fine della dimensione lineare del discorso. Fine della dimensione lineare della merce. Fine dell’era classica del segno. Fine dell’era della produzione”. (Baudrillard, (2015)
 Quando il filosofo francese matura queste riflessioni in Lo
scambio simbolico e la morte e giunge a ipotizzare
l’ingresso della società occidentale nel terzo
ordine dei simulacri, “dove tutti i segni si scambiamo ormai
tra loro senza scambiarsi più con qualcosa di
reale” (ibidem), liberi dal dover per
forza designare qualcosa, ha ormai metabolizzato le visionarie
intuizioni di Dick a proposito della friabilità del
reale, dei simulacri lo soppiantano, della
serialità, del matrimonio del corpo e della macchina. Nel
racconto che dopo quell’illuminante Natale Dick scrisse,
ricorrendo a una trama minimale, I giorni di Perky Pat,
si descrive un gioco di simulazione, al quale concorrono gli adulti,
ruotante intorno al mondo di una bambola: Perky Pat. La costruzione
progressiva del suo universo reale è
autentica ragion di vita per i partecipanti, una Second Life.
È la cellula da cui sboccerà il romanzo Le
tre stimmate di Palmer Eldritch, dove Dick espone
compiutamente la usa idea di cyborg.
Quando il filosofo francese matura queste riflessioni in Lo
scambio simbolico e la morte e giunge a ipotizzare
l’ingresso della società occidentale nel terzo
ordine dei simulacri, “dove tutti i segni si scambiamo ormai
tra loro senza scambiarsi più con qualcosa di
reale” (ibidem), liberi dal dover per
forza designare qualcosa, ha ormai metabolizzato le visionarie
intuizioni di Dick a proposito della friabilità del
reale, dei simulacri lo soppiantano, della
serialità, del matrimonio del corpo e della macchina. Nel
racconto che dopo quell’illuminante Natale Dick scrisse,
ricorrendo a una trama minimale, I giorni di Perky Pat,
si descrive un gioco di simulazione, al quale concorrono gli adulti,
ruotante intorno al mondo di una bambola: Perky Pat. La costruzione
progressiva del suo universo reale è
autentica ragion di vita per i partecipanti, una Second Life.
È la cellula da cui sboccerà il romanzo Le
tre stimmate di Palmer Eldritch, dove Dick espone
compiutamente la usa idea di cyborg.
Singolare triangolo, Dick, Baudrillard e Barbie come vertice, perché questa eterna signorina brillante è il primo autentico manufatto globale del terzo ordine dei simulacri, la Eva del mondo retto dal consumo, anzi la Lilith (Lilli?), più emancipata della moglie ufficiale di Adamo. Infatti, Barbie non ha un marito, è legata da tempo, secondo le cronache ufficiali, con Ken, il bambolotto prodotto un paio d’anni dopo di lei; si è concessa qualche scappatella, ma in realtà ha un vero compagno, marito, partner, amante ideale di Barbie ed è ben altro eroe. È James Bond, laddove “007 ci introduce in una sorta di grande esposizione universale dei consumi voluttuari e delle nuove fisionomie dell’edonismo in un’epoca che costituisce l’apice della sperimentazione dell’identità sociale attraverso i consumi” ( www.quadernidaltritempi.eu/numero37).
L’epifania della prima Bond Girl sullo schermo prende le forme di una bionda di origini tedesche in costume, più osé perché in bikini, ma in questo contesto è un dettaglio superfluo. Quando sulla spiaggia dell’isola del Dr. No, Bond vede sorgere dal mare come la Venere botticelliana Honey Rider, ovvero Ursula Andress, il feeling è immediato e tutte le Bond Girl che seguiranno non faranno altro che clonare la logica della prima, come tutti i modelli che seguiranno la primigenia Teen-Age Fashion Model Barbie Doll. Le storie d’azione si addicono a Barbie, che fa anche in proprio e si replica in televisione con le Charlie’s Angels, una per la precisione: Jill Munroe, ovvero Farrah Fawcett, che la stessa Barbie a sua volta reincarnerà.
Lui (Bond) e lei (Barbie), marche per eccellenza, che incarnano l’essenza stessa del brand, se questo ne ha una. Stralciando dall’indagine compiuta da Paolo Fabris e Laura Minestroni sul valore e sui valori della marca, prende forma il ritratto autentico di questa coppia di fatto e la loro longevità nel friabile mondo dei consumi certifica nei fatti la teoria. Barbie e Bond sono due formidabili casi di marketing di successo:
“La marca è un addensato di segni e significati. Possiede una straordinaria attitudine a creare mondi”. (Fabris, Minestroni, 2010)
“Siamo di fronte, evidentemente, ad un congegno davvero potente, capace di muovere e commuovere”. (ibidem)
“La marca … appartiene allo statuto del racconto. La sua è una vocazione a narrare”. (ibidem)
“Una marca… racconta quasi sempre una storia avvincente. O, se si preferisce, una lunga metafora, un articolato racconto con un forte contenuto metaforico”. (ibidem)
“Tutte le marche leggendarie hanno costruito le proprie strategie attorno a delle storie, delle narrazioni”. (ibidem)

Logo Barbie © Mattel Inc.
Barbie, però ha anche una marcia in più, perché oltre a essere una marca capillarmente presente nel target a cui mira è anche una sorta di libretto d’istruzioni destinato al destinatario finale, per renderlo consumatore/consumatrice ideale, così come è nei sogni della marca: un soggetto ludico. La gamification oggi praticata, non appena si rende possibile, in qualsiasi ambito del consumo, è stata prefigurata da Barbie oltre mezzo secolo fa. Gioco che si estende alla comunicazione, al punto che il 2015 ha visto il lancio di una serie limitata a 700 pezzi, la Moschino Barbie con relativi accessori (otto, tra cui un cellulare, una collana, le buste per lo shopping, un cappellino e una t-shirt), già andati a ruba. Il protagonista dello spot che ne ha accompagnato il lancio è un bambino.
“È così grintosa”
esclama il ragazzino, circondato
dalle sue amichette mentre gioca con Barbie insieme a loro. La
questione del gender si fa ancora più
giocosamente sfumata.
Bond e Barbie, scapolo e zitella: una coppia così
è indistruttibile e ognuno dei due lo dimostra da oltre
mezzo secolo, quello più veloce nella storia
dell’umanità. A fare il verso a questa coppia
immaginaria ci è riuscito meglio di tutti un prodotto
seriale tra i più longevi nell’ambito delle soap: Beautiful.
La coppia è quella costituita da Brooke Logan e Ridge
Forrester. Tutto si muove nella cornice di una casa di moda, la
Forrester, in un susseguirsi di intrighi. Difficilmente
l’immaginario si muove a caso, men che mai quando scende in
campo maliziosamente in modo seriale. Lasciamo Bond e restiamo su
Barbie e i suoi doppi, come Barbarella, girato da
Roger Vadim nel 1968. L’eroina ha del bon ton da vendere,
come la ragazza del Winsconsin; lo dimostra subito nello strip tease
castigato che funge da scena per i titoli di testa,
un’occasione per mostrare anche il guardaroba, mentre
impassibile un manichino osserva la scena. Moda, icona, corpo, sesso.
Ecco il reperto più prezioso estraibile dal sottosuolo della
cultura post moderna, in cui Barbie occupa forse davvero un ruolo pari
a quello di Eva, metaforicamente nel senso di fondativa, ma anche
più letteralmente di corpo a venire, come il proto androide
di Eva futura (1886), romanzo di Auguste de
Villiers de L'Isle-Adam, sulla quale il suo inventore, Edison,
così si esprime:
“Oh! Questa carne è molto migliore! La carne umana appassisce e invecchia, questa invece è una composizione di sostanze pregiate, preparata chimicamente, adatta a umiliare la boria della natura. La copia è migliore dell'originale. È carne artificiale, io sono in grado di scomporvi nel modo più esatto la sua composizione”. (Villiers de L'Isle-Adam, 1992)
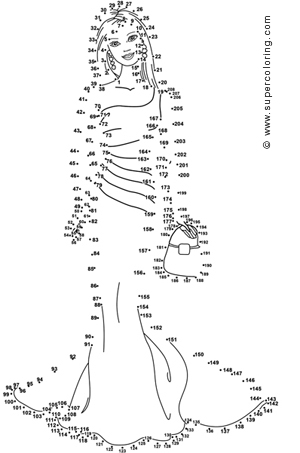 Quello di Barbie (come quello di Bond) è un corpo
performativo per eccellenza, adeguato al dispositivo narrativo seriale
di cui è autrice e oggetto al tempo stesso. Barbie
può essere tendenzialmente collocata in qualsiasi set,
segmentata a oltranza (è pur sempre una marca),
può interpretare qualsiasi racconto, di qualsivoglia genere
e relativi sotto generi. Finisce anche per essere co-protagonista nella
favola nerissima di Terry Gilliam, Tideland – Il
mondo capovolto (2007), o ricordo d’infanzia in Dio
esiste e vive a Bruxelles (2015) di Jaco van Dormael, per
restare più o meno all’oggi.
Quello di Barbie (come quello di Bond) è un corpo
performativo per eccellenza, adeguato al dispositivo narrativo seriale
di cui è autrice e oggetto al tempo stesso. Barbie
può essere tendenzialmente collocata in qualsiasi set,
segmentata a oltranza (è pur sempre una marca),
può interpretare qualsiasi racconto, di qualsivoglia genere
e relativi sotto generi. Finisce anche per essere co-protagonista nella
favola nerissima di Terry Gilliam, Tideland – Il
mondo capovolto (2007), o ricordo d’infanzia in Dio
esiste e vive a Bruxelles (2015) di Jaco van Dormael, per
restare più o meno all’oggi.
Niente le è precluso. È ovunque, è sostanza ubiqua, tendenzialmente dentro di lei alberga la quintessenza del dickiano Ubik. Un passaggio a proposito del S. Dole Melipone, veste alla perfezione le sinuose curve di Barbie: “Nessuno conosce il suo aspetto; sembra che cambi profilo fisionomico ogni mese” (Dick, 2013). Barbie deve essere adatta per una giornata al maneggio, o per un party con barbecue, interpretando da protagonista qualsiasi performance le venga richiesta. Un corpo accessoriato con tutte le meraviglie del sapere tecnologico, inclusi i materiali di cui è composto e con i quali si realizza l’intera panoplia di abiti e oggetti che abitano il suo mondo. Un corpo fantascientifico, in un certo senso, come quello di Bond.
Esiste un solo ambito dove ciò avviene in modo analogo: la pornografia. Anche qui il frazionamento per gusti e relativi generi tende all’infinito e il corpo o meglio la sua immagine, occupano interamente il campo. Infaticabili, sempre pronti a ricominciare, a ripetersi, i corpi nella pornografia si vestono e si svestono ripetutamente, agendo all’interno di scenari innumerevoli, tanti quanti sono i filoni narrativi esistenti. A ciascuno, a ogni target per quanto minuscolo, il suo racconto. Il marketing esemplare di Barbie ha un solo rivale parimenti flessibile, quello della pornografia, che fa della tendenziale personalizzazione dell’offerta la sua ragion d’essere. Echi dei tableau sadiani, della logica combinatoria che vi è sottesa, si può avvertire non solo con chiarezza nel cinema porno, ma anche nelle costruzioni a opera di adulti della dickiana Perky Pat; con altrettanta evidenza si dispiegano nei set creati per far trascorrere a Barbie del tempo libero piacevole o per farle svolgere le sue molteplici attività in modo proficuo.
A margine va poi annotato che Barbie si è trovata a sconfinare nell’arte e l’arte ha fatto altrettanto nei suoi confronti, così pure tra la pornografia e il cinema sperimentale (ma anche molta body art) si assiste al medesimo travaso di esperienze. Permutabilità e codice genetico: in fondo la nonna di barbie, Lilli, era un trastullo non certo per bambine.
La logica combinatoria del codice e la sua egemonia nel nostro tempo a quanto pare risiedono nei giochi per l’infanzia, nel Lego e in Barbie, che dalla sua può vantare anche il possesso di un corpo, o meglio di una sua rappresentazione, perché “Il corpo è un’immagine ancor prima di essere riprodotto in un’immagine. La figura non è ciò che afferma di essere, cioè la riproduzione del corpo. In verità è la produzione di un’immagine corporea che è compresa già nell’autorappresentazione del corpo. Questo triangolo uomo-corpo-immagine risulta essere senza soluzione di continuità, a meno che non si vogliano perdere tutte e tre le misure di riferimento” (Belting, 2011; corsivi dell’autore, ndr). Potrebbe risiedere qui la vera coolness di Barbie, quel distacco necessario con i fruitori, lo stesso instaurato per statuto nella scena pornografica.
Corpi performanti, storie seriali, permutazione, raffigurazioni del postumano, codici di pura operatività, segni/marca vuoti e in libera circolazione, culture del postmoderno e visioni del suo avvento, l’infantilizzazione del consumatore, il suo disciplinamento ludico, citazionismo, rovesciamento (abolizione?) della Storia: ecco una possibile trama cucita intorno a Barbie, anzi a lei sottostante, alla quale tutto ciò si addice, come tanti capi d’abbigliamento indossabili a seconda delle occasioni e degli impegni.
Alta sartoria culturale, altro che bambola.

LETTURE
— Jean Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, 2015.
— Jean Baudrillard, Per una critica dell’economia politica del segno, Mimesis, Milano, 2010.
— Nicoletta Bazzano, La donna perfetta. Storia di Barbie, Laterza, Bari, 2008.
— Hans Belting, Antropologia delle immagini, Carocci, Roma, 2011.
— Emanuelle Carrère, Io sono vivo e voi siete morti, Hobby & Work Publishing, Milano, 2006.
— Philip K. Dick, I giorni di Perky Pat, in Tutti i racconti 1964 – 1981, Fanucci, Roma, 2013 (formato Kindle).
— Philip K. Dick, Ubik, Fanucci, Roma, 2013.
— Philip K. Dick, La svastica sul sole, Fanucci, Roma, 2015.
— Giampaolo Fabris, Laura Minestroni, Valore e valori della marca, Franco Angeli, Milano, 2004.
— Auguste Villiers de L'Isle-Adam, Eva futura, Bompiani, Milano, 1992.
Qualora indicato dai detentori del copyright delle immagini attualmente prive di credito, provvederemo immediatamente a inserirlo.