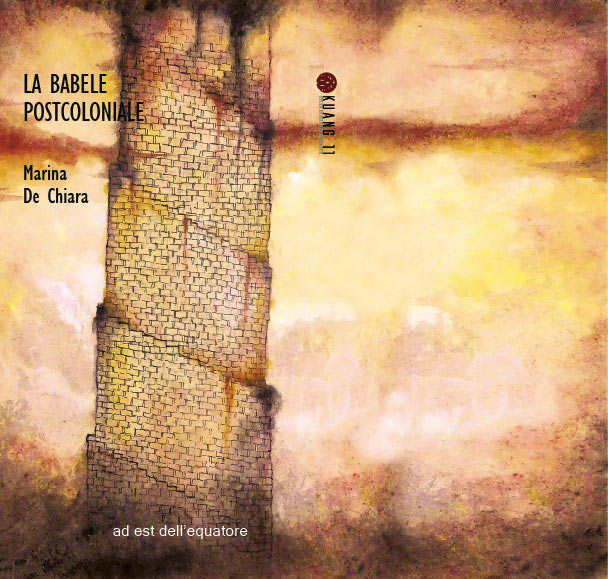Con un omaggio non di rito rivolto a tre pensatori scomparsi nel 2017 si apre La Babele postcoloniale di Marina De Chiara. Si tratta di Predrag Matvejevich, Tzvetan Todorov e Derek Walcott, tre figure, spiega l’autrice, che “hanno profondamente segnato la riflessione contemporanea sull’identità culturale e l’appartenenza nazionale nell’attuale scenario migratorio e diasporico”.
Identità culturale e appartenenza nazionale sono infatti temi che attraversano trasversalmente il testo e che, declinati dall’autrice in chiave postcoloniale, vengono trattati dalla prospettiva di chi si interroga su cosa è accaduto, e continua ad accadere, quando culture differenti si incontrano. Di fatto al centro de La Babele postcoloniale troviamo proprio “la spinosa questione del tradursi da una lingua all’altra, da una cultura all’altra”. Questione spinosa tanto nei regimi coloniali di ieri quanto nella contemporaneità interessata dai flussi migratori.
L’Europa interrogata dalle migrazioni rivela quella parte della propria storia che ha originato nazionalismi e razzismi, colonialismo e imperialismo, antisemitismo e fascismi. Un’Europa, dunque, la cui vicenda non può essere compresa come un percorso lineare e omogeneo verso il progresso e la democrazia. La relazione di dominio e sfruttamento che l’incontro coloniale ha avviato non ha riguardato solo il piano materiale; essa ha aperto anche un nuovo spazio epistemologico: l’autorappresentazione che l’Europa ha costruito di sé in quanto moderna, nominando altre popolazioni e parti del mondo come “non moderne”, ha prodotto umanità differenti.
 Da sinistra: Predrag Matvejevich, Tzvetan Todorov e Derek Walcott.
Da sinistra: Predrag Matvejevich, Tzvetan Todorov e Derek Walcott.
Si tratta di uno spazio che non definisce solo la conoscenza, distorta, degli altri, ma che parla del noi. L’Europa infatti non può essere compresa senza fare riferimento alla sua esperienza coloniale e imperiale e al suo bisogno di cristallizzare l’alterità per parlare di sé (cfr. Said, 1978). È con l’imperialismo che l’Europa si impone come “mondo quadro” (cfr. Chambers, 2005) al quale il resto del mondo dovrebbe aspirare ad uniformarsi. In questo senso gli effetti epistemici del “progetto coloniale” vanno ben al di là del colonialismo in quanto fenomeno delimitato nel tempo e nello spazio e si protraggono dopo i processi di decolonizzazione.
Confinamenti e spaesamenti
Appare necessario allora, come il testo di De Chiara invita a fare, interrogarsi sulle categorie cognitive che il colonialismo ha prodotto e che, in modo ambivalente, agiscono oggi nel tempo postcoloniale, un tempo caratterizzato “dal tracimare di logiche di dominio tipicamente coloniali al di fuori degli spazi in cui hanno avuto origine, fino a investire le metropoli” (Mezzadra, 2008).
I tre saggi che compongono La Babele postcoloniale compiono questa operazione da angolature differenti. Ciascuno di essi si apre ricordando uno dei pensatori a cui il testo è simbolicamente dedicato.
Il primo saggio, Spaesamenti, richiama il pensiero di Predrag Matvejevich, pensatore attento agli scambi, agli incroci e alle commistioni che hanno caratterizzato le relazioni tra le genti del Mediterraneo, un mare pensato come luogo di passaggio, simbolo del viaggio, piuttosto che come confine che separa. E in quest’ottica De Chiara propone delle riflessioni sulla impossibilità di un’autenticità, di una purezza e di una uniformità culturale. La contemporaneità postcoloniale si configura, scrive De Chiara, come “paesaggio incomprensibile e incontenibile” perché la frattura provocata dal colonialismo nelle storie, nelle memorie, nelle lingue, nei territori e nelle culture delle popolazioni colonizzate produce l’impraticabilità di identità assolute e stabili, di origini certe e definite.
Il secondo saggio, ImmagiNazione, si apre con il ricordo di Tzvetan Todorov, teorico della nascita della nazione moderna in quanto necessariamente connessa all’impresa coloniale e alla essenzializzazione e disumanizzazione dell’altro. In queste pagine l’autrice si sofferma sulle aporie del concetto di nazione che, per mantenere la propria coerenza e solidità interna, si fonda su narrazioni reificanti che leggono la possibilità della relazione con l’altro solo nei termini dell’assimilazione.

Il terzo saggio, infine, Babele nell’arcipelago antillano, attraverso i versi poetici di Derek Walcott ci conduce nei Caraibi, un luogo-laboratorio nel quale la dimensione ibrida della contemporaneità, la creolizzazione in quanto destino del mondo, è forse la più diretta conseguenza delle ferite coloniali che, nell’arcipelago antillano, si configurano come una commistione dei lasciti di schiavitù, sterminio e colonizzazione. A partire dalla tragicità di queste esperienze, tuttavia, la cultura nelle Antille si trasforma in “un meraviglioso mosaico di incroci culturali (…) reso magico dall’improvviso contatto di diverse popolazioni”.
Filo conduttore dei tre saggi è il concetto di narrazione e la sua natura performativa. L’attenzione agli effetti epistemici delle narrazioni è uno dei nodi centrali della teoria e critica postcoloniale, costantemente impegnata a decentrare il racconto eurocentrico della modernità e ad avviare una riesamina critica della storia europea.
Il testo di De Chiara si colloca certamente in quest’ottica, è infatti ricorrente il riferimento che l’autrice compie a due autori che si sono ampiamente dedicati alla performatività di specifiche narrazioni: Edward Said e la sua concezione dell’orientalismo in quanto “discorso” dell’Occidente sull’Oriente attraverso il quale il primo ha costruito il secondo come l’essenza dell’alterità (cfr. Said, 1978); Homi Bhabha e la sua proposta di concepire la nazione come quel costrutto narrativo che, avendo inglobato la retorica razzista-coloniale, presume l’esistenza di collettività omogenee e impermeabili (cfr. Bhabha, 1990).

Il merito del testo di De Chiara consiste però nel puntare l’attenzione sulla circolazione di narrazioni differenti. Se la storia europea degli altri è stata scritta in termini di mancanza, il bisogno di scomporre tale narrazione in tante storie, scrivendole da altri punti di vista e prendendo la parola in prima persona, diventa sempre più diffuso. Come l’autrice ben sottolinea, laddove la grande narrazione della modernità coloniale ha privato intere popolazioni della certezza delle proprie origini e ne ha sfilacciato le radici, mettendo definitivamente in crisi il nesso tra lingua parlata e terra abitata, si apre la possibilità di un nuovo legame: quello tra il racconto e la terra, tra il narrare e il viaggiare, tra la scrittura e la memoria.
Le narrazioni legate alle migrazioni, agli esili e alle diaspore sono allora la cifra del tempo postcoloniale. De Chiara infatti, citando Salman Rushdie, sottolinea la valenza politica della descrizione offerta dallo sguardo dell’esule: “quello di ri-descrivere il mondo è il primo passo necessario a trasformarlo” (Rushdie, 1991).
Traduzioni imperfette e paradossi dell’imitazione
Il pensiero di poeti e scrittori con cui l’autrice tesse un fitto dialogo nel corso del testo è frutto dell’esperienza dello spaesamento culturale e linguistico che la colonialità ha reso condizione esistenziale diffusa.
Un pensiero minoritario, ma non subalterno. De Chiara abbraccia infatti la prospettiva di Bhabha secondo cui parlare di minoranze piuttosto che di subalternità significa superare il rischio, che alcuni approcci postcoloniali corrono, di rimanere ingabbiati nel dualismo tipico dell’eurocentrismo, riproponendo, seppur dalla prospettiva opposta, dicotomie insuperabili.
Tale contrapposizione viene evitata attraverso la suggestiva immagine della Torre di Babele, che significativamente dà il titolo a questo libro. Se l’esperienza coloniale ha rappresentato il tentativo della traduzione forzata dell’altro, ovvero della riduzione dell’altro a sé, la Torre di Babele testimonia il fallimento di tale operazione. Già Walter Benjamin aveva sostenuto “l’impossibilità di una teoria della copia o della riproduzione dell’oggetto”, perché nella sopravvivenza che la traduzione – ben lontana dall’essere “la sorda equazione di due lingue morte” – assicura all’originale, quest’ultimo, necessariamente, si trasforma (Benjamin, 1995). La traduzione diventa dunque “un altro nome dell’impossibile” (Derrida, 2004). E la Torre di Babele, precisa De Chiara, simboleggia:
“l’utopia del linguaggio unico (ossia il sogno dell’uomo di ridurre all’uno la molteplicità), e la punizione divina (la dispersione delle lingue) per questo tentativo blasfemo: con la dispersione delle lingue Dio condanna l’uomo alla traduzione, come necessità e, nello stesso tempo, impossibilità”.
Data l’impossibilità della traduzione, De Chiara suggerisce di riconoscere l’imitazione come elemento tipico dell’era postcoloniale. Perché è proprio nell’imitazione che il colonizzatore ha preteso dal colonizzato, nel tentativo di annientarne la soggettività, che assistiamo alla disfatta dell’autorità della tradizione.
L’eco delle voci che l’autrice propone al lettore (Derek Walcott, Salman Rushdie, Jean Rhys e V.S. Naipul tra gli altri) è il frutto di una scelta precisa: non le voci di coloro che hanno scelto di opporre una propria autenticità originaria e incontaminata alla violenza del colonizzatore, ma quelle di coloro che, rimanendo nel mondo anglofono, ne riconfigurano l’universo di senso.
L’inglese, lingua imperiale per eccellenza, viene intaccato e sovvertito, contaminato dall’inscrizione in esso del “segno inconfondibile dell’alterità”, in un imperfetto gioco di specchi che rende, per De Chiara, “evidenti le aporie del sistema coloniale, in cui «imitazione» significa anzitutto, paradossalmente, esporre i segni della propria differenza”.
L’impraticabilità di una perfetta traduzione linguistica e culturale non implica però una perdita: è, al contrario, sostiene De Chiara, condizione di accrescimento e della formazione del “terzo spazio della mediazione, del continuo negoziare, di quel tra (in-between) che per Homi Bhabha è la cifra del nostro esistere, e che lo studioso propone come chiave interpretativa di ogni identificazione culturale”.
- Walter Benjamin, Angelus novus, Einaudi, Torino, 1995.
- Homi Bhabha (a cura di), Nation and Narration, Routledge, London, 1990.
- Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London, 1994.
- Iain Chambers, Cartografia del progresso, in Carla Pasquinelli (a cura di), Occidentalismi, Carocci, Roma, 2005.
- Jacques Derrida, Il monolinguismo dell’altro, Raffaello Cortina editore, Milano, 2004.
- Sandro Mezzadra, La condizione postcoloniale. Storia e politica del presente globale, ombre corte, Verona, 2008.
- Salman Rushdie, Patrie immaginarie, Mondadori, Milano, 1991.
- Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978.