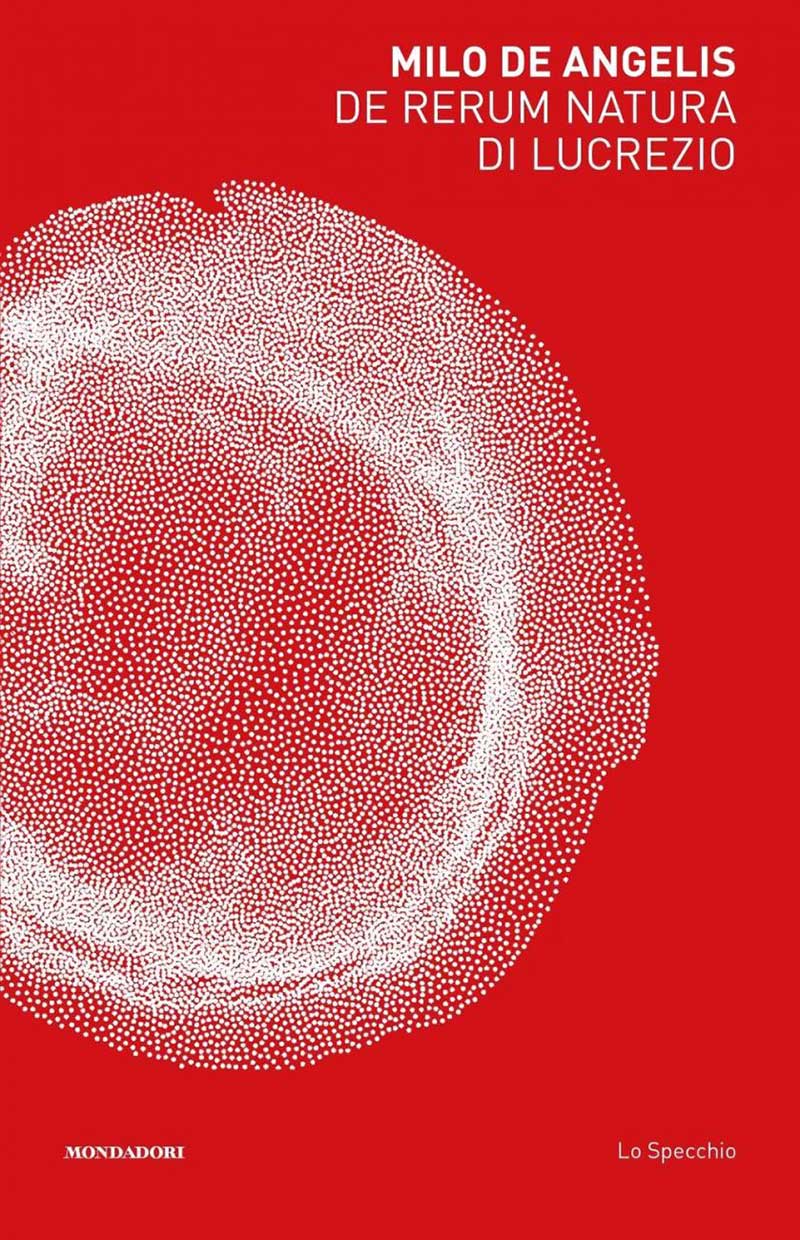Da ogni ritorno nasce un mondo nuovo. Lo scontento e la speranza, esuli da certi luoghi, rinnovano i loro contorni nei ritorni di chiunque. Ritorno nei luoghi, ma anche nei testi. “Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere spunti nuovi dentro di noi” (Pavese, 1997). Il ritorno può identificarsi con una meta di scrittura, un recupero del proprio io, un cammino a ritroso che si faccia radice di noi stessi e della nostra identità nella parola scritta. Lezione, questa, condivisa da un grande poeta dei nostri giorni, a cui il tema del ritorno è sempre stato molto caro, Milo De Angelis, che ci ha consegnato un lavoro di rarissima intensità, una nuova traduzione del De rerum natura di Tito Lucrezio Caro, per la collana Lo Specchio di Mondadori.
De Angelis ha ricercato più volte Lucrezio nel corso della sua vita, ma mai in maniera così articolata come in questa analisi dentro la quale sa superbamente proiettare il dialogo appassionato con la controversia, l’eccesso, la delicatezza, la sofferenza e la luce di un testo capace di sfilacciare le troppe resistenze dell’avanti ma anche del dopo Cristo. Traduzione emotiva, che evidenzia alcuni passaggi in direzione più comunicativa che semantica, adeguata alle presenti apocalissi di dolori e galassie a colori. Anzi, per certi versi, il tono di questo lavoro traduttivo calca ulteriormente l’irriverenza drammatica di qualche verso lucreziano. Ma cosa convince un autore dei nostri giorni a ritornare più volte a Lucrezio?

Chi legge Lucrezio non può non percepire una traccia musicale che sfiora i suoi spazi e il suo cuore. Non si tratta solo dell’esametro, che pure fa cantare le parole. Si tratta di quel sottofondo che accompagna tutte le sconfinate vite senza senso sopraffatte dalla voglia di trovarvi pur sempre una ragione. Perché Lucrezio è quell’inversione repentina di malinconia in fervore e di fervore in malinconia, che è un susseguirsi di toni e semitoni sulla scala dei suoi tempi. Un’inversione che non si scorda, soprattutto se ha un suo posto già connaturato dentro noi. È quanto accade a Milo De Angelis con il De rerum natura.
Tito Lucrezio Caro è l’insanissimus del mondo latino, il più folle. Lo accusa così la buona coscienza cristiana, ma non che prima fosse circondato dall’entusiasmo del suo tempo. Meglio tacere di chi passa informazioni incendiarie per i più, quelli che affollano le strade romane del I sec. a.C. con un occhio al dio di turno sopra la testa. Invece Lucrezio è lì, con una data di nascita incerta, una di morte pure, supposizioni su classe sociale e stile di vita, nessun familiare pervenuto, solo una certezza per tutte, la stesura di un libro a dir poco imbarazzante, tra una stagione di follia e l’altra, a dirla come S. Girolamo. La sua amentia fa il giro intorno alla filosofia materialistica del pensatore greco Epicuro, dispensando una promessa ambita in sommo grado, la felicità. L’importante è non temere gli dèi, beati nei loro intermundia e senza cura per gli uomini, non allarmarsi per la morte, tanto non convive con noi, mitigare i dolori presenti con il ricordo del benessere passato e la speranza di quello futuro, limitarsi ai soli bisogni naturali e necessari. Tutto lineare, o forse no. Abbandonare le stagioni estreme, le paure insane, i palpiti scomposti non rende nessuno di noi un uomo in più. Non è solo questione di immaginarsi un mondo senza un dio o senza un’anima che voli per l’eternità; è questione di prefigurarsi un mondo a cui sottrarre l’impossibile in nome del tangibile. Che te ne fai dopo di un posto così? Lucrezio tutto questo lo intuisce, lo analizza, lo testa. Ne nasce un’opera consolatoria e disperata al contempo, con la risultanza di qualche sentenza clinica sul suo conto, da parte di alcuni, e la cancellazione dalle cronache, da parte di altri.
 Foto di Reinhardi da Pixabay.
Foto di Reinhardi da Pixabay.
Un’opera che, trascorrendo per sei libri tra aggregazioni e disgregazioni atomiche, l’inutile paura della morte, il precipizio delle passioni amorose, l’origine del mondo e le umane vicissitudini per abitarlo, l’indifferenza degli dèi verso noi tutti, i fenomeni naturali, si va a concludere con l’immensa solitudine della peste di Atene nel V sec. a.C. Un sentiero in cui si parla di infinito ma non di eterno, di spaventi azzardati ma senza stasi, di vocazione alla felicità ma anche della sua fragilità. Circola notizia di un presunto suicidio del poeta e di un’interruzione brusca dell’opera. Senza indugiare sulla disamina critica del poema, un aspetto sembra avere il sopravvento su tutto, ma fu davvero convinto Lucrezio che la felicità bastasse volerla? Perché questo sguardo velato con cui osserva la scia delle stelle fino a quella delle pire dei cadaveri ateniesi sul finale, ben oltre l’eventualità di un qualsiasi suo suicidio, ci dice di un desiderio solitario di conferme. È qui il punto di incontro con chiunque lo abbia amato.
Lucrezio vive a testa in su anche quando è convinto del silenzio di quel cielo. Il motivo per cui un poeta come Milo De Angelis è tornato a lui forse sta proprio lì, nell’intuizione che la vita apra squarci indicibilmente desiderabili proprio mentre appare spaventosamente sbieca. E la vita si identifica con la poesia per entrambi. Di Lucrezio si è già precisato fosse tutto nel suo poema. Parimenti si presenta De Angelis:
“Sono in un segreto frastuono / sono in questo cortile d’aria / e ogni parola di lei violaciocca / mi fa pensare a ciò che sono / un povero fiore di fiume / che si è aggrappato alla poesia”
(De Angelis, 2015).
Su alcune tematiche le convergenze sono una traccia importante per introdursi in questo luogo d’incontro tra due poeti uniti pur nella distanza temporale. Terzo libro del De rerum natura, la paura della morte brulica e si moltiplica tra immagini perturbanti perché essa fonte di avidità, ambizione, autodistruzione. Il ravvedimento può arrivare solo dalla consapevolezza che la morte si riduca a pura scissione di atomi tanto dell’anima quanto del corpo. Ciononostante, mentre Lucrezio stesso sta per esaltare l’atarassia, lo sovrasta sentimento di altro segno e la dottrina del maestro Epicuro gli suona a tratti distante al punto da dilatare per versi e versi il trauma e il tormento legato alla mors immortalis. Così Lucrezio ospita convintamente quella stessa paura mentre la scaccia.
“Ci muoviamo sempre nel medesimo cerchio e di certo / non scopriremo nuove fonti di gioia prolungando la vita. / Quando è lontano, ciò che vorremmo avere ci sembra immenso / e quando lo afferriamo, siamo subito attratti da qualcos’altro / in questa continua ansia di vivere che ci lascia sempre assetati”.
Un’insopportabile mancanza nella somma delle cose fa tremare ogni uomo, ogni istante prossimo alla felicità, cancella d’un tratto la fiducia nella fortuna, rende il tempo senza definizione. “Persino adesso / sul golfo, il rosso / contro il cielo, l’attimo, è soltanto / paura di perdere il filo” (De Angelis, 2017; corsivo dell’autore, ndr). D’altronde, la contraddizione di noi uomini è nel sopravvivere ad altre notti e riversarci in altre fatiche pur di tenere in piedi intere vite. A Lucrezio si impara a tornare proprio perché ha saputo mostrarci l’infinità delle cose, la nostra inaccettabile marginalità in un universo così, eppure quell’altrettanto inesauribile voglia di ribellarci e dirci che un centro stiamo sempre in cammino a cercarlo, con tutto lo strazio conseguente. Ecco, amare Lucrezio significa perdersi nei suoi sforzi di far fronte al dolore intanto che questo pulsa forte. Urlarla a fil di voce, quella morte pressante, volendo immaginarsi vero pure il suo contrario.
“[…] non si potrà rispettarla, la morte, / se il sole batte sulle panchine / e più in là, deformati dalle lacrime, / altri alberi / tornano ad esistere” (ibidem).
Con pari sensibilità, sotto forme nuove, la battaglia si fa contemporanea. Capire chi siamo, si riconosce solo a ritroso. Anche laddove ci si sente prigionieri di chissà che, di chissà cosa. Anche mentre il nemico assume le forme del tiranno di turno, contro cui sferrare attacchi nulli se poi battuti da un terrore smarginato nella nostra intimità, come si legge in Lucrezio, sempre nella nuova traduzione di De Angelis:
“Così ciascuno tenta di fuggire da se stesso. Ma non può farlo, / e a questo “se stesso” resta attaccato suo malgrado e lo odia”.
Non esiste consolazione possibile a questa prigionia, ancor più dove tutti gli affanni perdono la loro utilità in nome di un cieco rimpasto di atomi o del vuoto tutto intorno.
“Ma le mura le avevamo già dentro / le notti curvilinee ci tornavano addosso / aprivo al mattino gli occhi lapidati / nasceva una prossimità violenta / si formava l’assedio”
(De Angelis, 2015).
Sapiente consonanza anche qui tra i due poeti rispetto alle battaglie mai vinte nella caccia di un nemico radicato fuori e, più ancora, dentro di noi. Battaglie a innalzare muri dietro cui sbarrarci, che sappiano di riparo e, al contempo, di penitenza. Nondimeno, chi scrive poesia non può esimersi dalla seduzione della speranza. Lo vediamo in Lucrezio, lo riscontriamo in De Angelis. Ne nascono versi ravvivati nei toni, insperati. Perché “l’agguato della gioia” è “una ierofania, un’apparizione del vero nella sua totalità” (De Angelis-Nicodemo, 2018). Scrive Lucrezio:
“Quando tu appari, dea, fuggono i venti e si diradano / in cielo le nuvole, la terra creatrice fa sbocciare / al tuo passaggio fiori soavi, ridono le distese del mare, / il cielo ritorna sereno e risplende, inondato di luce”.
Il riferimento in Lucrezio è alla dea Venere, invocata ad apertura del poema e sulla cui presenza le interpretazioni sono divergenti. Ci piace pensare fosse semplicemente simbolo della primavera, di quell’oro che si alterna all’argento nei prati, della muta aria che si converte in suono su nel cielo, di quel destarsi imprevisto dopo ogni inverno di confusione, di un’allegria che rovescia sospiri, del sentimento di ogni resistenza, anche quando niente resta.
“Non puoi immaginare, amico mio, quante cose / restano nascoste in una fine, non puoi / capire il pietrame triturato / che diventa la tua vita / eppure era bella, lo ricordo, era quella / che il vigore cosmico chiedeva, una giovinezza di frutteti, / l’arte suprema che mia madre augurava”
(De Angelis, 2015).
Un poeta di oggi, quando torna a un poeta di ieri, ammette che la vita sappia spiegarcela solo una pagina di versi.
- Milo De Angelis, Incontri e agguati, Mondadori, Milano, 2015.
- Milo De Angelis, Poesie (1969-2015), Mondadori, Milano, 2017.
- Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino, 1997.
- Viviana Nicodemo, Sulla punta di una matita. Conversazioni con Milo De Angelis, Produzioni dal Basso, 2018.