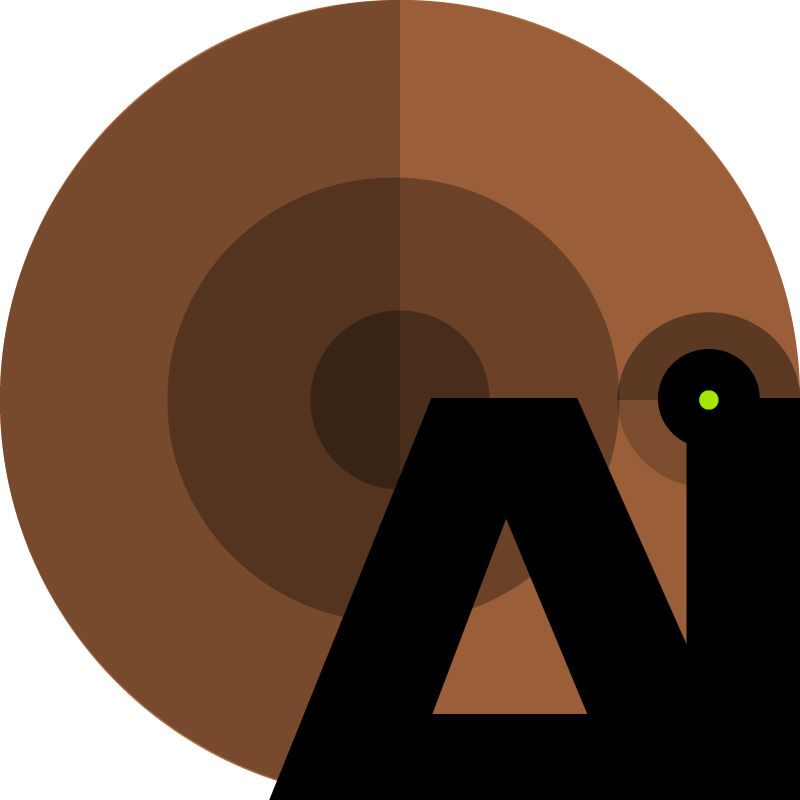Nel cercare di comprendere l’attuale fase (e crisi) economica e produttiva, emergono sempre più frequentemente temi all’apparenza sconnessi, o perlomeno appartenenti a differenti livelli di discorso, ma che si trovano a convergere in determinate circostanze. La digitalizzazione e quindi la robotizzazione dei processi, insieme alla datificazione delle vite, determinano spostamenti di capitali enormi, riportando al centro la questione della precarizzazione del lavoro culturale e cognitivo. Il dibattito sulle trasformazioni del lavoro ha incluso fin dagli anni Novanta il rapporto tra mente e macchina, rapporto che recentemente si è fatto sempre più simbiotico. Non sarà un caso se uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta abbia guadagnato la sua posizione grazie a una piattaforma che come prima cosa alla mattina ti chiede “a cosa stai pensando?”
Se la macchina è estensione del corpo, nei media proiettiamo la sfera intima ed emotiva, quindi la messa in rete dei dispositivi diventa terreno di riproduzione e modellizzazione delle reti sociali, delle relazioni. La data e sentiment analysis, la profilazione di utenti e l’interesse per il monitoraggio delle amicizie ci ricordano che l’estrazione che oggi avviene, e che determina i flussi, è un’estrazione di un lavoro diffuso nei tempi di vita, un plusvalore prodotto non solo dalla creazione immateriale individuale, ma dal valore aggiunto che è quello di corpi e menti messe in relazione, un plusvalore di rete.
Vari testi usciti in tempi recenti, come le antologie Salari rubati curata da Francesca Coin (2017) o Gli algoritmi del capitale redatta da Matteo Pasquinelli (2014), cercano di tessere i fili rossi che legano l’innovazione tecnologica con la messa a valore dei tempi di vita, e relativa diffusione e intensificazione della precarietà. Se vale la pena, però, citare un testo uscito prima degli anni Duemila, è perché a esso e al suo autore va riconosciuta una capacità di analisi quasi profetica, che ha saputo brillantemente introdurre, in tempi non ancora sospetti, la correlazione tra il rapporto uomo-macchina e la diffusione delle identità e delle affettività, quindi l’emergere di nuove forme di captazione capitalistica. Saggista, matematico di formazione e figura di spicco nella critica letteraria fantascientifica, Antonio Caronia (1944-2013) svolse un’intensa attività politica, prima nel PSI poi nella Quarta Internazionale. Membro del collettivo Un’ambigua utopia, tra i suoi saggi sono ricorrenti temi legati al cyberpunk, la virtualità, l’utopia. Tesi centrale del suo testo Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti, pubblicato nel 1996, è che la digitalizzazione non porterà ad un isolamento del corpo quanto invece ad una sua dissoluzione, disseminazione in una rete di relazioni.

A essere riportata al centro dell’attenzione, nel testo, non è la relazione uomo-macchina, bensì la relazione uomo-uomo che avviene tramite la macchina. Il corpo non perde la centralità, ma anzi la acquista, perché le tecnologie permettono al corpo di superare i limiti della località e della spazialità, permettendogli di raggiungere nuovi traguardi. È sorprendente riscontrare come, in certi passaggi, Caronia sembri addirittura descrivere dettagliatamente le tecnologie di realtà virtuale oggi in via di sviluppo. Tecnologie che, a suo dire, trovano già i loro embrioni nella diffusione della rete telefonica, che comportò una prima disseminazione di una parte del corpo, nello specifico la componente vocale. Tesi che, come lui stesso dichiara, ha valore se si considera il corpo non meramente come concetto biologico, ma come concetto culturale, cioè come interfaccia tra l’uomo e il mondo: “È da questo punto di vista che la disseminazione del corpo nelle reti rappresenta la grande novità del prossimo millennio, con tutte le potenzialità da un lato e con tutti i problemi dall’altro, che esso può comportare” (Caronia, 1996).
Demoni di macchine e digitalizzazione degli affetti
Nell’antichità, il demone – daemon – era lo spirito personificazione delle passioni dell’uomo. Nell’informatica, soprattutto in ambienti Unix, per demone si intende un programma eseguito in background, senza il controllo diretto dell’utente. Italo Calvino riscontrava, nelle pagine di Cibernetica e fantasmi, una tendenza emergente a considerare l’io e la psiche come processi combinatori piuttosto che trascendenti: “il pensiero, che fino a ieri ci appariva come qualcosa di fluido, evocava in noi immagini lineari come un fiume che scorre o un filo che si dipana (…), oggi tendiamo a vederlo come una serie di stati discontinui, di combinazioni di impulsi su un numero finito di organi sensori e di controllo” (Calvino, 1995). È un processo lungo, che parte da lontano, sicuramente accelerato dagli stravolgimenti portati dalla fisica quantistica e dalla psicoanalisi, oltre che ovviamente dai progressi informatici che lasciavano finalmente intravedere la realizzazione della mente artificiale.
L’avvento dei social network, insieme a una policy di utilizzo che obbliga alla sovrapposizione fedele di reale-virtuale (ricordiamo che prima di Facebook nessuna piattaforma si è mai sognata di obbligare l’uso del nome anagrafico come nickname), hanno concretizzato la digitalizzazione biopolitica delle esistenze. Le conseguenze economiche sono sotto gli occhi di tutti: il mondo del marketing e dell’opinion making non hanno mai avuto sotto il naso una miniera così ricca per monitorare e comprendere i flussi di pareri e pensieri di gran parte della popolazione mondiale.
L’analisi delle reti sociali si mescola alla robotica, e continuamente nascono e si sviluppano nuovi ambiti di ricerca – sentiment analysis, affect computing, text analysis – per comprendere e riprodurre, eventualmente tramite bot e software, tutta la sfera delle emozioni umane. Cos’è questa, se non una grande fabbrica diffusa, in cui i nostri spostamenti, le nostre relazioni costituiscono una incessante attività produttiva, costantemente messa a valore? Spesso di recente si è parlato di Facebook come una nuova forma di “sfruttamento inconsapevole” dell’utente. Qualcuno potrebbe pure osservare (comunque adottando un punto di vista miope) che chi accede ad una piattaforma accetta le condizioni previste, quindi anche quella di essere “sfruttato” dal colosso grazie al proprio lavoro messo a disposizione. A parte il fatto che vi sarebbe da considerare la questione del monopolio e del fagocitamento di tutta la Rete all’interno del portale, che ne rendono praticamente impossibile la fuoriuscita, la questione si è fatta ancora più complessa, perché non tiene conto di quanto il materiale condiviso, disponibile su piattaforme di vari proprietari o addirittura open, possa essere utilizzato da chiunque per addestrare reti neurali. Ma facciamo un passo indietro.
Processi di apprendimento automatico
Quando parliamo di bot, vale a dire intelligenze artificiali in grado di compiere attività complesse, ritenute alla stregua delle capacità umane, solitamente alla base c’è un processo di machine learning, apprendimento automatico. Sostanzialmente significa che se si vuole creare un programma che sappia riconoscere le foto dai cani da quelle dei gatti, gli si dà in pasto un enorme dataset (insieme) di foto catalogate, alcune di gatti e altre di cani, provviste di un’etichetta che ne identifica la razza del soggetto. “Studiando” per lungo tempo queste foto, e ri-calibrandosi in modo da commettere meno errori possibili, alla fine la rete neurale sarà in grado, con buona approssimazione, di riconoscere l’animale raffigurato in foto che non ha mai visto prima. La potenza incredibile di questo processo è che può essere applicato praticamente a ogni cosa. Questo significa che quando sentiamo di nuovi software che riconoscono tracce musicali, o identificano la persona in base a come cammina, o dalla voce, o altri mille casi simili, si tratta semplicemente di ri-applicare il processo descritto sopra a una circostanza diversa. Unica nota dolente, per poter applicare questo processo vi è bisogno, in ogni circostanza, di un grosso dataset di partenza su cui fare apprendere la macchina, adatto al contesto. Ed è qui che torniamo a interfacciarci con il general intellect, la produzione diffusa, il valore user-generated.

In un manuale accademico di machine learning ci si può imbattere in un esempio emblematico: il testo portava l’attenzione sugli algoritmi di sentiment analysis, branca del Natural Language Processing, ovvero quei sistemi sviluppati per determinare il livello di “positività” emotiva di un determinato testo. Come si accennava sopra, il testo riportava l’attenzione sul fatto che per creare tale algoritmo era necessaria una grossa mole di testi “etichettati” come positivi o negativi, su cui fare apprendimento. Una possibile soluzione proposta, oltre a quella di assumere a basso costo manovalanza per scrivere testi e catalogarli, era quella di usare una manovalanza che già esisteva in Rete, senza doverla retribuire, e che già aveva lavorato. Nello specifico, il testo proponeva di usare i commenti delle recensioni di TripAdvisor, disponibili pubblicamente, e costituiti da un testo annesso a una valutazione in stelline, che già ne costituiva una catalogazione sentimentale. Il dataset era lì, a portata di mano, pronto per essere usato per poter costruire un eventuale algoritmo di riconoscimento testuale, che poi sarebbe stato brevettato e diffuso in licenza close.
Il corpo, o meglio la mente disseminata degli utenti iper-connessi, grazie alla loro messa in condivisione di opinioni, valutazioni, produzioni intellettuali, stanno creando il sangue con cui alimentare il cuore dell’intelligenza artificiale così come oggi è concepita. Un’intelligenza artificiale la cui mente e la cui emotività è la somma ricombinata e interpolata di menti ed emotività collettive di una moltitudine di instancabili, iperproduttivi, operai.
Quando Frankenstein ci ruba il lavoro
Nel saggio Robot tra sogno e lavoro, Caronia analizza le interpretazioni culturali e mediatiche del rapporto tra uomo e macchina nelle varie epoche: “Se nel mondo antico la macchina può essere ancora un simbolo dell’unità con la natura, o il prodotto di una ingegnosità fuori dal comune (come gli automi semoventi di Erone Alessandrino), con l’arrivo della civiltà industriale e della modernità quella lacerazione fra uomo e natura è ormai insanabile” (Caronia, 1991).
Fin dal mito del golem di Praga e dell’homunculus alchemico, passando per il romanzo di Mary Shelley fino ad arrivare ai recenti prodotti cinematografici sulla ribellione dell’automa, si è sempre riscontrato il timore dell’uomo per la perdita del controllo sulla propria creazione. Nel 1921, nella Praga di Franz Kafka, uno scrittore anch’egli ceco, Karel Čapek, scrisse il dramma in tre atti R.U.R., un’opera nella quale compariva per la prima volta un termine destinato ad avere una diffusione culturale storica: robot. Con quel nome, inventato dal fratello dell’autore Josef, Čapek indicava una nuova razza di automi, di “macchine da lavoro vive e intelligenti”. Ma i robot di Čapek, ibridando la naturalezza dell’umano con la macchina, in tempi in cui emergevano le perplessità riguardo la sopraffazione della tecnologia sopra le forze della natura, portarono la macchina-automa a incarnare il mito distopico del Frankenstein, del portatore di morte, del dominio sull’uomo. Paure che ritornano, adattandosi all’attuale, re-incarnando i timori del tempo presente. E quale timore tra i più attuali, se non quello della precarietà dell’esistenza e del confino alla povertà?
L’orizzonte della quarta rivoluzione industriale
Dal rapporto The Future of Jobs pubblicato dal World Economic Forum (Wef) di Davos a inizio 2016, apprendiamo che la quarta rivoluzione industriale farà nascere due nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne renderà obsoleti sette, con un saldo negativo di oltre cinque milioni di occupati. Sul tema esiste ormai una letteratura sconfinata: secondo un articolo di The Atlantic del luglio 2015, per quanto riguarda gli Stati Uniti, “9 lavoratori su 10 sono impiegati in occupazioni che già esistevano 100 anni fa, e solo il 5% dei posti di lavoro generati tra 1993 e 2013 provengono da settori hi-tech”. Già adesso, “le industrie più innovative tendono a essere anche le più efficienti: semplicemente, non hanno bisogno di tante persone”. Il parallelo ormai classico, riportato anche da Valerio Mattioli su un articolo su Prismo (12/04/2016) è quello tra la AT&T che nel 1964 impiegava quasi 760.000 individui, e Google che di impiegati ne conta “appena” 55.000, lasciando virtualmente senza lavoro 705.000 persone.
È il timore che incalza l’immaginario, rappresentato da Caronia come una tartaruga della fantasia che raggiunge la realtà che è Achille. Ma Caronia ha chiaro che la tecno-fobia è un puntare al ribasso, è rinunciare alle possibilità, e analizza l’immaginario perché riconosce che è esso stesso un processo combinatorio, dovuto alle circostanze, alle narrazioni, ai dispositivi di potere. Dispositivi che Caronia si augura di disinnescare, trovando il grimaldello giusto, lo strumento che permetta di disincagliarsi da apparenti aut-aut del discorso, e tornare a tornare ad immaginare un rapporto virtuoso, simbiotico, tra l’uomo e la macchina: “Riusciremo mai a sfuggire all’alternativa falsa e paralizzante fra la demonizzazione della macchina e la sua esaltazione acritica?” (Caronia, 1991).

Umani e cyborg per un reddito minimo
In un interessantissimo, e ancora attuale articolo pubblicato su Giap nel settembre del 2011, i Wu Ming si interrogavano sulla sempre presente co-presenza di pratiche assoggettanti e pratiche liberanti nell’uso della tecnologia. Anche in quel caso si parlava di tecno-utopie e tecno-pessimismi, di apocalittici e integrati, anche se su temi diversi dal rapporto uomo-automa. Ma il discorso non cambia. Disinnescare l’aut-aut significa “smettere di pensare alla tecnologia come forza autonoma e riconoscendo che è plasmata da rapporti di proprietà e produzione, e indirizzata da relazioni di potere e di classe” (Wu Ming, 26/09/2011). Come esempio emblematico, e a mio avviso illuminante, a supporto di tale tesi, viene citato il caso dell’eolipila, un prototipo di macchina a vapore concepita dal matematico greco Erone di Alessandria nel I secolo a.C., un dispositivo che poteva anticipare la tecnologia a vapore di svariati secoli, ma che invece non trovò alcuna applicazione pratica, in quanto la grande disponibilità di schiavi non rendeva necessario, da parte di chi disponeva di risorse, investire su questa tecnologia. Rimettere al centro i rapporti di forza è ormai imprescindibile se vogliamo affrontare il reale in tutta la sua complessità.
Si dice che quando una tecnologia rende obsolete alcune occupazioni è perché ne genera altre, e questo è senz’altro vero. Ma l’errore sarebbe ricercare questi nuovi posti di lavoro in vecchie categorie. La diffusione capillare della possibilità di produrre contenuti, di rendersi vettori di cultura e conoscenza, fa sì che i nuovi lavori esistano già, e i nuovi impiegati, come detto prima, stiano già lavorando, chi più chi meno inconsapevolmente. Si potrebbe addirittura sostenere, riprendendo i termini di Caronia, che la disseminazione delle individualità in Rete non ha fatto altro che rendere più visibile ed esplicita la ricchezza che chiunque, in ogni giorno, dall’alba dei tempi, produce tramite le relazioni, gli affetti, la messa in comune del sé con gli altri. Se fino a dieci anni fa sembrava difficile spiegare che tutti abbiamo diritto a un reddito perché già produciamo in ogni attività ed esperienza, ora questo appare come una banalità, dal momento che quattro imprenditori della Silicon Valley sono riusciti a scalare le classifiche della ricchezza mondiale trovando dispositivi capaci di mettere a valore questa produzione. Con tante complessità del caso, che non vi è tempo di affrontare ora, quella di un reddito universale di base è un’ipotesi che sta prendendo piede, perdendo quell’aura di utopia impossibile che aveva anni fa.
Prospettive radicalmente ribaltate
Esistono molte strade in via di sperimentazione, e ogni giorno vengono lanciate proposte più o meno provocatorie, dal manifesto dei robot per il reddito di base alla nazionalizzazione di Facebook. Certo è che la fine del lavoro, così come inteso finora, incontra resistenze anche e soprattutto nell’immaginario. Retoriche lavoriste ormai fuori dalla storia lasciano residui che limitano l’immaginazione di un mondo post-lavoro. D’altronde sembra ancora più assurdo pensare che, se a fine Ottocento si immaginava un Duemila in cui gli oneri erano utopisticamente addossati alle macchine, ora viviamo nel timore che questo possa avvenire.
Riconoscere e riprendersi il valore relazionale di rete, nella Rete, in un’alleanza uomo-macchina volta al miglioramento delle condizioni di vita, critica nei confronti dei processi non più considerati come naturali ma come contingenti, quindi temporanei, può essere la risposta alla domanda che Caronia si poneva, quando si chiedeva in che modo stare nelle cose, avvicinandosi a quella verità che lui stesso citava da Philip K. Dick, per cui “ogni cosa è ugualmente viva, libera e senziente, perché ogni cosa non è viva, viva a metà o morta, ma piuttosto attraversata dalla vita” (Caronia, 1991).
–– Italo Calvino, Cibernetica e fantasmi, in Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 1996.
–– Antonio Caronia, Cyborg: saggio sull’uomo artificiale, Theoria, Roma-Napoli, 1985
–– Antonio Caronia, Robot tra sogno e lavoro, in Occhio meccanico braccio meccanico. I robot nelle fotografie d’oggi catalogo della mostra, ABB, Museo della scienza e della tecnica, Milano, 1991.
–– Antonio Caronia, Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti, Franco Muzzio Editore, Padova, 1996.
–– Francesca Coin (a cura di), Salari Rubati, Ombre Corte, Verona, 2017.
–– Matteo Pasquinelli (a cura di), Algoritmi del capitale: accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del comune, Ombre Corte, Verona, 2014.