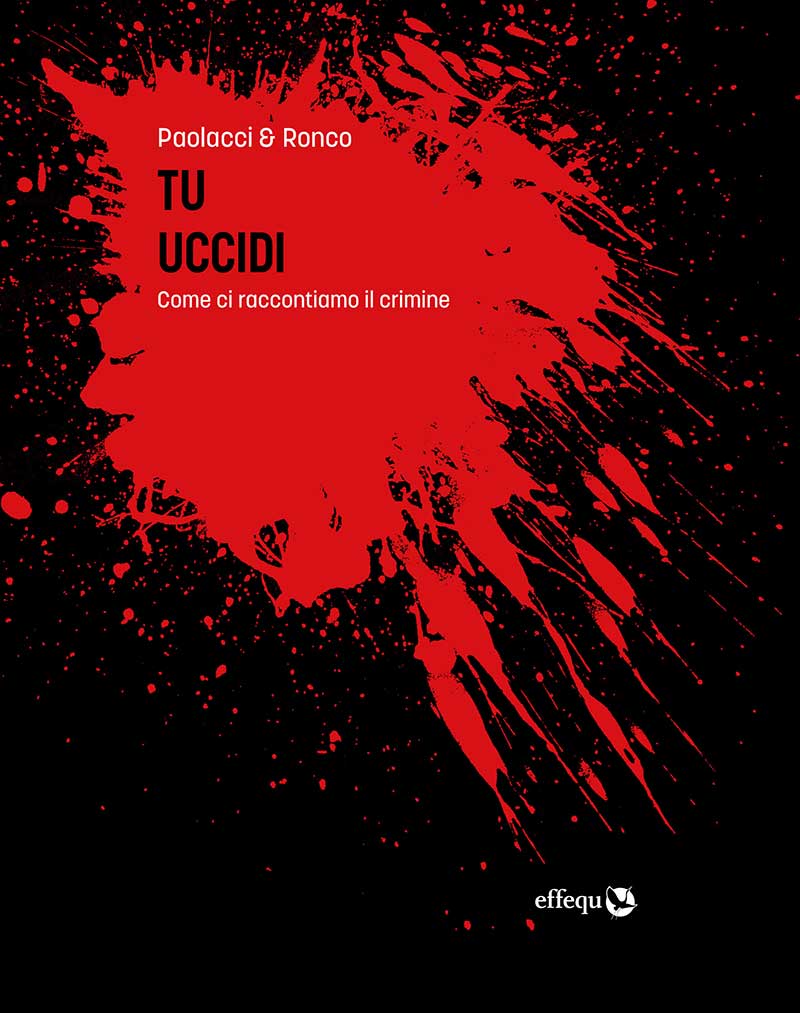È di recente pubblicazione, per le edizioni effequ, Tu Uccidi. Come ci raccontiamo il crimine, un volume a firma di Antonio Paolacci e Paola Ronco. I due sono una coppia anche nella vita, informazione che potrebbe sembrare apparentemente irrilevante, ma che va specificata perché questo elemento emerge anche in diverse occasioni nel testo e ha una motivazione precisa nell’economia dello stesso. Uno degli obiettivi dichiarati del saggio è difatti mostrare l’infondatezza delle contrapposizioni assolute, che quasi sempre sono alla radice della narrazione del crimine nel contemporaneo. Non esisterebbero quindi, se non nella costruzione che apparentemente è dominante, né noi né loro, ma solo delle persone, con le loro vite, incommensurabili e non paragonabili tra loro.
In questo senso, l’introduzione di elementi della vita privata, così come l’eliminazione quasi totale di terminologia tecnica o in altre lingue, ha lo scopo ben preciso di ampliare il più possibile la platea dei lettori, di non porsi mai in modo cattedratico verso gli stessi, e di coinvolgerli anche emotivamente in un argomento obiettivamente complesso da affrontare: noi siamo come voi, noi siamo voi, è il sottotesto su cui insistono Paolacci e Ronco. Dal punto di vista editoriale gli autori hanno nel loro carnet una nutrita serie di romanzi, sia singolarmente che in coppia, ed è in questa formazione congiunta che hanno dato vita alla serie imperniata sul vicequestore aggiunto Paolo Nigra, che svolge le sue indagini nella Genova odierna, dove anche i due autori vivono. In questa occasione però non si tratta di pubblicare un romanzo, bensì un saggio, anche se, per parafrasare Carlo Ginzburg, viene mantenuto ben saldo il paradigma giudiziario, e gli autori procedono nella scrittura esattamente come se stessero svolgendo una indagine. A voler essere precisi vi è una sorta di prequel a questo saggio, sebbene con i dovuti distinguo, ed è quel testo ibrido (si perdoni l’abusato aggettivo), un romanzo mancato, pubblicato nel 2017 a firma del solo Antonio Paolacci e che si intitolava Piano Americano, rispetto a cui questo ultimo ha, si direbbe, svariati debiti. Si riscontrano quindi diverse costanti nella loro produzione, a partire dal continuo gioco di sponda tra la percezione soggettiva da un lato, descritta, come si è detto, anche grazie ai momenti della vita privata incastonati nel testo, e dall’altro la ricerca della maggior oggettività possibile, vorremmo dire di prove, che permette agli autori di salvaguardare un approccio realistico anche se all’interno di una sorta di narrazione.
“Noi ci occupiamo insomma di narrazione. Ed è soprattutto di questo che parleremo qui: perché sappiamo che la narrazione del crimine riveste un ruolo centrale nella sua comprensione e in quello della cultura in cui il crimine stesso accade. Osservare il modo in cui ci viene raccontato un delitto, sia dall’informazione che dalla fiction, permette di comprendere qualcosa di più importante del puro e semplice chi è stato”.
Un titolo programmatico
Il volume pone questioni piuttosto specifiche, già a partire dal titolo. Ricordiamolo: Tu Uccidi. Come ci raccontiamo il crimine. Il lettore viene quindi immediatamente coinvolto, gli autori gli si rivolgono direttamente, e con una certa durezza: Tu uccidi. È una imputazione grave, diretta, un preciso riconoscimento di responsabilità (oltre a un riferimento esplicito al noto romanzo di Giorgio Faletti) che si accosta a quel noi che segue. Difatti il sottotitolo pare una sorta di spiegazione: in quale modo noi raccontiamo il crimine. A chi lo raccontiamo? A noi stessi, e difatti è presente quel “ci” a confermarlo. Come dire che scrittori e lettori fanno lo stesso lavoro, ovvero ognuno, a suo modo, raccontano storie. In questo senso, è dichiarato fin dal titolo che non vi è altro che un noi: scrittori, lettori, persone, vittime, criminali, tutti siamo coinvolti in questo teatro dell’assurdo che è la narrazione del crimine. Vi è però, o almeno dovrebbe esserci, una profonda differenza riguardo la consapevolezza di ciò che si sta facendo. Se lo scrittore cerca di mostrare ciò che rende complesso un percorso, umano, sociale o quant’altro, il lettore, implacabilmente, cerca un colpevole. Come ripetono continuamente Paolacci e Ronco nel corso del testo, la domanda del lettore è un mantra che recita: chi è stato, e la decostruzione della narrazione serve proprio a chiarire perché l’identificazione del colpevole sia quantomeno insufficiente, se non addirittura fuorviante, per la comprensione dell’evento criminoso.

La questione è complessa, e difatti i due procedono passo passo decostruendo quel rapporto molto sui generis che si crea tra chi le storie le inventa e chi invece le riceve. Si dovrebbe inoltre considerare che il flusso informativo non è mai a senso unico, e che se lo scrittore propone la sua visione del crimine in un testo scritto, un mezzo lento e pesato, il lettore – che è anche pubblico – ha invece le sue fonti di informazione soprattutto attraverso la televisione e la rete, ovvero tramite l’immagine, il visivo. Spesso sono perciò i lettori, il pubblico, le persone che guardano la TV, a costruire, tassello dopo tassello, l’immaginario retrostante un evento, usando le informazioni adeguatamente dosate da chi le diffonde. La narrazione è quindi uno dei mille specchi deformanti che rimandano la notizia, dati di realtà rielaborati attraverso pregiudizi e meccanismi di identificazione. Questo avviene soprattutto perché a filtrare la realtà per il lettore / spettatore è la velocità dei media visivi, dalla televisione a internet, che, come dice Marshall McLuhan, tendono alla simultaneità. Il lettore, inoltre, non è unicamente un ricevitore, bensì lui stesso rielabora il messaggio ricevuto e lo restituisce modificato, amplificato o depotenziato.
“[…] a leggere la maggioranza dei libri in commercio sono in prospettiva pochissime persone, a fronte delle decine e decine di milioni che formano il proprio immaginario assorbendo informazioni e storie dalla comunicazione di massa e dalle sue semplificazioni”.
Casi esemplari degli ultimi decenni
Paolacci e Ronco dedicano diverse pagine alla formulazione dei loro presupposti metodologici, dove vengono evidenziate le diverse modalità della narrazione (giallo, noir, crime, true crime, thriller, detective story), alcuni degli strumenti utilizzati nelle inchieste effettive dalle Forze dell’ordine, ma anche quali sono le conseguenze, sia fattuali che psicologiche, di certi specifici comportamenti o di determinati modelli d’indagine. Dopodiché questa “cassetta degli attrezzi” viene applicata alle modalità di trasmissione di alcuni degli eventi che mediaticamente sono stati esemplari negli ultimi decenni. Anna Maria Franzoni, l’infanticidio di Cogne, è il caso scuola su quanto possa diventare perverso voyerismo la rappresentazione televisiva; gli omicidi di Sarah Scazzi, Carol Maltesi e Pamela Mastropietro sono casi esemplari dello sfruttamento mediatico del corpo femminile, seppur fatto a pezzi; e sullo sfondo di quasi tutte le ricostruzioni mediatiche dei delitti, a partire da Erika, Omar e la villetta di Novi Ligure, si trova il fantasma dell’uomo nero, dell’immigrato delinquente, elefante nella stanza di ogni racconto delittuoso in Italia da vent’anni a questa parte, tra l’altro in evidente e totale contrasto con i numeri e i fatti. Da un punto di vista politico, la conseguenza principale della confusione esistente tra la proiezione di una paura e una realtà molto differente, porta ai processi di emulazione, come quello accaduto per Luca Traini a Macerata, e a seguire dei vari mass shooter WASP, come Brevik in Norvegia o Tarrant in Nuova Zelanda. Quei morti sono una responsabilità che ricade su tutti coloro che fanno informazione e/o narrazione, perché se costruiamo immaginario, difficilmente questo resta tale.
È una questione di metodo: i bias cognitivi
La semplificazione è – come si è detto – una delle caratteristiche del discorso degli autori, uno sforzo imponente per passare al setaccio la lingua, così da espellere quanto di eccessivamente specialistico, sia che si tratti di critica letteraria, di criminologia o di psicoanalisi. Ed è proprio in virtù di questa semplificazione del linguaggio che il termine bias cognitivo arriva a essere espresso solamente dopo oltre centocinquanta pagine, anche se come concetto è emerso in moltissimi passaggi. Il motivo è evidente: a nessuno piace scoprire quanto e come la propria psiche è soggetta a meccanismi predeterminati indipendenti dalla nostra volontà, e questi errori – perché di questo si tratta – che noi compiamo, ci inducono ad accettare come vere delle operazioni di camuffamento e di ricollocamento, mistificazioni che quotidianamente effettuiamo sui dati di realtà. La spiegazione qui inserita è uno dei due passaggi del libro – pochissimi, vista la particolarità della materia e l’approccio non accademico che è stato adottato – in cui il testo diventa didascalico.
“Stando alla psicologia sperimentale, a fregare la nostra percezione entrano in gioco le cosiddette scorciatoie cognitive: meccanismi mentali precisi a cui gli esperti hanno dato nomi precisi. Meccanismi che chiunque, letteralmente chiunque, ha sperimentato o sperimenterà nel corso della sua esistenza”.
Il testo procede poi a spiegare l’effetto illusorio di verità, la dissonanza cognitiva, l’illusione dello schema, e così via, mostrando come la diffusa incapacità di affrontare la realtà dei fatti, per sostituirla con un’altra più adatta alla nostra mente, sia sostanzialmente un processo psicologico, quasi biologico che certamente ha poco o nulla a che fare con la coscienza e con la volontà, ma che proprio per questo è particolarmente pericoloso da stimolare.
“Ti chiedi mai come sia possibile che la gente convinta di qualcosa di assurdo – mettiamo: la piattezza della Terra – non cambi idea nemmeno quando i fatti la smentiscono in modo palese? Ecco: è per via del modo in cui funziona il cervello, che ci spinge di continuo a confermare le impressioni iniziali, portandoci ad accrescere le certezze, a volte fino a scommetterci la vita. […] L’illusione di frequenza, unita all’errore di attribuzione [due bias cognitivi NdA], crea un mondo di certezze che si possono sommare l’una all’altra, stratificandosi, fino a definire una idea incredibilmente fallace del mondo che ci circonda. Idea fallace che, però, più viene confermata e più sembra palesemente e innegabilmente l’unica realtà”.
Il secondo passaggio in cui il testo diventa – vorrei dire inevitabilmente – didascalico è nella trattazione del concetto di Panico morale, come riportata dal sociologo Stanley Cohen, dove sono individuate cinque fasi di questo processo, che – ai nostri occhi – sembrano descrivere nel dettaglio il processo di criminalizzazione degli immigrati in Italia.
Autocoscienza e azione
Gli ultimi capitoli del saggio sono dedicati al ruolo delle forze dell’ordine in questo processo di costruzione di una realtà alternativa. Anche in questo ambito va evidenziata la realtà della loro attività, e quanto, dati alla mano, l’apporto alla sicurezza dei cittadini sia decisamente mal valutato. Le grandi rivolte in Francia e Stati Uniti degli ultimi anni hanno mostrato, se mai ve ne fosse stato bisogno, il ruolo di garanti dello status quo che da sempre viene loro richiesto. Eppure, un pensiero che affronta anche il tema della violenza della polizia, così come quello della violenza in generale, è sempre più diffuso:
“Solo con l’uso della logica abbiamo capito che per non subire un crimine è necessario anche non commetterlo, e quindi condannarlo sempre, anche quando a compierlo è una persona che ci assomiglia o che riteniamo ‘dalla nostra parte’. È una verità insomma tutt’altro che innata […]. Per difenderci culturalmente dalla violenza dobbiamo accettare che non è giusto esercitarla a nostra volta: nemmeno se indossiamo una divisa”.
Non è quindi previsto un lieto fine, in questo testo, e gli autori ribadiscono quanto complesso e lungo sia il lavoro che ci attende. Quasi alla ricerca di una via da seguire, negli ultimi brevi paragrafi vengono quindi ribaditi molti dei passaggi analizzati nel corso del testo, come a controllare che le tessere del mosaico siano correttamente composte, e a fianco della sconfitta generazionale, tristemente ammessa, si ritrovano il senso di responsabilità dello scrittore, conscio del suo ruolo e del dovere, anche morale, di osservatore, quando spinge il suo processo di autocoscienza ad estendersi nella ricerca storica e nell’azione politica.
“È quello che accade di fronte a ogni delitto, a ogni azione orrenda compiuta qui nella realtà: il più delle volte non possiamo impedire che accada, e l’unica cosa che possiamo fare è osservare. Possiamo però scegliere in che modo guardare. Possiamo negare, fuggire la verità, mentire, e così in qualche modo far parte dell’orrore, oppure possiamo riconoscere di essere parte della realtà, di far parte del quadro, e scegliere di guardare le cose come stanno, con gli occhi aperti”.