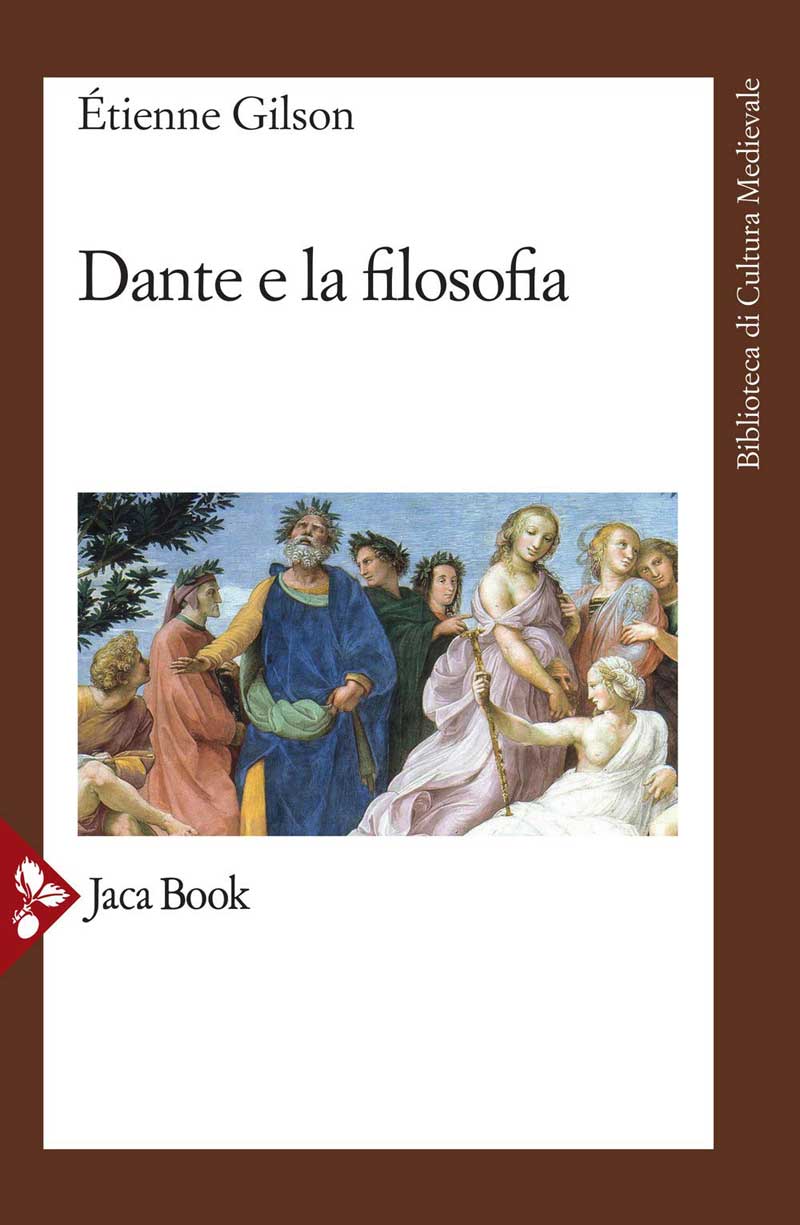In sincronia con le celebrazioni dantesche, la Jaca Book ristampa un classico della filosofia medievale: Dante e la filosofia di Étienne Gilson, filosofo e storico della filosofia francese fortemente condizionato dalla ‘fede’ neotomistica. Nonostante ciò le sue ricerche hanno contribuito a far conoscere modi e aspetti della filosofia medievale.
È opinione diffusa che il pensiero di Dante fosse in bilico fra aristotelismo (tomismo o averroismo) e neoplatonismo, scisso fra i sostenitori di una o dell’altra tesi. Gilson è scettico circa i tentativi di ricondurre la posizione di Dante al tomismo oppure all’averroismo: per Dante il problema filosofico non era tanto quello di definire l’essenza della filosofia, quanto di determinare degli spazi di azione, e il principio che fondava tale idea non era assolutamente conciliabile col tomismo. San Tommaso non conosceva che un solo fine ultimo: la beatitudine eterna, che non si poteva attingere se non attraverso la Chiesa; per Dante la beatitudine terrena era ben distinta da quella celeste, ed era anche indipendente dall’agire ecclesiastico. Quanto all’averroismo, Gilson considerando che l’essenza dell’averroismo autentico era la completa subordinazione della religione alla filosofia, riteneva che l’abisso tra esso e Dante fosse incolmabile. Per Dante esisteva un ordine soprannaturale distinto, valido in sé, e i cui mezzi propri, diretti verso il suo fine proprio, s’imponevano ugualmente a tutti gli uomini, compresi i filosofi.

Secondo Dante l’imperatore deriva il suo potere direttamente e immediatamente dal Dio trascendente, e senza trascendenza divina l’intero impianto politico dantesco crollerebbe. Gilson ritiene che il pensiero di Dante sarebbe privo di premesse metafisiche di tipo averroistico come le dottrine dell’intelletto unico, dell’eternità del mondo, della mortalità dell’anima; anzi su questi punti professa tesi esattamente opposte.
In realtà la formulazione originaria della dottrina dell’intelletto unico implica una angelologia, un Angelo dell’intelletto, che raggia la sapienza noetica sulle menti unite alla sua conoscenza. Gilson sembra non condividere l’idea – evidente nelle ricerche di Bruno Nardi (1884-1968) filosofo e dantista nostrano – che nell’angelologia medievale in genere, e in quella dantesca in particolare, sia avvenuta una contaminazione di antiche mitologie iraniche (zoroastriane, zurvanite), motivi giudaico-cristiani e gnostico-ermetici con elementi metafisici aristotelici (cfr. Nardi, 1967).
In verità, l’angelologia biblica sviluppata dai Padri della Chiesa che, oltre ai testi canonici attingeva a materiali apocrifi, niente aveva che fare con la dottrina aristotelica delle “intelligenze motrici”. Questa era nata dalla critica alle idee platoniche, che Platone s’era rappresentato come «universali reali» e “sostanze separate”, di per sé sussistenti e immateriali, ritenute “esemplari” e “cause” delle cose sensibili. A saldare l’unità del mondo sensibile col mondo intelligibile, recisa da Platone, e a spiegare in che modo questo possa dirsi “causa” di quello, lo Stagirita collocò, fra l’uno e l’altro, le “intelligenze motrici” dei cieli, cause dirette del movimento di questi, e cause indirette di tutti gli effetti che, col loro moto e con la loro luce, gli astri producono nella sfera dei quattro elementi. Certo, nel teorizzare questo, Aristotele s’era ispirato alla cosmologia del tempo che a ogni pianeta dava il nome d’una divinità celeste, e alle dottrine astrologiche che dei pianeti e delle costellazioni pretendevano di determinare gli speciali influssi sulla terra (apotelesmatika). Secondo questa partizione, la totalità dei cieli risultava suddivisa in intervalli regolari: ogni stella planetaria aveva un moto di rivoluzione, circolare, a partire dalla più esterna che era collegata alla successiva da un salto di quattro posizioni. Distribuite su di una circonferenza e collegate fra loro, le orbite di ogni singolo pianeta formavano quindi un eptagramma (cfr. Cassio Dione, 2000).

A ogni pianeta o divinità era assegnato un giorno della settimana, ogni giorno era così in intima unione musicale con il movimento dei cieli, i Pianeti si trasformavano quindi in una sorta di divinità onniscienti, theoi epopsioi “dèi che tutto vedono”. Aristotele stesso n’era pienamente consapevole, come dimostra nella Metafisica dove parla di antichissimi miti intorno agli dèi come “prime essenze”, considerandoli quasi ricordi di una arcaica disciplina, scampata a un successivo riciclo.
Tale credenza diffusa gli era sembrata contenere un nucleo di verità, che gli permetteva, da un lato, di risolvere il problema, posto e non risolto da Platone, di come le idee potessero dirsi cause della realtà sensibile, e, dall’altro, di dar ragione del finalismo che egemonizzava tutta la natura. E lo stesso Platone, nonostante l’immane e continuo sforzo di liberare dai miti popolari i concetti filosofici, aveva nel Timeo fatto ricorso alla presenza del Demiurgo che, buono e immune da invidia, fabbricava le cose che duravano eterne, e a una serie di “secondi dèi” ai quali era affidata la costruzione delle cose corruttibili; sì che questi “secondi dèi” sembravano esercitare la funzione delle intelligenze motrici di Aristotele, le quali, al dire di Dante “fabbricano col cielo queste cose di qua giuso” (Dante, 2018). Ma tanto il Demiurgo quanto i “secondi dèi” platonici appaiono alle menti critiche nient’altro che figurazioni poetiche; le intelligenze celesti d’Aristotele, invece, sono vissute come anelli di una catena in cui si svolge il reale.
Quanto al numero delle intelligenze motrici, Dante sa che Aristotele nella Metafisica aveva dedotto il numero di 55 oppure 47 intelligenze dal numero dei movimenti siderei, quale a lui risultava dalla critica alla teoria planetaria di Eudosso di Cnido e di Callippo di Cizico; ché se, oltre a queste, ve ne fossero altre, anch’esse dovrebbero pur muovere un cielo. In altri termini, nella Metafisica Aristotele non sembra concepire l’esistenza di altre menti separate oltre a quelle ritenute necessarie per spiegare i movimenti celesti. E questo fa cadere l’ipotesi aristotelica, cioè tomistica.

Gilson ritiene che nella Monarchia noi possiamo osservare un Dante filosoficamente creatore; un moralista, piuttosto che un metafisico oppure un teologo. La riforma morale dantesca sarebbe fondata sulle idee di autorità, ordine, obbedienza, intese nel significato più forte e nel loro fondamento metafisico. Il referente filosofico è sempre – e ovviamente – Aristotele; la sua autorità non significa soltanto che è il maggiore dei filosofi antichi, ma che Dio ha sottomesso a lui la morale. La giustizia appare come fedeltà alle autorità rese sacre dall’origine divina. In dipendenza da questa morale del rispetto dell’ordine, Gilson intende la giustizia come il tema conduttore dell’opera dantesca. Una disposizione che definisce la virtù come accettazione incondizionata dell’ordine, porta Gilson a criticare la tesi dell’umanesimo di Dante, una visione tutto sommato cristianizzante che tende a disinnescare il valore fortemente eversivo del messaggio dantesco.
Si dovrebbe quindi consigliare al lettore di dimenticare le faide tra guelfi e ghibellini, di dimenticare la filosofia scolastica, di dimenticare anche le allusioni mitologiche e i versi di Virgilio che Dante ripete, a volte migliorandoli, per quanto eccellenti siano in latino, e osservare il poeta da una visuale più concreta. Il sapere esibito da Dante è enciclopedico, una conoscenza distillata in un racconto. Oggi uno scrittore che racconta qualcosa di sovrannaturale è un individuo perplesso che si rivolge a lettori increduli e deve quindi preparare lo spazio fantasmatico in cui far muovere i suoi personaggi; un sovrannaturale per la verità difficile da scodellare, dal momento che la realtà pandemica ha superato ampiamente ogni aspettativa fantastica.
Dante era più fortunato, non ne aveva bisogno: “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura”. La selva sarà pure allegorica, ma noi crediamo alla sua fisicità; le sue avventure nell’aldilà sono inventate di sana pianta, ma crediamo alle sue visioni. Ma forse Dante non era un visionario; una visione è breve: è concepibile una visione prolungata quanto quella della Divina Commedia? Lì è tutto talmente vivido che alla fine ci convinciamo che Dante credesse davvero nel suo altro mondo, così come credeva alle cosmologie e alle apocalissi che raccontava.

La Commedia è scritta in prima persona, Dante è uno dei personaggi del suo poema. Una novità per l’epoca. Leggiamo di un Dante atterrito all’Inferno; deve esserlo non perché fosse un fifone, bensì perché la sua paura inducesse a credere nell’Inferno. Dante è atterrito, ha paura, si interroga sulle cose. Sappiamo ciò che pensa non da ciò che dice, ma dalla poeticità, dalla intonazione, dall’accento della sua lingua. C’è poi un altro luogo poco ospitale, uno spazio intermedio che di lì a poco era stato ‘creato’, il Purgatorio (cfr. Le Goff, 1982).
Già l’antichità conosceva una classica suddivisione dell’Ade in tre livelli: Stige, Campi Elisi, Tartaro, nominata sin dal Peri tōn ouranōn di Eraclide Pontico (IV sec. a.C.) in chiave astrale, e le tre porte in cui transitavano le anime erano tre passaggi ricavati negli spazi stellari. Collocati rispettivamente nella costellazione dello Scorpione, tra le costellazioni del Leone e del Cancro, e infine tra le costellazioni dell’Acquario e dei Pesci.
La terza, la via del Tartaro, frequentata da empi e criminali, dovrebbe corrispondere alla costellazione dello Scorpione. Affine a tale triplice escatologia era un dialogo platonico, il Gorgia; l’epilogo sul destino delle anime (523 b-524 a) ha infatti ispirato elaborazioni successive. Due delle vie del trivio sono indicate: l’una conduce al Tartaro, l’altra alle Isole dei Beati. La terza, passata sotto silenzio nel dialogo, diventa il mondo dei demoni aerei, un’idea molto pitagorica. L’Ade non è più un insieme sotterraneo di caverne e voragini di cui la più abissale è il Tartaro (Fedone) – e il Piriflegetonte uno dei suoi melmosi fiumi –, ma l’infinito spazio in cui si muovono Stelle e Pianeti. Ed è la tirannia aeriforme, astrale, a definire il dominio della reincarnazione, la metempsicosi: a questo si riferiscono le allusioni dell’Asclepio (cfr. Nock, Festugière, 2005) ai destini umani diversificati in 360 possibilità, come i gradi dello Zodiaco.
È il grande Demoniarca, il Demone dell’aria a giudicare ed enunciare il verdetto sull’anima, comminandole, a seconda dei casi, una punizione infinita (æternæ poenæ), una catarsi e reincarnazione, oppure una beatitudine eterna che sigillerà e porrà termine alle trasmigrazioni da un corpo a un altro. Queste tre vie nell’immaginario occidentale si tradurranno nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso danteschi. Ma l’atto di nascita del Purgatorio propriamente detto sembra si possa collocare solamente nel XII secolo e si collega in parte all’idea di un “fuoco purgatorio” elaborata dalla teologia greca e latina dei primi secoli.

L’intento di base è infatti quella di trovare un succedaneo e sostituto credibile alla nozione classica di trasmigrazione delle anime al fine di una purificazione e di una “nuova nascita”, palingenesia. La tradizione patristica sull’esistenza di un “fuoco purgatorio” è strettamente relata – almeno in principio – con l’esistenza del “fuoco del giudizio”, anche perché nei primi secoli dell’era cristiana le tendenze escatologiche pregresse hanno certamente frenato la riflessione sull’aldilà, soprattutto per quanto concerneva il destino delle anime nel periodo intercorrente tra la morte individuale e il Giudizio finale. Si può quindi dire che la vera storia del Purgatorio si apra con un paradosso, proprio perché i primi autori cristiani che trattano del “fuoco purgatorio”, sono due esponenti della scuola alessandrina: Clemente e Origene. Due neoplatonici (cristiani) d’eccellenza.
C’è infine il problema – taciuto da Gilson – di collocare la filosofia di Dante in un quadro più propriamente misterico ed ermetico, anche se ipotizzare una derivazione diretta fra le suggestioni di Dante e i testi ermetici è argomento insidioso. Come succedaneo si può parlare di un generico sfondo ermetico-neoplatonico in cui si sviluppò il pensiero dantesco. Di fatto gli scritti dei neoplatonici sono infarciti di detti attribuiti a Ermete Trismegisto, ché a volte risulta difficile discernere quanto ci sia di “ermetico” nel neoplatonismo e quanto ci sia di “neoplatonico” nell’ermetismo, tenendo anche conto dell’universo culturalmente fluido entro il quale gli esegeti di Platone andavano elaborando i propri insegnamenti. È il caso del Liber viginti quattuor philosophorum, un enigmatico testo – editato magistralmente anni fa da Paolo Lucentini – che raccoglie insegnamenti neoplatonici ed ermetici in uno sfondo apparentemente cristianizzato (cfr. Anonimo, 1999). Lo scritto vuole essere, così racconta il Prologo, un compendio delle definizioni di Dio enunciate da ventiquattro sapienti riuniti in simposio. Il libro è databile alla metà del XII secolo, e ha influito attivamente sull’opera di filosofi come Alano di Lilla (Regulae caelestis iuris, Sermo de sphaera intelligibili).

È stata inoltre sottolineata la fortuna del Liber viginti quattuor philosophorum in Paradiso XXXIII e nei suoi commentatori: Benvenuto da Imola, Commentum super Dantis Aldigherii Comoediam, Giovanni Bertoldi da Serravalle, Translatio et commentum totius libri Dantis Aldigherii cum textu Italico fratris Bartholomaei a Colle, oltre al commento in volgare di Cristoforo Landino.
È inoltre presente il nome di Ermete negli stessi commenti a Dante; così Landino, citando il Poimandres, racconta che “Mercurio Trismegisto havea diffinito Idio essere una spera circulare” (Landino 2001). Così Dante (nel secondo canto del Paradiso) può riassumere l’ordine dei cieli e la loro gerarchica dipendenza dalla prima sfera in una terzina, ogni parola della quale traduce un concetto di filosofia ermetica e neoplatonica:
“Questi organi del mondo così vanno,
come tu vedi ormai, di grado in grado,
che di su prendono e di sotto fanno”.
Il poeta sembra qui debitore di Giamblico attraverso Simplicio, in particolare dal commento al De coelo aristotelico fatto da Simplicio: l’idea centrale del neoplatonismo è infatti quella di una causalità per il tramite di una emanazione graduale; dall’Uno, come dal centro oscuro di una fiamma, emana la Mente, il Nous, che è luce irradiante un’aura attorno a sé, il cui splendore si attenua in intensità quanto più ci si allontana dalla prima fonte luminosa. Gli scolastici del tempo di Dante pur non conoscendo gli scritti di Plotino, se non qualche breve citazione in Macrobio e in altri autori le cui opere erano note a tutti, interagivano con il pensiero neoplatonico attraverso la filosofia di Alfarabi e di Avicenna, gli scritti dello Pseudo-Dionigi Areopagita, l’ignoto autore del Liber de causis attribuito per qualche tempo ad Aristotele, e per la conoscenza diretta degli Elementi di teologia di Proclo tradotti in latino nel 1268 dal domenicano fiammingo Guglielmo di Moerbeke, lo stesso a cui si deve la traduzione del commentario di Simplicio. Di fatto Avicenna nella Metafisica, in sintonia con una idea emanatistica di origine neoplatonica, poneva nel cielo una gerarchia di sfere animate ciascuna da un principio vitale e mosse da altrettante intelligenze separate, di cui la superiore era causa di quella inferiore, in una struttura ordinata che dall’Uno portava al molteplice (Avicenna, 2002).

Tale corrispondenza tra il principio divino e i molti, il cosmo concepito come unitario e retto da armoniche relazioni fra le sue parti, e soprattutto l’uomo microcosmo, signore dei quattro elementi, capace di agire sulla materia, sono argomenti che s’incontrano anche nell’Asclepio, e in un altro testo ermetico conosciuto al tempo di Dante, la Tabula smaragdina, lo scritto di riferimento della disciplina alchimica medievale. D’altronde la filosofia nella sua forma platonica, corrisponde a una conversione nell’esperienza della morte.
La filosofia nasce in tale dimensione: è quanto accade allorché l’anima, esercitandosi a morire, si prepara a liberarsi dal corpo, e dunque anche dal demonico e dall’orgiastico. D’altronde proprio il mysterium tremendum esibito nella Commedia svela l’esperienza della morte nella propria singolarità assoluta, la morte è precisamente ciò che nessuno può patire né affrontare al mio posto, per questo Dante si fa egli stesso protagonista. Il resto è contemplazione delle ‘pene’ o dei ‘godimenti’ altrui.
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Roberto Mercuri, Einaudi, Torino, 2021.
- Dante Alighieri, Convivio, BUR Rizzoli, Milano, 2018.
- Dante Alighieri, Monarchia, BUR Rizzoli, Milano, 1998.
- Anonimo, Il libro dei ventiquattro filosofi, a cura di Paolo Lucentini, Adelphi Milano, 1999.
- Anonimo, Asclepio, in Arthur Darby Nock, André-Jean Festugière, Corpus Hermeticum, a cura di Ilaria Ramelli, Bompiani, Milano 2005.
- Avicenna, Metafisica, Bompiani, Milano, 2002.
- Cassio Dione, Storia romana, I. Libri 36-38, trad. e cur. di Giuseppe Norcio, BUR Rizzoli, Milano, 2000.
- André-Jean Festugière, La rivelazione di Ermete Trismegisto: Vol. 1: L’astrologia e le scienze occulte; Vol. 2: Il Dio cosmico, a cura di M. Neri, Mimesis, Milano-Udine, 2019-2020.
- Peter Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, Il Saggiatore, Milano 2007.
- Cristoforo Landino, Comento sopra la Comedia, a cura di Paolo Procaccioli, Salerno Editrice, Roma, 2001.
- Jacques Le Goff, La nascita del Purgatorio, Einaudi, Torino 1982.
- Paolo Lucentini, Platonismo, ermetismo, eresia nel medioevo, Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales, Brepols, Louvain-la-Neuve, Belgio, 2007.
- Bruno Nardi, Saggi di filosofia dantesca, La Nuova Italia, Firenze 1967.