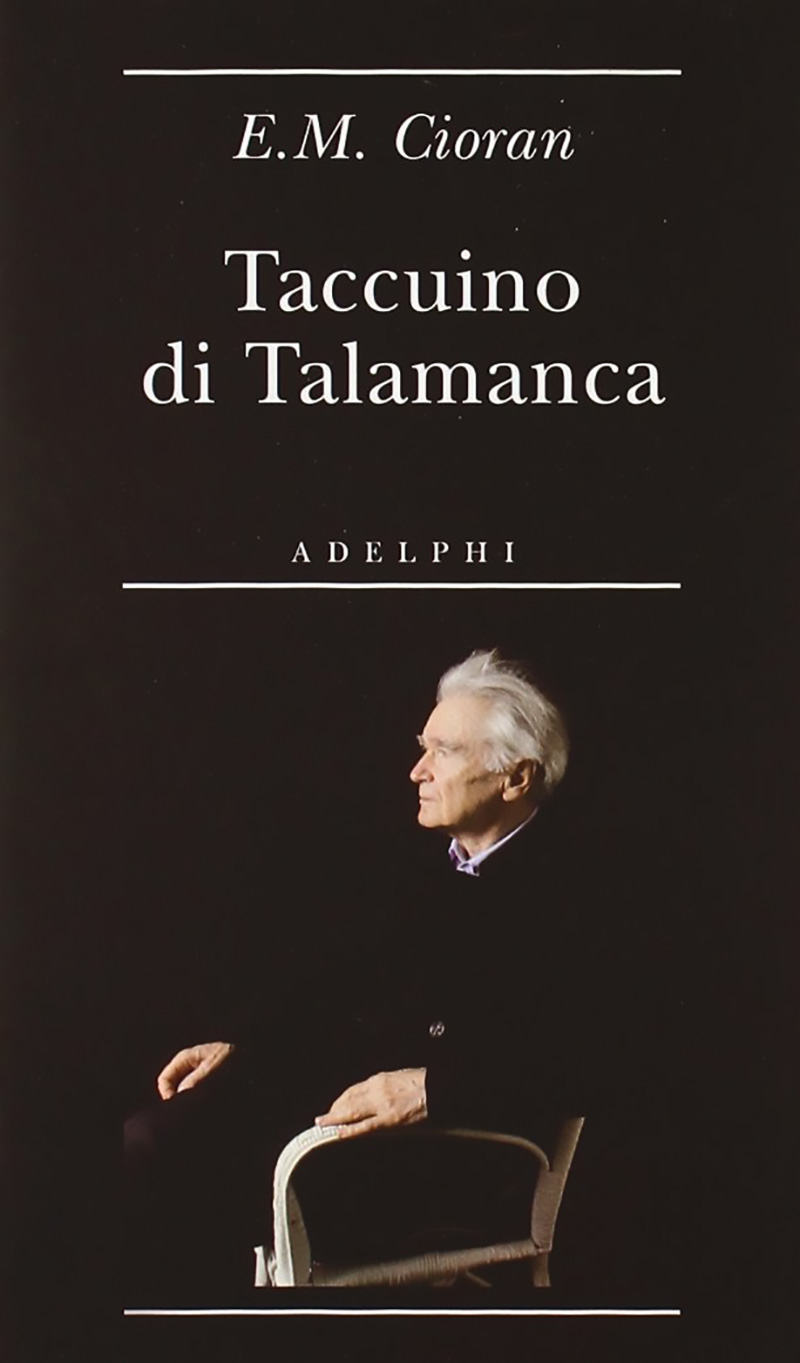Nel Taccuino di Talamanca Emil Cioran (1911-1995), filosofo e scrittore di origine romena, trasferitosi all’età di 26 anni a Parigi, l’odiosamata ville lumière nella quale ha vissuto e scritto per il resto della sua esistenza, ricorda un avvenimento del lontano passato, che ha tutte le sembianze di una delusione d’amore:
“Tutto ciò che in me è vero proviene dalle timidezze della mia gioventù. A loro devo quello che sono, nel senso migliore della parola. Senza di esse non sarei letteralmente nulla, e non conoscerei tregua nella vergogna di me stesso. Che cosa non ho sofferto, da giovane, per causa loro. E ora sono queste sofferenze che mi riscattano ai miei occhi. (L’altro giorno mi sono ricordato di un momento capitale e particolarmente doloroso della mia adolescenza; amavo segretamente una ragazzina di Sibiu, Cela Schian, che doveva avere quindici anni; io ne avevo sedici. Per niente al mondo avrei osato rivolgerle la parola; la mia famiglia conosceva la sua; avrei potuto avere delle occasioni per avvicinarla. Ma questo andava al di là delle mie forze. Per due anni ho vissuto in preda a tormenti infernali. Un giorno, nei dintorni di Sibiu, nel folto di una foresta dove mi trovavo con mio fratello, scorgo quella ragazza in compagnia di un compagno di scuola, il più antipatico di tutti. Fu per me un colpo a stento tollerabile. Ancora adesso mi fa male. Da quel momento decisi che bisognava farla finita, che non era degno di me incassare il «tradimento». Cominciai a staccarmi dalla ragazza, a disprezzarla e infine a odiarla. Mi ricordo che nel momento in cui la giovane «coppia» passava, stavo leggendo Shakespeare. Darei chissà che cosa per sapere quale opera. Non riesco a ricordarlo. Ma quell’istante ha deciso della mia «carriera», di tutto il mio futuro. Ne derivarono anni di completa solitudine. E io divenni quello che dovevo divenire)”.
La carriera cui allude Cioran in questo ricordo è quella del pessimista radicale, di un Giacomo Leopardi del ventesimo secolo, che ama scrivere per lampi, per intuizioni abbaglianti e caustiche, per aforismi taglienti e scolpiti nella pietra del disinganno, una condizione dell’anima di cui è stato (ed è) uno dei massimi interpreti nel Novecento. Se dovessimo inquadrare questo autore in una precisa corrente del pensiero filosofico novecentesco, non sarebbe troppo azzardato collocarlo nell’ambito dell’esistenzialismo: il suo primo libro (Al culmine della disperazione) uscì nel 1934, proprio nel cuore del decennio (1930-1940) che vide il maggior sviluppo di questo movimento filosofico e culturale che da Søren Kierkegaard, cioè dalla sorgente dell’esistenzialismo, tocca il suo apice in Martin Heidegger: Essere e Tempo (Sein und Zeit) è un’opera capitale tutt’altro che sconosciuta a Cioran, che però espresse non pochi dubbi sull’oscurità del linguaggio heideggeriano. A questo proposito, vale ricordare un aneddoto gustoso. In una delle interviste raccolte in Un apolide metafisico (Conversazioni) racconta che la lettura di Heidegger fu molto importante per la sua attività letteraria: “Heidegger mi insegnò come «non» si doveva scrivere”(Cioran, 2004) .

Elegante e preciso, dotto ma non pedante, incline al lirismo e alla poesia, spesso ironico, sempre provocatorio fino al paradosso, mai noioso nonostante l’irredimibile negatività della sua Weltanschauung che oscilla tra sobria disperazione e sorriso ironico/beffardo, Cioran non è un filosofo sistematico né d’accademia: è un pensatore che arriva direttamente al nucleo essenziale dell’esistenza umana, evitando le tentazioni speculative e gli esibizionismi di mestiere. La concisione e la densità del suo stile devono più alla tradizione del pensiero aforismatico (da Eraclito ai moralisti francesi), che conferisce alla voce di Cioran – modulata con eleganza ora rassegnata ora dissacrante – un timbro deciso ed esemplare, mai superbo anche nelle più amare stoccate contro tutte le certezze positive che tendono a nascondere quel vuoto di Senso chiaramente avvertibile nella visione essenziale del nulla cui si riduce la vita senza il conforto di un Dio razionalmente accessibile.
Le affinità con Leopardi
Non diversamente da Giacomo Leopardi – scrittore che conosceva superficialmente, ma con il quale ha molto in comune – in Cioran si trova uno degli esempi più compiuti di come l’energia vitale e creativa non è annichilita o contraddetta dal pessimismo, che non è un atteggiamento pregiudiziale o precostituito, ma la condizione dello spirito più coerente ai risultati meditativi di una consapevolezza estrema illuminata dal duro esercizio del disincanto, dall’ingrato lavoro di lucida smerigliatura della ragione che sottrae alla realtà le incrostazioni delle retoriche, delle fedi, dei proclami, delle sovrastrutture ideologiche e culturali, riportando alla visione essenziale la nudità dell’essere nel suo inesplicabile e assurdo non-senso. Il pessimismo cioraniano, come d’altronde quello leopardiano, non lascia vie d’uscita. Ma per Cioran, come per Leopardi, l’accettazione del disinganno, la consapevolezza che la vita non abbia realmente senso, non nasconde intenti distruttivi, ma presuppone l’abbandono delle false certezze, delle ipocrisie e delle facili illusioni tipiche del positive thinking. Nella disperazione cioraniana scintilla come un corrusco bagliore di speranza ed energia:
“Sebbene io abbia della vita una concezione tetra, ho sempre nutrito un grande amore per l’esistenza, un amore talmente grande da convertirsi in negazione della vita, perché non possedevo i mezzi per soddisfare la mia voglia di vivere. Quindi non sono tanto un uomo deluso quanto piuttosto uno sfibrato interiormente dai troppi sforzi”
(Cioran, 2004).
Il perimetro delle letture che hanno contribuito alla formazione culturale e spirituale di Cioran è difficilmente delimitabile per la diversità e l’ampiezza degli orizzonti. Fra gli autori studiati in giovane età, che lui stesso ritenne decisivi sull’evoluzione del suo pensiero, spiccano i grandi moralisti francesi come Blaise Pascal, François de La Rochefoucauld, Chamfort, François-René de Chateaubriand; e autori meno conosciuti in Italia, ma stimolanti per le loro riflessioni su alcuni aspetti dell’esistenza (la noia, in primis), come la marchesa Marie du Deffand ed Étienne de Sénancour. Non possono mancare i grandi scrittori russi da Fëdor Dostoevskij (secondo Cioran, I demoni è il più grande libro dell’Ottocento) ai mistici come Lev Šestov. Fra i filosofi che più lesse e apprezzò figurano, oltre a Kierkegaard, i tedeschi Georg Simmel, Friedrich Nietzsche, e Otto Weininger, senza escludere la filosofia orientale (indù e buddista), per la quale Cioran nutrirà sempre, come Arthur Schopenhauer, una particolare predilezione. Non meno importante è stato l’influsso della Bibbia, soprattutto degli scritti veterotestamentari con più spiccata vena pessimistica (per esempio, il Qoèlet o Ecclesiaste), e dello gnosticismo.
Il Taccuino di Talamanca apre con un’annotazione fra le più frappantes e paradigmatiche riguardo le letture e le ascendenze spirituali di Emil Cioran:
“Nel Vangelo secondo Tommaso, Gesù, cui viene chiesto dove si può fare la propria salvezza, risponde: «Ovunque non vi siano donne». Risposta gnostica se mai ve ne furono”.
Composto nell’estate 1966, a Talamanca, villaggio sull’isola di Ibiza, nel corso di una delle crisi più profonde sofferte dallo scrittore, il Taccuino costituisce una breve crestomazia di appunti e pensieri brevi – schegge ora acuminate, ora fulminanti, spesso incandescenti – tipici di gran parte della prosa cioraniana. La citazione dal Vangelo secondo Tommaso non deve essere interpretata in chiave misogina, anche perché Cioran amava molto il gentil sesso:
“Adoro le donne. Preferisco le donne agli uomini in assoluto. Ecco la ragione: sono più equilibrate degli uomini, quindi più capaci di capire le cose che gli uomini non possono capire… Ma a diciassette anni avevo letto Otto Weininger. Scrisse un libro contro le donne, il libro è straordinario, influenzò Ludwig Wittgenstein”
(Cioran, 2004).
Un’altra citazione, da uno dei libri più noti di Cioran, L’inconveniente di essere nati, aiuta a mettere a fuoco il significato profondo di quella citazione gnostica:
“Nel Vangelo secondo gli Egizi Gesù proclama: «Gli uomini saranno preda della morte finché le donne figlieranno». E precisa: «Sono venuto a distruggere le opere della donna». Quando si frequentano le verità estreme degli gnostici si vorrebbe andare, se possibile, ancora oltre, dire qualcosa di mai detto, che pietrifichi o polverizzi la storia, qualcosa che scaturisca da un neronismo cosmico, da una demenza commisurata alla materia”
(Cioran, 1999).
La consapevolezza che la vita umana, e quindi il male e la morte, siano il risultato di una “caduta” (in questo caso la “caduta” ha inizio storico con la nascita di un individuo) rappresenta un punto di raccordo fondamentale con il pensiero gnostico che in Cioran trova una delle forme espositive più chiare e fulminee. Pur professandosi ateo, l’autore definisce il suo atteggiamento nei termini di un “teologo non credente, di un teologo ateo”:
“Se fossi onnipotente – Dio o Diavolo – eliminerei l’uomo. Di lui è stato detto tutto nel Genesi. Attratto da ciò che lo nega, ha optato per il rischio, ossia per la storia. Fin dall’inizio ha scelto il Male, e senza quell’esilio la storia non ci sarebbe stata… l’uomo ha scelto la conoscenza e quindi il dramma… Non credo al peccato originale in senso cristiano, ma senza quello non si può capire la storia universale”
(Cioran, 2004).
Che per Cioran il peccato originale possa ricollegarsi all’irresistibile, illogico e indiscriminato richiamo alla riproduzione, è evidente:
“Non si tratta tanto di combattere l’appetito di vivere, quanto il gusto della «discendenza». I genitori sono dei provocatori, o dei pazzi. Che l’ultimo dei malnati abbia facoltà di dare vita, di «mettere al mondo» – può esserci qualcosa di più demoralizzante?“
(Cioran, 1997).
Il modo migliore di ricordare Cioran è partire da uno dei luoghi tematici più frequentemente visitati nelle sue meditazioni: il sentimento del nulla e del non-senso di fronte allo spettacolo dell’esistenza umana e della storia. Il termine “sentimento” è quanto mai aderente all’approccio riflessivo di chi, come Cioran e, prima di lui, Leopardi, percepiscono il vuoto ontologico con la scioccante immediatezza di una rivelazione: l’assurdità della vita s’impone come intuizione devastante, al di là delle motivazioni personali, non importa se negative o positive. La consapevolezza del nulla azzera il cammino esistenziale e riporta nel deserto della meditazione: situazione tutt’altro che sconosciuta ai primi cristiani, almeno dal Battista fino a quando i conventi non fungevano solo da agriturismi. Per un lungo tratto di questo percorso di allontanamento – spirituale e intellettuale – dalle finzioni della realtà, il disinganno del pessimista e la speranza di chi cerca Dio procedono come compagni muti, familiari l’uno all’altro, anche se diversi nella meta cui tendono. Bisogna infatti sfatare il falso mito secondo il quale il pessimismo è in antitesi con lo spirito religioso in generale e cristiano in particolare.
“Ho trascorso parte della mia vita a leggere i mistici, forse per trovarvi una conferma della mia personale esperienza. Li ho letti con grande avidità”
(Cioran, 2004).
L’ateismo del pessimista nasce – o viene alimentato – da una violenta crisi esistenziale o da un disagio che conduce l’individuo dotato di particolare sensibilità e cultura, attraverso il ponte dell’isolamento, alla rivelazione dell’inanità del mondo; esperienza molto religiosa. Commentando lo stato d’animo nel quale si trovava prima e durante il periodo di elaborazione del suo libro d’esordio, Cioran racconta:
“È stato tra il 1926 e il 1927, epoca di malessere continuo. Ogni notte girovagavo per le strade in preda a ossessioni funebri. In quel periodo di tensione interiore ho fatto più volte l’esperienza dell’estasi. Comunque ho vissuto istanti in cui si è trasportati fuori dalle apparenze. Ti assale un brivido improvviso, cogliendoti del tutto impreparato. L’individuo si ritrova immerso in una pienezza straordinaria, o meglio in un vuoto trionfale. È stata un’esperienza capitale la rivelazione diretta dell’inanità di ogni cosa. Quelle poche illuminazioni mi hanno fatto accedere alla conoscenza della felicità suprema di cui parlano i mistici”
(Cioran, 2004).
Le esperienze interiori vissute in quell’epoca di “malessere continuo” formeranno la base per l’elaborazione del suo primo libro, Al culmine della disperazione, scritto nel 1933, all’età di ventidue anni, a Sibiu, in Transilvania, suo luogo natale. Come precisato nella prefazione di Verena von der Heyden-Rynsch al Taccuino di Talamanca, Cioran aveva tre patrie: quella dell’infanzia, la Romania; quella della lingua, la Francia; e quella dell’anima, la Spagna, paese di estasi mistiche, ma anche del “desengaño”. Fra i mistici da lui frequentati nelle sue prime letture, spicca Santa Teresa d’Ávila, così come Il sentimento tragico della vita di Miguel de Unamuno fu uno dei suoi libri prediletti. La Spagna è per Cioran una delle patrie ideali della spiritualità: una nazione “gravida di Dio” come la Russia. Questa tripla appartenenza geografico-spirituale (Romania, Francia e Spagna) contribuisce a creare in Cioran l’amalgama umorale e culturale alla base del suo stile e della sua visione della vita, che abbraccia il lirismo, l’energia scardinatrice e barbara riconducibile allo spirito balcanico, la tensione mistica, e un illuministico esprit de clarté. Sull’Europa Cioran ha espresso valutazioni tutt’altro che ottimistiche, ma non prive di un alone profetico: nell’intervista con Esther Seligson lo scrittore commentava:
“L’Europa, gli Stati Uniti e la Russia scompariranno. Sono le nazioni che hanno fatto la storia. L’apocalisse atomica è diventata una visione da donnette: indubbiamente è verosimile e fondata, ma non è interessante. Interessante è il destino dell’uomo, al di là di tutti questi incidenti…”
(Cioran, 2004).
E nell’intervista con Benjamin Ivry, Cioran diceva espressamente:
“L’Europa non ha più vitalità. È una civiltà vecchia… In futuro l’Europa passerà in second’ordine. Credo più nel futuro dell’America Latina che in quello dell’Europa. Anche se i regimi sono orrendi, c’è vitalità da quelle parti. Non sono popoli logori. Qui, invece, l’Europa si è autodistrutta.”
(Cioran, 2004).
Come conciliare questo spegnimento progressivo dell’Europa con il suo invidiabile e, sotto molti aspetti, ineguagliabile livello raggiunto nei campi più diversi, dalla cultura alla musica, dall’arte alla filosofia? Per Cioran la risposta è chiara: l’esaurimento dell’Europa è la conseguenza di un estenuarsi vitale e morale, politico ed economico, e non esclusivamente culturale, esattamente come avvenne per l’impero romano nella sua lunga fase declinante. Un popolo “barbaro” (nel senso di “nuovo e vitale” che subentra a una civiltà in crisi) non può permettersi, e nemmeno concepire, il pessimismo, che è la forma più alta e autentica di pensiero, possibile solo quando una civiltà ha raggiunto la maturità del suo ciclo di vita storico-economico. Il progresso e l’espansionismo, intesi nella loro accezione meramente economica, scientifica e tecnologica (e anche nelle loro catastrofiche conseguenze sull’umanità e l’ambiente) sono semplicemente incompatibili con la verità filosofica del pessimista. Oltre che filosofica, la rivelazione dell’inanità di ogni cosa è infatti un’esperienza mistica perché riporta l’uomo al centro dell’essere: questo “centro” può essere Dio, il nulla o un nucleo vitale e indistinto di forze primigenie e irrazionali:
“A mano a mano che il divario che ci separa dal mondo cresce dolorosamente, l’uomo si avvicina sempre più alle sue realtà interiori, fino a scoprire la morte nella propria soggettività. Un processo di interiorizzazione attinge il centro sostanziale della soggettività, superando tutte le forme sociali che lo rivestono. Una volta oltrepassato il nucleo, l’interiorizzazione, progressiva e parossistica, scopre una regione dove vita e morte si intrecciano, dove l’uomo non si è separato attraverso l’individuazione delle scaturigini dell’esistenza, e dove il ritmo folle e demoniaco della vita pulsa in tutta la sua irrazionalità”
(Cioran, 1998).
L’esperienza del non-senso nella vita è fondamentale nel pensiero cioraniano. La scoperta del non-senso apre le porte al vuoto, al nulla che, inteso come intuizione di irrealtà, diventa la vera sostanza dell’essere, e in particolare della vita. Nell’impossibilità o incapacità di credere in Dio, la costante consapevolezza di questa assurdità fa sì che il nulla attragga il pessimista nella sua centralità, nella sua unicità, nel gorgo inesprimibile della sua autentica Verità, proprio come il Dio di Dante, un Punto in cui tutto inizia e tutto finisce, al quale tutto tende e nel quale tutto si appaga. Adesso si comprenderà perché fra un pessimista e un credente non vi è differenza in termini di tensione trascendentale: il primo sente un trasporto irresistibile verso il nulla come la più autentica Verità, il secondo anela a Dio per riconciliarsi alla sua infinita Bontà. Ma mentre il pessimista non deve fare sforzi particolari perché l’assurdo è una realtà oggettiva (per quanto percepita da pochi), al credente è richiesto un sacrificio disumano: credere in un Dio nascosto, refrattario ad ogni dimostrazione razionale, e soprattutto ad ogni appello. E cosa c’è di più atroce, per un uomo, essere vivente dotato di razionalità, del dovere sacrificare sull’altare della Fede ciò per cui egli è tale per essenza, ovvero la razionalità stessa? E qui si arriva al problema di Dio, cui Cioran ha dedicato un libro specifico, Il funesto demiurgo (Cioran, 1997), ma che è trattato ovunque nelle sue opere.
Dio, gli dei e il demiurgo
Fra i capitoli più felici di questo pamphlet spicca sicuramente quello intitolato Gli dèi nuovi nel quale l’autore riprende provocatoriamente le parti di un Celso del Novecento per riabilitare il politeismo che, se non altro, aveva il vantaggio di distribuire in modo più vario e democratico l’anelito spirituale, mentre l’ammissione di un solo dio concentra ed esaspera il fervore religioso convertendolo in fede. Ed è – la storia lo dimostra ancora oggi – la fede in un solo dio a trasformare l’uomo in un fanatico. Senza contare il fatto che attribuire la creazione a un solo Dio comporta necessariamente la paternità unica anche di tutti gli errori e i mali che caratterizzano il prodotto finale: a meno che non si evochi – come fecero gli gnostici – un demiurgo che, come nota ironicamente Cioran, avrebbe usato in modo molto approssimativo la delega a creare e gestire questo mondo:
“Manifestamente, il dio buono non era attrezzato per creare: possiede tutto, fuorché l’onnipotenza. Grande per le sue deficienze (bontà e anemia vanno di pari passo), è il prototipo dell’inefficacia: non può aiutare nessuno”
(Cioran, 1997).
Alla rivelazione dell’inanità di ogni cosa, e quindi dell’esperienza del nulla, si ricollega un altro grande tema prediletto dal pensatore romeno: il cafard. Nel vocabolario cioraniano la parola francese cafard (letteralmente: scarafaggio) ha la stessa ricorrenza e il medesimo peso della noia nel pensiero leopardiano. Anche nel Taccuino di Talamanca si trova una breve riflessione su questo stato d’animo così familiare a Cioran:
“Il cafard appare come un’angoscia svalutata. In realtà è più virulento dell’angoscia; ma non si dà tante arie come lei. È più modesto, ma anche più terribile, perché può sorgere in qualsiasi momento, mentre l’angoscia, più pretenziosa, si manifesta solo nelle grandi occasioni”.
Nell’intervista con Helga Perz, pubblicata negli Entretiens, si trova una definizione ancora più precisa di questo sentimento:
“Il paradosso della mia natura è che provo amore per l’esistenza ma nello stesso tempo ogni mio pensiero è ostile alla vita. Ho sempre intuito e avvertito il lato negativo della vita, il vuoto di tutto. Ho essenzialmente sofferto di noia. Forse è una cosa innata in me. Non posso farci niente. La parola francese che designa questa disposizione è assolutamente intraducibile: cafard. Io ho il cafard. Non si può fare niente per combatterlo. Deve passare da solo”
(Cioran, 2004).
Il cafard, la noia cioraniana, il senso del vuoto si legano, a volte direttamente, anche al tema del lavoro e dell’attività umana. Cioran ha sempre dichiarato – senza esibizioni di orgoglio o snobismo intellettuale – di non aver mai potuto svolgere un impiego, una normale occupazione; era l’effetto meduseo delle sue stesse riflessioni (in particolare sulla morte e sul vuoto esistenziale e metafisico) che gli impediva di sostenere lo stress di un prolungato impegno lavorativo. Per chi vive costantemente nella consapevolezza del vuoto e della morte, anche svolgere le mansioni più elementari può diventare pesante. Figuriamoci fare professioni, lavori o carriere che richiedono un’adesione pressoché incondizionata all’insipienza dei nostri meccanismi sociali e culturali. Se la vita è destituita di senso, lavorare può essere o diventare un tormento più insopportabile del supplizio.
“Gli uomini, in genere, lavorano troppo per poter restare ancora se stessi. Il lavoro è una maledizione che l’uomo ha trasformato in piacere. […] il lavoro duro e assiduo istupidisce, abbruttisce e rende impersonali. Esso fa sì che il centro dell’interesse dell’individuo si sposti da una zona soggettiva verso una scialba oggettività. L’uomo non si interessa più allora del proprio destino, della propria formazione interiore, dell’intensità di certi baluginii interiori, e si dedica solo ai fatti e alle cose […]. L’uomo non si realizza, ma realizza […]. Più si perseguono beni temporali, più il lavoro aumenta, più l’eternità diventa un bene lontano e inaccessibile. Da qui la prospettiva limitata degli uomini dinamici, da qui l’irrimediabile piattezza del loro pensiero e della loro sensibilità. Lavoro come dire periferia. Preferisco un’indolenza che capisce e giustifica tutto a un’attività convulsa e intollerante, […]. C’è molto più senso metafisico in un pigro che in un frenetico”
(Cioran, 1998).
Queste riflessioni di Cioran sul lavoro vanno contestualizzate, considerando che le citazioni si riferiscono a un periodo (quello della stesura del primo libro, nel 1933) di fortissima angoscia e depressione, oltre che di gioventù (Cioran aveva 22 anni). Il Taccuino di Talamanca non rappresenta in modo esaustivo il pensiero di Cioran. È un aperitivo che dovrebbe preparare a letture più dense e più rappresentative dello spirito di questo cupo e vivace (si passi l’ossimoro) pensatore secondo il quale “non c’è nulla che giustifichi il fatto di vivere”.
Ci permettiamo di suggerire ai lettori che intendono avvicinarsi a questo scrittore, di partire senza dubbio da Entretiens, tradotto da noi con il titolo Un apolide metafisico (Conversazioni), uno dei libri più belli in assoluto, che raccoglie interviste realizzate tra il 1978 e il 1994. È una lettura profonda e brillante nello stesso tempo, spesso ricca di humour, che permette di cogliere pienamente non solo il pensiero di Cioran, ma anche il suo carattere. A chi non piacerebbe svegliarsi una mattina con la chiara convinzione hegeliana che ciò che è reale è razionale, e ciò che è razionale è reale? Al di là dei più faraonici e tronfi sistemi filosofici, è meglio dar retta a Cioran: purtroppo la vita umana, per quanto a tratti indiscutibilmente bella, sfugge a qualunque attribuzione di senso metafisico.
- Emil Cioran, Sommario di decomposizione, Adelphi, Milano, 1996.
- Emil Cioran, Sillogismi dell’amarezza, Adelphi, Milano, 1993.
- Emil Cioran, Il funesto demiurgo, Adelphi, Milano, 1997.
- Emil Cioran, Al culmine della disperazione, Adelphi, Milano, 1998.
- Emil Cioran, L’inconveniente di essere nati, Adelphi, Milano, 1999.
- Emil Cioran, Un apolide metafisico (Conversazioni), Adelphi, Milano, 2004.
- Mario Andrea Rigoni, In compagnia di Cioran, Il notes magico, Padova, 2004.