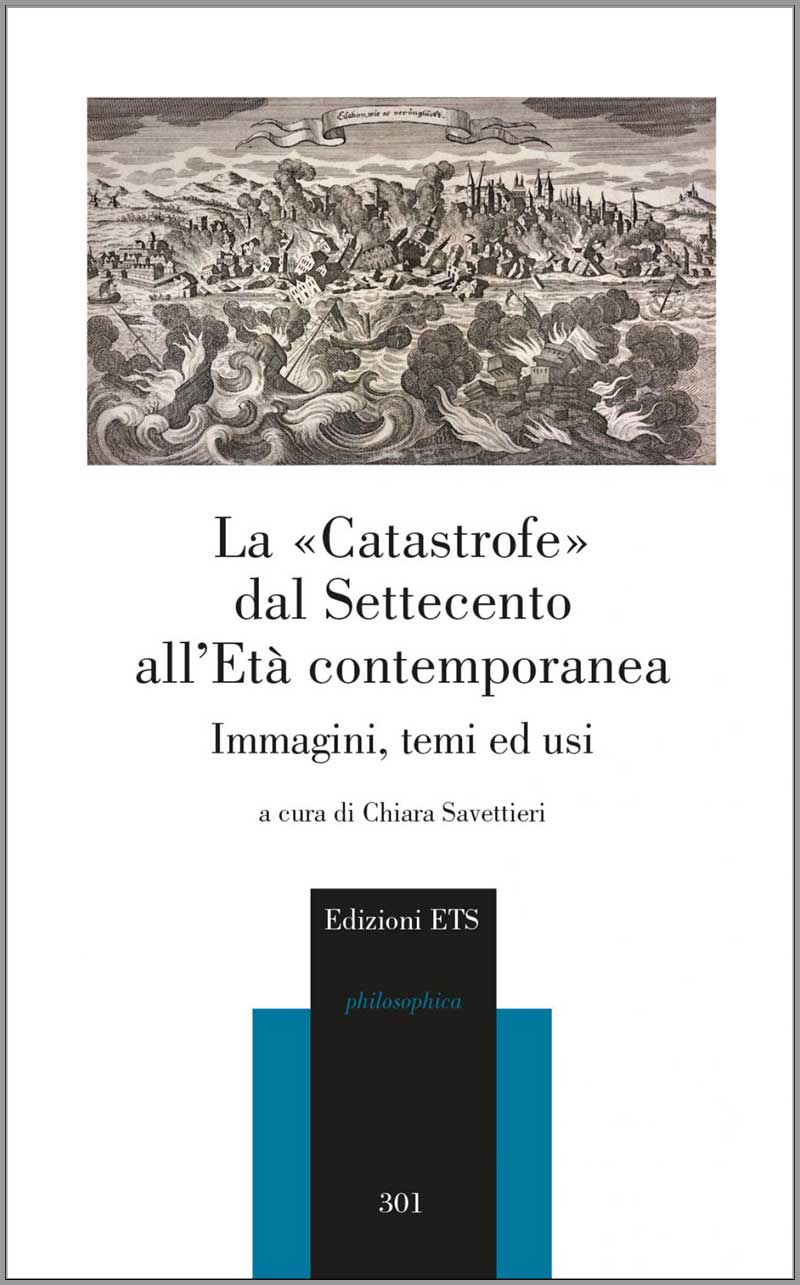Sin dalle sue più lontane origini la nostra specie si è confrontata con il resto dell’esistente, con la percezione della sua essenziale differenza. Da un lato si è trattato di un processo identificativo, per cui si riconosce sé stessi come altro da (altro da una scimmia, altro da una pietra), ma contemporaneamente si è trattato anche di una ricerca, di un’indagine sulle proprie origini, una quest che portava alla luce la volontà di vedere sé stessi non solo come esclusione ma anche come appartenenza, e quindi come parte di (si appartiene al vivente, al creato). Per lungo tempo questo altro da sé di cui però si è parte è stato chiamato Natura. Si tratta perciò di una antropizzazione, di una nostra proiezione, che risponde alle due esigenze sopra espresse, e difatti questa duplice dialettica ha avuto un suo sviluppo storico, si è molto diversificata nel corso del tempo. Nella maggior parte dei casi però, va detto, il non umano è stato visto solo e unicamente come una risorsa da sfruttare, un qualcosa per il cui possesso si poteva combattere e uccidere. Il Cantico delle Creature è una vera rarità nella storia della nostra specie, simbolo di un dono che pochissimi hanno ricevuto, almeno nel mondo antico. La sensibilità empatica e comunicativa, perciò, nella migliore delle ipotesi accadeva in modo unidirezionale, non reciproco. Dal profeta Daniele in poi era la fiera (il leone, il lupo, l’orso, il drago) che, riconoscendo la santità ovvero la superiorità morale dell’umano, si piegava di sua iniziativa all’ordine di sottomissione, al comando che proveniva dall’umano, rinunciando così al suo essere assolutamente altro, al suo essere belva. La storia del rapporto tra l’umano e il non umano, inoltre, non si limita al solo racconto di ciò che ci lega al mondo animale, ovvero ai viventi non umani, ma va allargata alla vicenda che ci contrappone al mondo inanimato, che è altrettanto lunga e conflittuale. A partire dal primo atto di coscienza che ci ha contraddistinto, siamo stati difatti soggiogati e uccisi dall’inanimato. Alluvioni, eruzioni, terremoti, uragani, maremoti, tifoni, valanghe e qualsivoglia altra tipologia di catastrofe, nel corso dei tempi si è abbattuta sulle fragili e inadatte costruzioni che abbiamo eretto, spazzate via da eventi totalmente incontrollabili.

L’umanità vedeva nell’inanimato un Golem fatto di fango, senz’anima e senza coscienza. Se un leone o un drago potevano comunque essere combattuti da un cavaliere, o soggiogati da un santo, nulla di tutto ciò poteva tenere lontane un’eruzione vulcanica o un terremoto. La catastrofe naturale era oltre il controllo umano. Questo non significa che non sia stata oggetto della nostra disperata attenzione, anzi. Non si contano i trattati che sin dal mondo antico hanno tentato di dare spiegazioni a questi fenomeni, o che comunque hanno cercato di osservarli e di rivolgerglisi con un approccio che oggi definiremmo scientifico, o per lo meno para scientifico. Tra l’altro non si tratta di un tema proprio solamente della cultura occidentale, ma ogni altra civiltà umana ha tentato di comprendere eventi che sono stati devastanti e imprevedibili per ogni popolazione del mondo, in modo drammaticamente imparziale. Sarebbe inoltre ingenuo da parte nostra credere che il mondo antico e medioevale si rapportassero alla catastrofe solo in termini mitologici o religiosi. Basti citare solo a titolo esemplificativo, oltre al celeberrimo testo pliniano sul Vesuvio e agli studi dello Stagirita, un Trattato su Terremoti di Seneca e l’omonimo testo di Nicola Longobardo pubblicato in Cina nel 1626. Qui, come in molti altri testi, sono state avanzate ipotesi, ingenue, se si vuole, ma solidamente fondate su principi di causa-effetto, e quindi ben lontane dalla magia o dalla vendetta divina, quale appare per esempio nel racconto biblico del diluvio, che per secoli era stato lo schema imperante per la comprensione della catastrofe naturale, un modello fondato sulla punizione e la vendetta.
Il terremoto di Lisbona del 1755
Nel tratteggiare le linee costitutive di un abbozzo di una storia dell’idea di catastrofe, si incontra però un discrimine, un momento storico che divide nettamente due mondi, e che li separa in un modo che, una volta oltrepassato il guado, non è stato più possibile tornare indietro. Da un lato si abbandona un mondo antico, dove la catastrofe riguardava solo e unicamente la natura (e il nostro rapporto difficile con essa, l’umana hybris), e dall’altro si accede a un mondo moderno, dove nuove ambizioni provano ad analizzare il nostro comportamento di fronte alla calamità, si assiste al debutto di una società in cui ci si può legittimamente interrogare e cercare una risposta circa il nostro poter compiere dei passi per contrastare la catastrofe, per limitarne la portata. Questo evento-cerniera è il terremoto di Lisbona del 1755, un avvenimento che portò a delle nuove prospettive e aprì la strada a tutto ciò che seguì, riguardo al nostro modo di vivere la natura. È il motivo per cui il testo da cui prende inizio questa riflessione si intitola La «catastrofe» dal Settecento all’Età contemporanea collettanea di studi curata da Chiara Savettieri. Ciò che accadde a Lisbona fu una catastrofe quindi in un doppio significato. Prima di tutto in quanto fatto fisico in sé, e in secondo luogo per la sua valenza di frattura ideale, in quanto momento che produsse un salto di paradigma.
“La catastrofe è ciò che costituisce una frattura, uno shock, che interrompersi il normale svolgersi delle azioni della vita: irrompe nelle vite individuali con violenza distruttiva e le devasta. Reca morte, paura, sconvolgimento. La catastrofe è un trauma che frantuma la normalità”
(Savettieri, 2024).
Questo il netto incipit della curatrice, docente di Storia della critica d’Arte e curatrice del volume, oltre che autrice di due dei saggi ivi contenuti. Sin dalle prime parole è quindi evidente il riconoscimento della portata epocale del tema: la catastrofe, nelle sue differenti declinazioni, è il basso continuo che dai primi vagiti dell’Illuminismo ha tracciato la rotta della nostra relazione con l’alterità. In questo volume possiamo dire che sono indicati tre percorsi di indagine, che si intersecano continuamente, ma che mantengono fino in fondo una precisa autonomia.
In prima istanza vi è la visione della catastrofe in quanto elemento fisico e materiale, ovvero un elemento della realtà concreta, che merita di essere oggetto di studio. La seconda analisi riguarda l’immagine della catastrofe, la rappresentazione che ne è stata fatta nel tempo, e infine il terzo elemento riguarda l’immaginario collettivo che la comunità umana genera a fronte della visione che gli si è posta di fronte. Il legame tra la seconda e la terza linea di lettura va identificato nel concetto di spettacolarizzazione, che, a partire appunto dal terremoto di Lisbona, è diventato un elemento costante, con un’incidenza sempre maggiore. Eventi come il terremoto di Messina del 1908, quello del Friuli nel 1976, per giungere fino allo tsunami che nel 2004 devastò le coste dell’Oceano Indiano, sono alcuni esempi di quella trasformazione in immagine pubblica (e di conseguenza in immaginario collettivo) che la catastrofe ha vissuto in questi ultimi secoli. Una metamorfosi divenuta con il tempo un fenomeno senza più alcun limite, foraggiando di conseguenza anche un certo gusto morboso dei media in cerca di costante visibilità. Questo tema in particolare è oggetto del contributo di Andrea Tagliapietra, già curatore del volume antologico Filosofie della Catastrofe (Tagliapietra, 2022). Qui si possono rintracciare i testi unanimemente riconosciuti come centrali per comprendere la disputa filosofica sviluppatasi in quella seconda metà del Settecento. Si tratta di tre saggi, il Poema sul disastro di Lisbona, di Voltaire, la Lettera a Voltaire sul disastro di Lisbona, ovvero la risposta scritta da Jean-Jacques Rousseau, e infine il saggio Sulle cause dei terremoti, scritto da un ancor giovane Immanuel Kant. Tre saggi che definiscono i limiti della riflessione dell’epoca intorno all’inevitabilità della catastrofe e sulle conseguenze etico pratiche che questa comporta. Come correttamente chiosa Savettieri:
“La catastrofe è dunque un prodotto dell’epoca dei lumi”
[…]
“Da un lato Voltaire […] dichiara la fine di ogni possibile ottimismo, la siderale solitudine dell’uomo dinanzi a un male che non può né prevedere né dominare, la rabbia di una umanità che subisce una catastrofe di cui non sarebbe responsabile e che coinvolge innocenti. […] Dall’altro lato Rousseau […] pone l’accento sulla responsabilità umana. […] Voltaire ci ricorda la nostra fragilità, Rousseau la nostra responsabilità […]”
(ibidem).
Credo che anche per il lettore totalmente digiuno nell’indagine filosofica sia evidente la pregnante attualità del dibattito, pensando per esempio alle misure restrittive che si è stati costretti ad adottare di fronte alla pandemia di COVID-19, ma uno sguardo illuminista e razionale dovrebbe essere rivolto anche verso un fenomeno che di naturale non ha nulla, come l’inesistente prevenzione rivolta a eliminare la mortalità propria del mondo del lavoro. La razionalità umana, se è l’unità di misura della nostra azione, dev’essere rivolta a ogni settore, non solo in direzione delle catastrofi di origine naturale. L’angosciosa ricerca di una responsabilità, e le evidenti problematiche presenti sia nella soluzione religiosa quanto in un riconoscimento della potenzialità umana, stabiliscono i confini dello stretto cammino che si ritrova a percorrere il neonato pensiero scientifico, un razionalismo che ancora indossa i pantaloni corti. Se non è pensabile l’esistenza di un Dio malvagio, quando la soluzione agnostica rimane apparentemente la più facilmente praticabile – come sostenne Laplace, secondo un aneddoto controverso, Dio è una ipotesi inutile – allora questo abbandono pone sulle spalle della futura razza umana ogni evento malvagio che ancora doveva accadere, con tutto ciò che questo ha comportato.
Rovine, spettacolo e pubblico
Non bisogna però limitare l’analisi dell’evento-catastrofe alle scienze naturali e nemmeno all’etica. Anche l’estetica ha qui una importante componente interpretativa. Difatti le rovine di Lisbona, così come saranno mostrate al mondo dai diversi artisti che dipinsero quadri e dipinti di ogni cenere, incisero litografie e usarono le più varie forme di rappresentazione in quel contesto, hanno un fratello quasi coetaneo. È proprio in quegli anni che, grazie a Johann Joachim Winckelmann e agli studi di estetica classica a cui lui diede inizio, che le rovine delle città greche e romane diventano oggetto di studio e di apprezzamento. In quel 1755 Winckelmann si trovava a Roma, e negli anni subito seguenti fu a Napoli, dove fu promotore degli scavi di Ercolano. La domanda sulla bocca dell’Europa era facile da interpretare: quali differenze dobbiamo evidenziare tra le rovine di Lisbona e quelle di Pompei? Perché le une sono monumenti e le altre una tragedia? Forse fu la precoce morte dell’esteta tedesco a lasciare la domanda sospesa, ma certamente
“[…] è possibile vedere una relazione tra il gusto per le rovine che caratterizza la cultura visiva settecentesca e l’attrazione che esercitano […] i ruderi di Lisbona. […] Ciò che accomuna i due tipi di rovine è il senso della sparizione e il piacere che si prova nel contemplare i resti di ciò che è stato oggetto di distruzione, nell’antichità come in tempi recenti”
(ibidem).
Difatti, al pari delle reazioni dei filosofi e degli scienziati, il comportamento dell’opinione pubblica è un elemento altrettanto centrale per comprendere quale chiave di volta fu il terremoto di Lisbona. Certamente – e in questo contesto ci riferiamo al testo di Andrea Tagaliapietra – va identificata una differente concezione del tempo, che ci è utile proprio per la definizione del moderno. Il tempo che identifica la catastrofe, ovvero l’evento, induce a una sorta di presentificazione. È il tempo dell’ora, il tempo della scienza. Nel suo contributo, Catastrofe con spettatore. Metamorfosi moderna di un’idea, Tagliapietra scrive:
“Con la modernità l’esperienza diventa attiva partecipazione alla costruzione del sapere, a partire dall’incrocio in cui il punto di vista incontra l’evento, facendo accadere quello che, di conseguenza e d’ora in avanti, diverrà il fenomeno complesso della realtà […]. L’esperienza è legittima non perché mette in contatto con gli oggetti del senso comune o con presunti paradigmi immutabili, ma perché si istituisce, d’ora in avanti, come l’esito dell’interazione con una realtà complessa e paradigmatica, che è frutto e risultato di una attività, anzi di una doppia attività, quella del punto di vista e insieme dell’evento che lo provoca”
(Tagliapietra in Savettieri, 2024).
Questo processo, per cui l’esperienza diretta si collega strettamente con l’immediatezza dell’evento scientifico, fa però emergere un ulteriore problema, che attanaglierà questo tempo, e che troverà la sua espressione nelle Recherches di Georges Cuvier, pubblicate nel 1812. Se tutto in natura procede in modo continuo (natura non facit saltus) come è possibile la catastrofe, ovvero un evento discreto per definizione? Il procedere in modo continuo delle leggi della natura così come erano state intese almeno da Leibniz in poi, di fatto non prevedeva la possibilità che questo moto continuo si trasformasse improvvisamente in un evento discreto, che provocasse una frattura. Eppure, all’accadere del terremoto, filosofi e matematici si scoprono impotenti, incapaci di risolvere l’aporia a cui si trovano di fronte.
“Cuvier constata che nessuna causa lenta può aver provocato effetti istantanei e questo principio, affermato senza neppur tentare di dimostrarlo, svolge nel suo pensiero un ruolo assolutamente capitale […]. Le cause lente sono semplicemente quelle le cui azioni variano in modo continuo, e per questa ragione Cuvier ritiene che non possano provocare catastrofi. […] Cuvier non riesce a concepire cause improvvise, per cui non ne parla affatto, e tutta la sua teoria geologica resta come sospesa nel vuoto”
(Pomian, 1997).
L’empasse in cui si trova la cultura scientifica a cavallo del secolo, tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, viene affrontato prima da Georg W.F. Hegel e di conseguenza da Karl Marx, dove la possibilità del salto, l’ipotesi qualitativa piuttosto che un processo continuo, trova una casa. La lettura dialettica delle scienze naturali in questo momento offre una soluzione filosofica, ma ancora per lungo tempo mancheranno gli strumenti matematico-fisici per integrare questo approccio. Il pensiero della catastrofe, all’interno della riflessione hegelo-marxiana, è difatti oggi slegato da una contestuale interpretazione del processo scientifico, ma ha mantenuto una stretta dimensione di tipo economico sociale, riferendo perciò il pensiero della fine, l’orizzonte del superamento, alla possibilità della fine del capitalismo, piuttosto che alla dimensione tecnologica o naturalista. Sarà invece solo a partire da James Clerk Maxwell, grazie alle innovazioni sviluppate dalla meccanica quantistica, fino a giungere alle moderne teorie della complessità, e soprattutto alla teoria delle catastrofi di Renè Thom, che verranno generati gli strumenti matematici adatti a costruire una scienza dell’evento, una matematica che contempli l’elemento discreto oltre a quello continuo.
Il pessimismo della volontà
Gli oltre duecentocinquant’anni che ci separano dal terremoto di Lisbona, visti con uno sguardo contemporaneo, sembrano essere, almeno apparentemente, all’insegna del mondo sperato da Rousseau. Un mondo in cui vige l’ottimismo della ragione, dove la relazione tra l’uomo e il mondo, così come quella tra l’individuo e i suoi simili, è costruita sulla base dell’ideale di convivenza che ci siamo proposti. Se noi, uomini moderni, siamo responsabili delle nostre azioni, ciò vuol dire che, dedicando sufficiente tempo e risorse, la decisione ricade solo su di noi: nulla può impedirci di essere noi stessi. Salvo appunto noi stessi, perché questo tempo trascorso ha visto anche sempre scorrere sotterraneo il destino ineluttabile di dolore e sofferenza che allora fu tratteggiato da Voltaire, così come lo sviluppo della scienza e della tecnica, pur aumentando la durata della vita media in modo assolutamente impensabile anche solo cento anni or sono, d’altro canto non è riuscito a fermare la produzione di armi sempre più potenti e a generare le due guerre mondiali, vertici (per ora) del tentativo di autodistruzione proprio della nostra specie. L’approccio del volume qui in oggetto è in modo appassionato e sentito, vicino allo spirito illuminista, pur cogliendo ovviamente le problematiche che nel corso del tempo si sono presentate. L’architettura stessa del volume, in una sorta di reciproca interdipendenza dei diversi interventi, è finalizzata a sostenere questa visione, questo spirito costruttivo e collaborativo attraverso il quale si possono affrontare anche le moderne catastrofi, pur con mille esitazioni e difficoltà.
Savettieri lega esplicitamente i diversi interventi tra loro mostrandone un volto unitario e compiendo così una precisa scelta. Non è scontato. Certamente il confronto tra queste due visioni del mondo, raffronto che ha avuto inizio in quella triste mattina del giorno di Ognissanti di duecento sessantanove anni or sono sulle sponde dell’Atlantico, è, come si è visto, costitutivo della modernità stessa, e noi viviamo ancora la sua onda lunga, incapaci di tagliare i ponti con un passato a cui probabilmente siamo ancora troppo legati. È la traccia del volume che Savettieri così ben riassume:
“ […] la catastrofe rivela inevitabilmente la nostra fragilità; se non cadiamo nella trappola della spettacolarizzazione fine a se stessa (Tagliapietra), se conoscendo la storia delle rappresentazioni catastrofiche (Savettieri, Rio, Serena) ne comprendiamo anche i meccanismi (Capocci) e le ricadute sociali, se sappiamo comunicarla in modo adeguato (Neri), se la guardiamo in faccia (Benedetti), cercando di conoscere sempre meglio le cause (Doglioni), adottando misure di prevenzione e atteggiamenti positivi, favorendo anche modalità di ricostruzione capaci mettere in sicurezza una area urbana conciliando il contesto storico e la modernità (Angelillo), allora la catastrofe, pur continuando a farci paura, quanto meno ci avrà reso più consapevoli, più solidali, e anche un po’ meno vulnerabili”
(Savettieri).
- Aristotele, Metereologia, Bompiani, Milano, 2003.
- Immanuel Kant, Sulle cause dei terremoti in occasione della sciagura che ha colpito le terre occidentali d’Europa verso la fine dell’anno trascorso, in Andrea Tagliapietra (a cura di), Sulla catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del disastro, Bruno Mondadori, Milano 2004.
- Nicola Longobardo, Trattato sui terremoti, a cura di Silvia Toro, Edizione Dehoniane, Bologna, 2017.
- Plinio il giovane, 50 lettere, a cura di Giulio vannini, Mondadori, Milano, 2019.
- Krzysztof Pomian, Catastrofi, in Autori vari, Enciclopedia vol. 2 Ateo- Ciclo, Einaudi, Torino, 1997.
- Seneca Trattato sui terremoti, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1965.
- Andrea Tagliapietra (a cura di), Filosofie della Catastrofe, Raffaello Cortina, Milano, 2022.
- Voltaire, Il terremoto di Lisbona, include Jean-Jacques Rousseau, Lettera a Voltaire sul disastro di Lisbona Mattioli 1885, Fidenza (PR) 2017.