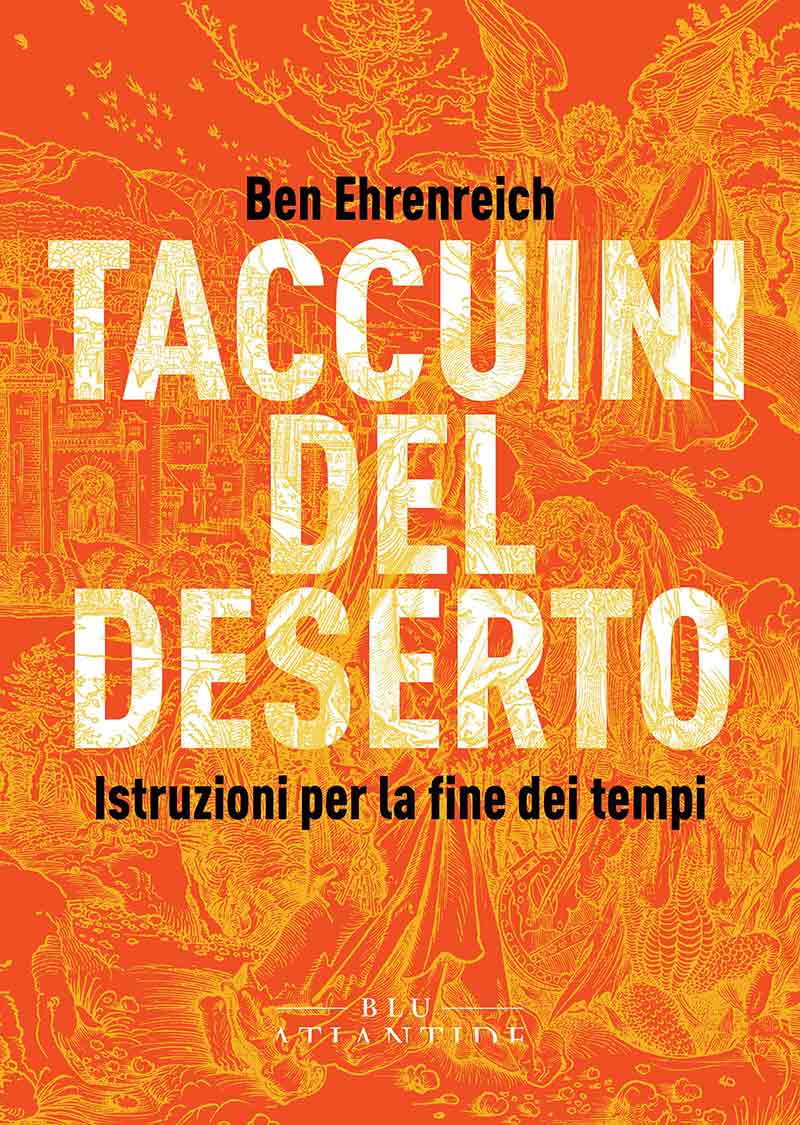In quale posto della Terra possiamo scorgere l’immagine della fine del mondo? Il giornalista e scrittore irlandese Mark O’Connell, in Appunti da un’Apocalisse, l’ha cercata nei bunker dei survivalisti in South Dakota, nelle distese della Nuova Zelanda, dove i miliardari della Silicon Valley comprano tenute in cui rifugiarsi se tutto andasse male, in un ritiro nelle Highlands scozzesi, e nella Zona, l’area contaminata dalla centrale atomica di Černobyl’, in Ucraina. Il suo omologo americano Ben Ehrenreich, in Taccuini dal deserto. Istruzioni per la fine dei tempi, non si è spinto più in là della sua patria, gli Stati Uniti, ma ha trovato un’immagine dell’apocalisse nel Joshua Tree National Park, l’arido e inospitale deserto della California meridionale, a poche miglia dalle grandi capitali dell’innovazione tecnologica ma in grado di mettere in soggezione l’essere umano attraverso l’impietoso confronto con una natura ostile.
Ciò che sorprende di questi due libri molto simili è, per noi lettori di questi giorni, il confronto con la realtà. Scritti prima della pandemia, ci fanno amaramente sorridere del fatto che non abbiamo avuto bisogno di fare viaggi ai confini della Terra per incontrare la fine del mondo, perché questa è venuta a scomodarci fin dentro le nostre case mentre eravamo impegnati a guardare altrove.
L’innominabile attuale
Agli inizi del 2020 girava su Internet un meme che rappresentava un calendario: a gennaio c’era il rischio di una terza guerra mondiale, dovuta alle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran dopo l’assassinio del potente generale iraniano Qassem Solemani da parte degli americani; a febbraio la recrudescenza dei grandi incendi che stavano devastando l’Australia; a marzo l’arrivo del Covid in Europa. Ci si immaginava, per i mesi successivi, ulteriori calamità che andavano dalla caduta di un meteorite all’invasione degli alieni. Invece ci è rimasto solo il Covid, che ha reso tutte le altre preoccupazioni relative rispetto a una pandemia che finora non solo ha ucciso almeno tre milioni e mezzo di persone (le stime parlano di oltre dieci milioni), ma ha costretto il mondo a cambiare in modo radicale il proprio modello di vita come mai è accaduto nemmeno durante le due guerre mondiali.

In questo scenario, impensabile fino a un anno e mezzo fa, è interessante ragionare intorno alla letteratura dell’apocalisse, che ha goduto di un vero e proprio boom sia nella narrativa che nella saggistica negli anni scorsi. È indubbio che a promuoverla siano state soprattutto le preoccupazioni, mai sopite, per gli scenari del cambiamento climatico, l’innesco che ha spinto sia Mark O’Connell che Ben Ehrenreich a scrivere i loro libri; ma più a fondo è stata alimentata anche da un’inquietudine più sottile, difficile da definire, che ha a che fare con quell’“innominabile attuale” di cui ha scritto Roberto Calasso presentando inquietanti parallelismi tra la condizione dell’Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale e la nostra (cfr. Calasso, 2017), o con quegli “stati di angoscia più nebulosi, incentrati su microcosmi stremati di carne e comunanza” che secondo la storica Joanna Bourke hanno caratterizzato la civiltà a partire dalla fine del Novecento (Bourke, 2007).
Nelle sue sedute di psicoterapia, per esempio, O’Connell cerca di spiegare il suo disagio apocalittico che lo ha spinto, dopo la nascita dei due figli, a interessarsi alla possibile fine del mondo. La psicologa gli chiede se non abbia mai considerato un punto di vista diverso, e gli cita gli studi di Steven Pinker, il convinto sostenitore che il mondo stia semplicemente migliorando e tutto andrà per il meglio (cfr. Pinker 2013, 2018). O’Connell liquida (giustamente, aggiungiamo) il chiacchiericcio tecno-ottimista di Pinker, perché sa che dietro si nasconde una retorica che reifica le disuguaglianze del presente, in cui miliardari come Peter Thiel possono comprare un’enorme tenuta con tanto di panic room in Nuova Zelanda come “piano B” all’apocalisse, o cercare come Elon Musk di prepararsi ad andare su Marte, mentre il resto dell’umanità resta a confrontarsi con disastri climatici, guerre e pandemie. Però non prende in considerazione nemmeno il consiglio della psicanalista di staccarsi per un po’ dal flusso di notizie.
Il rinoceronte nella stanza
Perché, in effetti, sia O’Connell che Ehrenreich sono perfetti esempi di ansia da sovraesposizione mediatica. Nei loro libri troviamo continui riferimenti a notizie e informazioni da cui sono letteralmente bombardati; essendo giornalisti, sono portati a dare a queste notizie un valore superiore a quello che un semplice fruitore conferirebbe loro e – quel che è peggio – a collegarle tra loro in una narrazione uniforme nonostante il fatto che queste notizie abbiano in realtà poco in comune tra loro.

Ehrenreich si dimostra fin da subito particolarmente angosciato da Trump. Il libro è scritto come un diario durante la presidenza trumpiana, e l’incipit lo pone al centro, sebbene in modo ellittico: “Nella terza settimana di novembre, un anno e sei giorni dopo l’elezione del Rhino, andai a fare una passeggiata con due amici”. “Rhino”, ossia rinoceronte, è il nomignolo con cui l’autore chiama Trump per tutto il libro, chiaro meccanismo di evitamento per ciò che rappresenta la sorgente di tutte le sue ansie. Nel corso del libro, Rhino sembra continuamente essere sull’orlo di scatenare la terza guerra mondiale; col senno di poi, le preoccupazioni di Ehrenreich ci sembrano decisamente eccessive, un po’ come quelle di Philip Dick quando paventava l’avvento della dittatura fascista sotto Nixon. È però interessante comprendere il modo in cui i due autori, ciascuno per conto proprio, mettono insieme tutte le notizie in una narrazione orientata a un fine, o meglio a una fine, come se stessimo guardando un film di cui conosciamo già il finale, che va da sé non sarà un happy ending.
Scrive per esempio Ehrenreich:
“Negli anni Ottanta c’erano i russi e Reagan. Ora il pericolo arriva da molteplici fronti, tutti insieme. C’è il Rhino e la Corea del Nord, il Rhino e l’Iran. Ci sono guerre in Iraq, Siria e Yemen nelle quali quasi tutte le maggiori potenze militari del pianeta uccidono per delega perché, al momento, non sono pronte a fronteggiare direttamente la cosa. C’è l’improbabile storia d’amore tra Netanyahu e i sauditi, insofferenti a questo schifo di delega. Ci sono i fascisti nei parlamenti europei, nelle strade e alla Casa Bianca. C’è l’infrastruttura ampia e letale della guerra al terrorismo di Bush e Obama che aspetta solo la più piccola scusa per saltare su un altro campo di battaglia. E in cima a tutto, sotto a tutto, su ogni singola superficie e su ogni singolo lato c’è quella estinzione di massa già avviata, lo scioglimento dei ghiacciai, lo stallo della corrente a getto, la siccità e gli incendi, le prossime tempeste”
(Ehrenreich, 2021).
Anche per O’Connell tutte queste vicende sono strettamente intrecciate:
“Viviamo in un’epoca d’incombenze, cose incalzanti e imminenti. Una serie di fenomeni sconcertanti incombe sulla nostra cultura – una catastrofe climatica incombente, certo, ma anche un populismo di destra incombente e lo spettro incombente della disoccupazione provocata dalla diffusione dell’automazione in diversi settori economici”
(O’Connell, 2021).
Fermate il mondo, voglio scendere
Si tratta di punti di vista politicamente e culturalmente situati, che in quanto tali si scontrano con la percezione di una parte forse preponderante del mondo. Se oggi si fa poco o nulla per contrastare il populismo di destra, la disoccupazione tecnologica, le diseguaglianze economiche, la macchina bellica che produce costantemente conflitti a bassa intensità, e ovviamente il cambiamento climatico, è perché esiste una fetta molto ampia del mondo secondo cui questi non sono affatto problemi, men che meno scateneranno il collasso della civiltà. Questa fetta dell’umanità ha trovato in Trump, ma anche in intellettuali come Pinker o in innovatori come Thiel dei portabandiera in grado di contrastare la narrazione apocalittica che, al di là di O’Connell o Ehrenreich, è stata divulgata da altri autori dichiaratamente di sinistra come Slavoj Žižek (2011) o Mark Fisher (2018).

Queste considerazioni ci permettono di comprendere meglio le preoccupazioni che si situano dietro i due libri. È la sensazione di impotenza di chi vede un baratro davanti a sé ma sa che alla guida c’è qualcuno che non se n’è accorto, come il conducente un po’ troppo distratto dell’autobus che porta Mark O’Connell e la sua comitiva verso Černobyl’ sfrecciando sulle autostrade ucraine. È una questione di there is no alternative, il celebre motto del neoliberismo secondo cui questo sarebbe l’unico modo per l’umanità di andare avanti e dobbiamo accettarlo quali che siano gli effetti collaterali; ma è anche una questione di mania del controllo. Un tema ben noto ai sociologi della post-modernità, strettamente connesso al disagio esistenziale che favorisce una lettura da “fine dei tempi”. Lo sa bene O’Connell, che scrive:
“Il futuro spaventa non perché non sappiamo cosa accadrà, e quanto sarà terribile, ma perché sappiamo così poco, è così poco controllabile. La sensibilità apocalittica, lo stile apocalittico, seduce appunto perché offre una via di uscita da questa situazione: ci fa superare con un balzo il baratro epistemologico del futuro, dritti verso una destinazione finale, la fine di ogni cosa. Dalle tenebre del tempo emerge la sagoma distinta di una visione, una rivelazione che infine permetterà di vedere dove sta andando tutto questo casino. Tutto – la storia, la politica, la lotta, la vita – si avvicina alla fine, il sollievo è palpabile”
(O’Connell, 2021).
Mentre studia le dinamiche dei preppers, i survivalisti americani che si preparano a un qualsiasi scenario catastrofico facendo scorte di cibo, acquistando armi e munizioni, scavando o acquistando bunker, O’Connell avverte questa sorta di sollievo che il collasso della civiltà ispira a molte persone: l’idea che nessuno ci sopravviva e continui a spassarsela mentre siamo diventati cenere o cibo per i vermi. Abbiamo potuto toccare in parte per mano questo pensiero quando, all’inizio della pandemia, la crisi del sistema socio-economico era stata salutata non solo con sollievo, ma persino con entusiasmo da alcuni: niente più scuola, niente più ufficio, tantissimo tempo per guardare serie tv, leggere o giocare ai videogame. Ma la pandemia ci ha insegnato anche quanto questo desiderio di apocalisse duri poco: poche settimane, qualche mese al massimo, poi la comprensione di vivere in un mondo in cui il nostro spazio di manovra si è ristretto alle mura di casa spazza via ogni facile entusiasmo e fa emergere il desiderio di un ritorno alla normalità.

La fine del mondo non è un pranzo di gala, eppure è stata molto (troppo) spesso invocata. Dai survivalisti più di chiunque altro, ma non si può dire di meno per le sette cristiane che credono nel rapture, il “rapimento” dei giusti, che Dio metterà in salvo per risparmiarli dalle tribolazioni, continuamente impegnati a scrutare i segni dei tempi sperando di essere portati in salvo mentre tutti gli altri periranno in un turbine di calamità e atrocità (i survivalisti dei bunker sono solo una loro variante “mondana” di questa Schadensfreude, il godere delle disgrazie altrui); oppure per molti ideologi di sinistra. Per loro come per molti altri, il collasso della civiltà rappresenta il perfetto scenario per un’inversione dei ruoli, come accadeva per i flagellanti del Medioevo: la loro ansia apocalittica derivava dalla speranza evangelica secondo cui “gli ultimi saranno i primi” e, all’approssimarsi del Giorno del Giudizio, potenze e autorità saranno distrutte e ai miserabili sarà concesso il posto a capotavola nel banchetto divino (cfr. Cohn, 2014).
Da un lato, la passione degli intellettuali di sinistra per il collasso (che ha addirittura un nome: collassologia; cfr. Servigne, Stevens e Chapelle, 2020) si spiega con la convinzione che solo uno shock traumatico romperà la gabbia del there is no alternative e consentirà di dare un nuovo assetto all’ordine mondiale; dall’altro, la fascinazione della cultura di destra per la fine del mondo consiste nella possibilità di ripristinare un ordine patriarcale considerato l’unico giusto, distrutto dalle follie dei liberal, i primi che saranno spazzati via, come scrive O’Connell
“Il collasso della civiltà prevede un ritorno a forme di mascolinità che nella nostra cultura ormai servono a poco, a un mondo dove un uomo che sa costruire un cesso dal nulla – oppure proteggere moglie e figli dagli intrusi usando un arco, oppure eviscerare un cervo – farà subito parte della nuova élite. L’Apocalisse, in qualsiasi forma, causerà morte e miseria per la maggior parte degli esseri umani, ma chi è preparato tornerà ai principi originari, a un mondo dove gli uomini sono uomini. Specialmente se sono bianchi”
(O’Connell, 2021).
Il (nuovo) tramonto dell’Occidente
In Taccuini del deserto Ehrenreich porta molto più in profondità queste riflessioni. Il libro è (anche) un omaggio alla cancel culture, che propone una serie di radicali messe in discussione dell’ordine sociale bianco, maschile ed europeo, prendendo di mira la filosofia di Hegel, il concetto giudaico-cristiano di progresso e la sua variante positivista, la fede nei princìpi illuministici di uguaglianza, democrazia e fraternità e nell’idea che la culla della civiltà risieda nelle polis greche, recuperando al contrario la saggezza dei nativi americani, il Popol Vuh e le teorie (per la verità oggi scientificamente screditate, ma politicamente tornate di moda) di Marija Gimbutas sull’esistenza, nell’Europa preistorica, di una civiltà matriarcale poi distrutta dai conquistatori provenienti dall’Asia. È una reazione, certamente, all’America incarnata da Trump, dal suprematismo bianco, dagli incel e dall’alt-right, ma è anche una contro-narrazione che nasconde, al suo interno, una fascinazione per la fine dei tempi.

È l’idea, cioè, che dopo aver portato all’estinzione intere civiltà, a partire da quelle native americane, all’Occidente tocchi per la legge del contrappasso lo stesso, analogo destino, di ormai imminente realizzazione. Fare spazio alle culture afro-americane, islamiche, orientali, alle donne, alle comunità LGBT, in generale agli oppressi di questo ordinamento solo apparentemente liberale, permetterà al mondo bianco euro-americano di espiare le sue colpe e farsi da parte, aspettando pazientemente ma volontariamente la sua estinzione. Una versione “di sinistra”, potremmo dire, del declinismo che, a destra, è stato rappresentato agli inizi del Novecento dalle tesi di Oswald Spengler sul Tramonto dell’Occidente (cfr. Spengler, 2008).
All’interno di questa riflessione, Ben Ehrenereich pone una domanda decisamente avvincente: se il mondo in cui viviamo è dominato dalla concezione del tempo lineare e progressivo della cultura giudaico-cristiana, con la sua ossessione messianica per la fine dei tempi, è possibile immaginare una concezione diversa del tempo? E in tal caso, verrebbe meno anche tutta la nostra fascinazione per l’apocalisse?
“Se il tempo si sta veramente esaurendo, se ci troviamo alla fine dei tempi, forse vale la pena fermarsi e chiederci: cos’è il tempo? Come lo concepiamo? Perché lo viviamo così? È questo modo di esperirlo e pensarlo che ci ha spinto fin qua, su questo precipizio, e che ha contribuito a farci sentire questo particolare cattivo odore?”
(Ehrenreich, 2021).
E d’altronde, se si vuole davvero perseguire un altro futuro, “il sogno di un mondo nuovo”, le ricorrenze cicliche non aiutano, anzi, non fanno altro che ingabbiare la realtà nella prigione dell’eterno ritorno. Anche le catastrofi sono eterne. Una possibilità sta nel recuperare le concezioni del tempo delle culture che la civiltà occidentale ha distrutto, come quelle dei nativi americani. Per esempio, scrive Ehrenreich, i Mohave dividevano il tempo in due parti: il tempo degli dèi e il tempo degli uomini. Anche qui la “figura più importante era una linea”, ma “non quella freccia unidirezionale che ci spinge senza sosta nel futuro, ma uno squarcio orizzontale che segna un confine tra noi e gli dèi”. Questo confine è attraversabile solo da un lato, nel senso che il tempo degli dèi influenza quello degli uomini, ma non viceversa. A meno di non usare la dimensione del sogno, un modo per annullare il tempo.
“Ovviamente, il tempo non veniva distrutto. Assumeva solo una forma diversa, e seguiva regole diverse. Non era né lineare né totalmente sequenziale. Il passato epico va avanti, separato dal presente solo attraverso le nostre palpebre, le categorie che la mente cosciente impone al mondo, e la nostra capacità di sognare”
(Ehrenreich, 2021).
Può essere l’inizio di una soluzione? Chi lo sa. Questi non sono libri che forniscono risposte, ma che pongono domande. Straordinariamente inattuali se letti come testi per immaginare l’apocalisse, perché la pandemia ci ha permesso di toccarla con mano molto più solidamente di quanto O’Connell e Ehrenreich riescano a fare; ma di grandissima utilità per permetterci di riprendere il filo del discorso interrotto con la pandemia, ossia: come evitare un’altra fine del mondo? Come superare questa “sensibilità apocalittica”, come la chiama O’Connell, che continua a sospingerci come sonnambuli lungo una china distruttiva, come una sorta di profezia che si auto-avvera? Probabilmente a partire dalla messa in discussione di ciò che abbiamo finora dato per scontato, a partire dal modo in cui pensiamo il tempo e dal modo in cui il tempo struttura i nostri pensieri. Forse, allora, nel sogno, potremo trovare una soglia da varcare per raggiungere un altro mondo.
- Joanna Bourke, Paura. Una storia culturale, Laterza, Bari-Roma, 2007.
- Roberto Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano, 2017.
- Norman Cohn, I fanatici dell’apocalisse, PGreco, Roma, 2014.
- Mark Fisher, Realismo capitalista, Nero, Roma, 2018.
- Steven Pinker, Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l’epoca più pacifica della storia, Mondadori, Milano, 2013.
- Steven Pinker, Illuminismo adesso. In difesa della ragione, della scienza, dell’umanesimo e del progresso, Mondadori, Milano, 2018.
- Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Un’altra fine del mondo è possibile, Treccani, Roma, 2020.
- Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano, 2008.
- Slavoj Žižek, Vivere alla fine dei tempi, Ponte alle Grazie, Firenze, 2011.