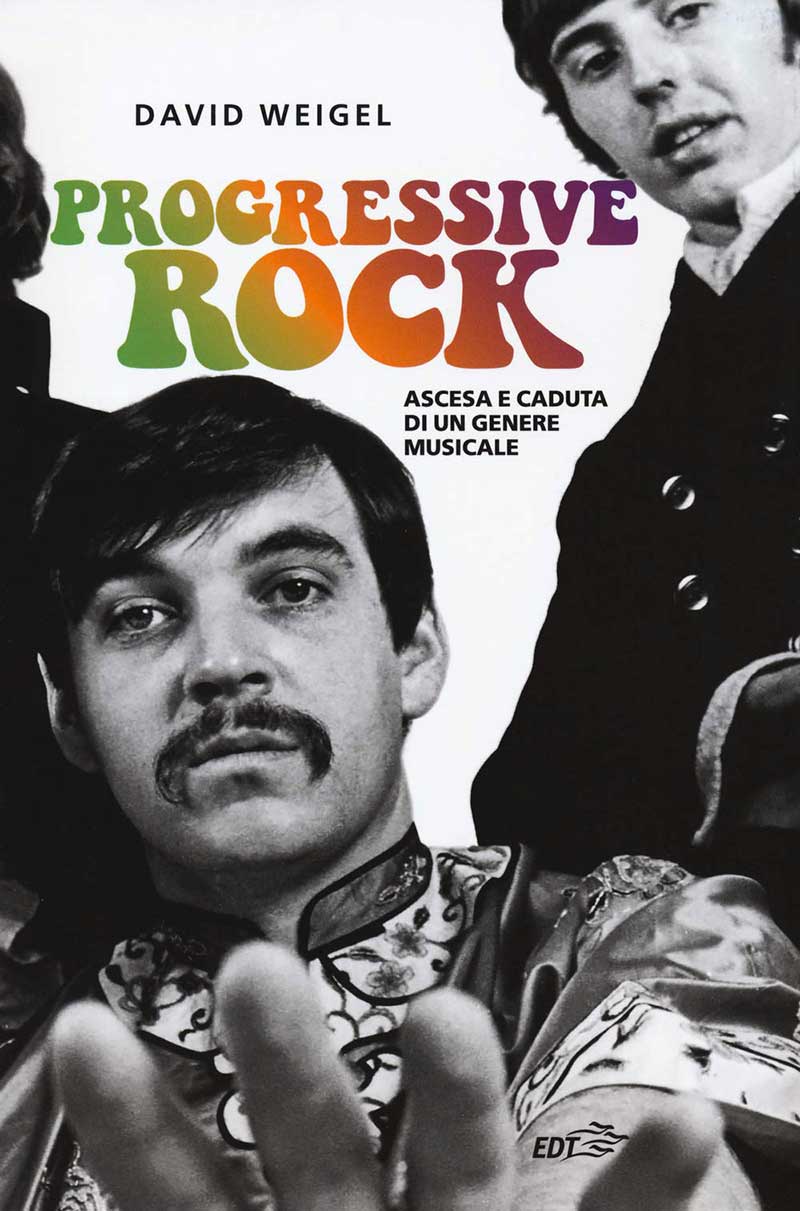Cruise to the Edge non è, come molti potrebbero pensare, il titolo dell’ultimo album degli Yes, tardivo seguito del celebre Close to the Edge. Tutt’altro. È il nome di una crociera che ospita, oltre al blasonato gruppo britannico, numerosi altri protagonisti del “genere di musica pop più vituperato del dopoguerra”, come recita il Rock Snob’s Dictionary pubblicato su Vanity Fair. I passeggeri, ben riconoscibili dalle magliette e dai gadget a tema, stanno per godersi “quattro notti e cinque giorni di paradiso in compagnia delle divinità in terra del progressive rock”. Così si apre l’ultima fatica del giornalista David Weigel, in un clima che ricorda da vicino il cinismo e il malcelato imbarazzo di David Foster Wallace nell’esilarante Una cosa divertente che non farò mai più. Ben lontano da un atteggiamento agiografico o celebrativo, Weigel mostra senza remore quanto possa essere controversa un’operazione simile: “Al momento in cui scrivo il dirigibile è stato rattoppato e si trova sottoposto a revisione, ma ancora non ha ottenuto il permesso di riprendere il volo”.
Chi si aspettasse di ripercorrere, per l’ennesima volta, le gesta gloriose dei tanti Peter Gabriel, Keith Emerson, Robert Fripp, rischierebbe seriamente di rimanere deluso dalla lettura di questo libro. Soprattutto in un periodo in cui si rincorrono reunion, cofanetti, cinquantenari e tour commemorativi. “Puristi” o “entusiasti” del genere storcerebbero sicuramente il naso: Weigel è un giornalista che si occupa di politica, che ne sa lui del prog? In effetti, uno sguardo critico e disincantato, da “esterno” ancorché fan, giova a restituire un’immagine più completa e realistica del fenomeno. E a vantaggio del progressive stesso:
“Il libro intende essere anche una perorazione a favore del progressive rock, visto come una grandiosa svolta che è all’origine di molta della musica che si ascolta oggi”.
Weigel non è certo un negazionista: è lui stesso a sottolineare la “popolarità favolosa” e il “favore della critica” di cui il prog ha goduto per anni. Ma è anche molto preciso, forse in modo un po’ impietoso, nello scandire il racconto con numerose citazioni tratte dalla stampa specializzata, mostrando come questa spesso abbia contribuito in maniera determinante a celebrare i fasti e, nel giro di poche settimane, a stigmatizzare i medesimi artisti. Certo furono proprio questi ultimi, con le proprie scelte azzardate, a mostrare la contraddizione insita nel fenomeno: poteva un approccio colto, teatrale e virtuosistico sposare i dogmi della popular music nell’era della sua più pervasiva commercializzazione? Probabilmente sì, ma non molto a lungo, e le classifiche di vendita sono lì a dimostrarlo, nel bene e nel male. In più, quello stesso approccio non aveva smentito il carattere intrinsecamente viscerale e anti-intellettualistico del pop-rock? Forse sì, e Weigel cita proprio quel The Rotters’ Club di Jonathan Coe, i cui protagonisti incarnano con malinconica efficacia la fine dell’illusione progressiva e l’inarrestabile avanzata iconoclasta del punk.
Certo la storia del prog non si sarebbe fermata al 1976 o giù di lì. Quasi tutti i grandi gruppi dell’epoca d’oro avrebbero trovato la propria strada per sopravvivere nei decenni successivi, con esiti molto diversi: la frettolosa ritirata dei King Crimson, che già nel 1974 “cessarono di esistere”, e le loro diverse reincarnazioni; la lenta ma inesorabile deriva pop dei Genesis; il finale in sordina dei Gentle Giant con Civilian, nel 1980; i numerosi cambi di formazione e direzione degli Yes. Particolare risalto viene dato alla tormentata figura di Keith Emerson: alla sua triste uscita di scena Weigel dedica il commosso epilogo del suo racconto.
Anche il taglio storiografico scelto dall’autore è piuttosto originale, per esempio ricollegando gruppi come Moody Blues, Procol Harum e The Nice alla psichedelia di fine anni Sessanta, e dando spazio a figure solitamente considerate poco prog, come Kevin Ayers e Mike Oldfield, o a gruppi come Kansas e Rush. D’altra parte non vengono trattati alcuni filoni importanti, come il Rock in Opposition o, in epoche più recenti, il revival scandinavo degli anni Novanta, mentre ampio spazio viene concesso al new prog dei Marillion e ad altri fenomeni più originali emersi fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui il metal prog dei Dream Theater o l’ascesa di Steven Wilson con i Porcupine Tree e poi come solista. Del tutto ignorato è il prog nostrano, una lacuna colmata da un lungo saggio di Jacopo Tomatis inserito nell’edizione italiana del volume.
Che fine ha fatto quindi il prog? E, se continua a sopravvivere, sotto quale forma ci riesce? È proprio Tomatis a mostrare come il prog, e in particolare quello più di nicchia, sia tornato in auge negli ultimi anni grazie alla “retromania” che, secondo Simon Reynolds, dominerebbe il consumo culturale di oggi, non solo nonostante, ma anche grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia:
“In un mondo di infinite possibilità, in cui scoprire e creare musica non è mai stato così semplice, torniamo sempre a mettere sul piatto quel solito disco del Banco, e a volere che il nostro sintetizzatore software suoni come un Moog”.
Ma la longevità del prog, o meglio la passione che anima ancora i suoi fan più attempati, ha radici più profonde:
“Quella a cavallo dei primi anni Settanta è stata un’epoca breve ma di rara creatività […] perché alla popular music si apriva l’inedita possibilità di essere cultura, di funzionare come l’arte […] Quella che prima era solo musica di sottofondo, da ballare o da sentire facendo altro, si prestava ora a generare saggi analitici e riflessioni filosofiche, si prendeva la scena ed esigeva di essere ascoltata e raccontata come opera”.
Ma soprattutto, quella musica, quel sogno, “non nasceva con l’idea di durare lo spazio di una stagione, il tempo di un passaggio in classifica: era lì per rimanere”. Ciò che i fan irriducibili tendono comprensibilmente a non fare è chiedersi come mai quel sogno sia svanito così presto, e come mai le tante nuove leve del prog, in tutte le sue derivazioni, non riescano a riportare il genere alla gloria dei bei tempi andati: “La popolarità del prog metal, dei Marillion e delle altre band disposte a identificarsi con l’etichetta ‘prog’ non bastò a salvare la situazione”, né i grandi nomi del passato sono più riusciti di fatto a conquistare nuovi fan.
L’altra faccia della retromania, dopotutto, è la nostalgia, che costringe le vecchie glorie nelle gabbie della ripetizione di sé. Sul prog aleggia da sempre un’aura di leggendario rétro, che lo rende più simile a una lingua morta che a un genere vitale e realmente proiettato nel futuro: “La Cruise to the Edge non è un sarcofago, pur avendo le sue tombe”. La “pervasiva assurdità delle circostanze” di cui parla Weigel a proposito di queste crociere è un’iperbole della quotidiana fruizione del prog a oltre cinquant’anni dalla sua nascita. Il prog è morto, lunga vita al prog, quindi: il sogno è svanito, l’illusione non altrettanto.