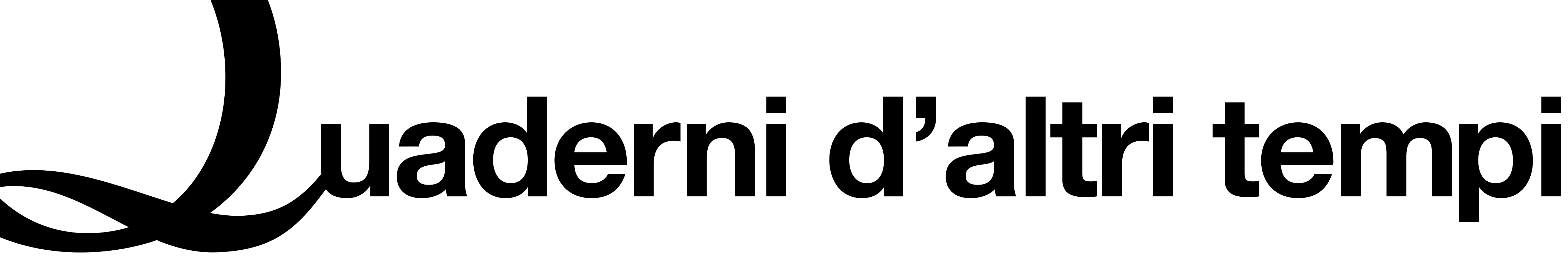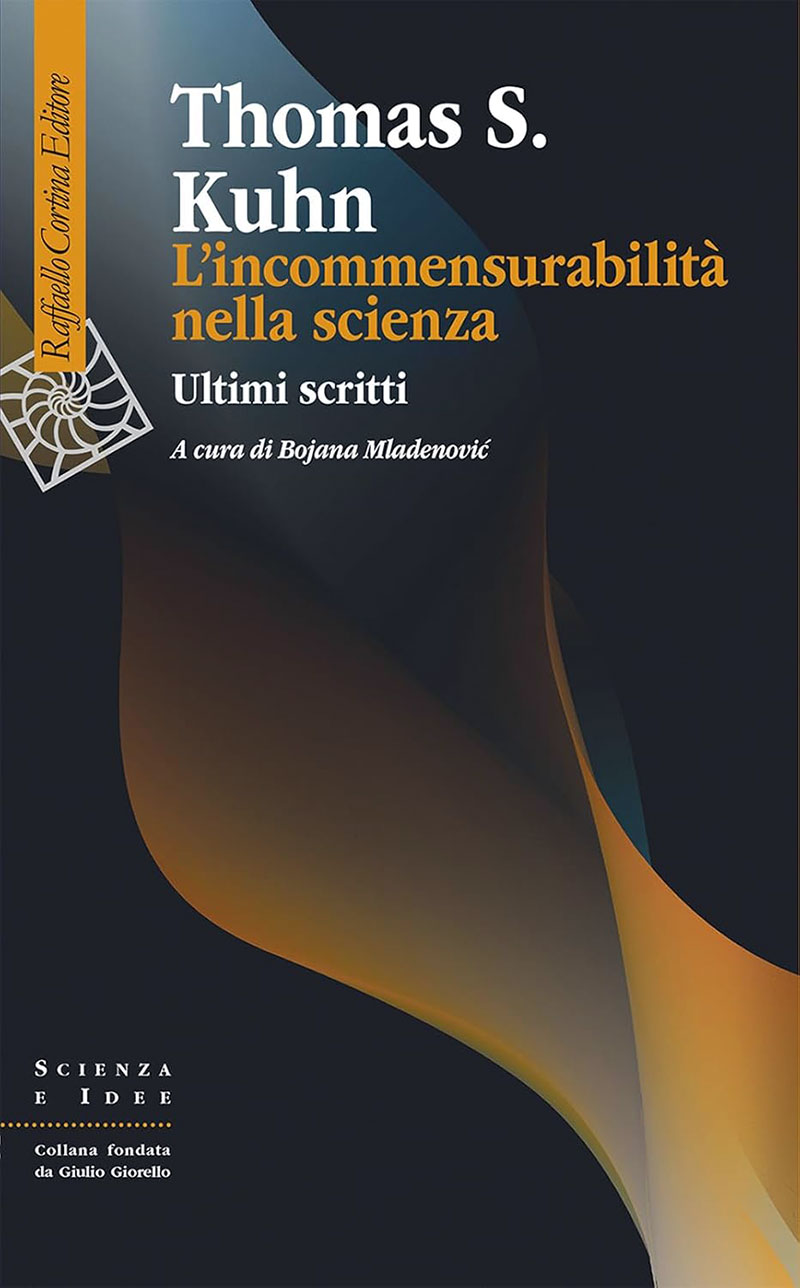Per quanto possa apparire un’ovvietà, vale sempre la pena ricordare che in nessun’epoca della storia gli uomini si sono sentiti “antichi”. Poteva accadere – ed è accaduto quasi sempre finché la moderna ideologia delle “magnifiche sorti e progressive” non si è affermata – che ci si percepisse in un’epoca di decadenza; ma ogni generazione si considera moderna e attribuisce alle precedenti errori e concezioni superate, anche se questo può farci sorridere se pensiamo a coloro che credevano nella fissità della Terra o nell’etere luminifero. Di quest’ovvietà si rese conto Thomas S. Kuhn nell’estate del 1947 quando, giovane dottorando venticinquenne, meditando sul testo della Fisica di Aristotele, all’improvviso ebbe una illuminazione:
“Improvvisamente i frammenti nella mia testa si sono riordinati in modo nuovo e ognuno è andato al proprio posto. Sono rimasto a bocca aperta, perché tutto d’un tratto Aristotele mi sembrò davvero un ottimo fisico, ma di un tipo che non avevo mai sognato fosse possibile”
(Kuhn, 2024).
Era accaduto che Kuhn, chiedendosi come fosse possibile per il più grande filosofo dell’età antica credere nell’inesistenza del vuoto e in generale a tutta una serie di concezioni scientifiche del tutto errate rispetto alle nostre conoscenza moderne, comprese che la fisica di Aristotele si reggeva su concetti che avevano per lui significati del tutto diversi da quelli che hanno oggi e che, all’interno di quella tassonomia, la fisica aristotelica era non solo perfettamente sensata, ma corretta. Quell’epifania aveva proiettato per un attimo Kuhn nel mondo di Aristotele, vale a dire che gli era riuscito di vedere il mondo esattamente nello stesso modo in cui lo vedeva lo Stagirita, e non piuttosto – come sempre avviene – con gli occhi di noi “moderni” di oggi. Nell’opus magnum di Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), questa idea è trattata nel capitolo decimo, intitolato Le rivoluzioni come mutamenti nella concezione del mondo. Il cambio di paradigma che rappresenta, nell’opera di Kuhn, il processo con cui si verifica una rivoluzione scientifica, è un vero e proprio cambiamento di mondo:
“È quasi come se la comunità degli specialisti fosse stata improvvisamente trasportata su un altro pianeta dove gli oggetti familiari fossero visti sotto una luce differente e venissero accostati a oggetti insoliti”
(Kuhn, 2009).
Così era accaduto al giovane studioso nel momento in cui aveva compreso la scienza dal punto di vista di Aristotele. Se oggi quella scienza ci appare non solo sbagliata, ma incomprensibile, è solo perché tante rivoluzioni scientifiche, tanti cambi di paradigma sono avvenuti nel frattempo, e a ogni rivoluzione “gli scienziati reagiscono a un mondo differente” (Kuhn, 2009). Tuttavia, questa intuizione non era stata ulteriormente approfondita nella Struttura, per via della sua inevitabile brevità, data dall’essere un’opera di sintesi che doveva rientrare in un più vasto progetto editoriale di tipo enciclopedico sui fondamenti della scienza. Né Kuhn aveva ancora le idee chiare su come si verificasse davvero quella trasformazione del mondo prodotta dai cambi di paradigma. Si limitò a introdurre, nel penultimo capitolo della Struttura (La soluzione delle rivoluzioni), il concetto di incommensurabilità, contestualmente ripreso da Paul Feyerabend per descrivere l’impossibilità di confrontare due teorie scientifiche diverse a causa della diversità di linguaggio. Per Kuhn, tuttavia, questa incommensurabilità aveva quasi un carattere ontologico: “In una maniera che sono incapace di spiegare ulteriormente, i sostenitori di paradigmi opposti praticano i loro affari in mondi differenti” (Kuhn, 2009). Veniva così rinviata ad altra sede una spiegazione più dettagliata di cosa davvero intendesse il filosofo americano.
La pluralità dei mondi
Nel corso degli anni Ottanta, e saltuariamente fino alla morte nel 1996, Thomas Kuhn provò a fornire finalmente quella spiegazione che non era riuscito a dare ne La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Ma la sua ultima opera, provvisoriamente intitolata La pluralità dei mondi. Una teoria evoluzionistica dello sviluppo scientifico, rimase incompiuta. Ora finalmente ce ne vengono restituite le bozze e il piano complessivo grazie alla certosina ricostruzione di Bojana Mladenović, filosofa della scienza di origine serba in forze alla Williams University, già autrice di un volume dedicato all’eredità di Kuhn (Kuhn’s Legacy: Epistemology, Metaphilosophy, and Pragmatism, 2017). Il volume curato da Mladenović e tradotto in italiano da Raffaello Cortina sotto la curatela di Stefano Gattei porta come titolo L’incommensurabilità della scienza, che mette un po’ in ombra il concetto su cui evidentemente Kuhn intendeva maggiormente insistere, quello della “pluralità dei mondi” prodotta dai cambi di paradigma, per favorire piuttosto quel termine fortunato, mutuato dalla matematica, che Kuhn aveva introdotto nella Struttura, ossia appunto “incommensurabilità”. Perché quando una teoria scientifica nuova sostituisce una precedente, tra di loro diventano incommensurabili? Davvero per noi seguaci della teoria eliocentrica l’universo tolemaico è destinato a restarci precluso da ogni reale comprensione? E che dire di teorie che sono vere a un livello maggiore ma che non falsificano quelle valide a un livello inferiore, come la relatività generale di Einstein e la gravitazione universale di Newton? Per tutta la sua carriera Kuhn fu inseguito da queste domande, formulate in particolare dai suoi critici, e tentò di spiegare cosa intendesse dire, inseguendo una nuova teoria con cui spiegare quello che era divenuto noto come il “problema del cambiamento di mondo”.

C’era, naturalmente, il Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus: “I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” (Wittgenstein, 2022). Ma non era quello che Kuhn intendeva davvero: non è un problema semantico, ma ontologico. Convinzione, questa, che lo esponeva inesorabilmente alle accuse dei relativisti: Kuhn non credeva davvero che la scienza potesse conseguire una verità oggettiva sulla natura della realtà? La sua era una concezione strettamente storicista, secondo cui la verità è sempre soggettiva rispetto alle diverse concezioni del mondo valide per una determinata epoca storica? Per rispondere a queste domande, torniamo ad Aristotele. Ciò che aveva portato il giovane Kuhn alla sua epifania era stata la comprensione che lo Stagirita intendeva per moto qualcosa di completamente diverso da ciò che intendiamo noi oggi. Non soltanto, cioè, un cambiamento di posizione, ma un cambiamento qualitativo, come “la maturazione di una ghianda in quercia, il passaggio dalla malattia alla salute o la trasformazione da solido a liquido”. Il cambiamento di posizione è dunque per gli aristotelici solo una delle numerose sottocategorie del moto. Ma per Galileo e Newton “moto” si riferisce solo ed esclusivamente al cambiamento di posizione di un corpo, dato dalla velocità e dalla direzione che assume in ogni istante; un cambiamento di stato non è quindi un “moto”. È una differenza sostanziale. Nella fisica aristotelica, il moto di un sasso che cade non è uno stato ma un cambiamento di stato, che lo porta a ritornare alla sua proprietà originaria, quella di occupare un luogo specifico che gli è connaturale (la terra). Da ciò deriva che lo spazio vuoto non esiste, perché ogni corpo occupa uno spazio specifico e se un corpo non c’è allora non c’è nemmeno lo spazio. All’interno del mondo di Aristotele, il vuoto è effettivamente una contraddizione in termini. Affinché il vuoto possa essere concepibile, è stato necessario un cambiamento lessicale radicale, che ha reso possibile l’emergere della rivoluzione scientifica di Copernico, Galilei e Newton:
“Respingere la concezione aristotelica del vuoto equivarrebbe a mettere a repentaglio tanto la teoria del moto naturale di Aristotele quanto l’antica astronomia geocentrica. Non c’è modo di «correggerla» senza dover ricostruire gran parte del resto della sua fisica. Non è un caso che, a questo proposito, l’universo infinito di Copernico, la meccanica di Galileo e di Newton e i primi vuoti terrestri siano emersi tutti insieme”
(Kuhn, 2024).
Gli altri due esempi su cui si concentra Kuhn, quello della pila di Alessandro Volta e del problema del corpo nero di Max Planck alle origini della scoperta dei quanti, si focalizzano anch’essi sulle differenze tra il significato originale dei termini e quelli che utilizziamo oggi. La pila di Volta ci appare incongrua perché Volta aveva in testa un concetto di pila diverso da quello che abbiamo oggi, così come Planck diede al concetto di quanto un significato diverso, che Kuhn – autore di una importante monografia sul problema del corpo nero (Alle origini della fisica contemporanea. La teoria del corpo nero e la discontinuità quantica del 1978) – spiega dimostrando come Planck si fosse fatto ispirare dalla statistica di Boltzmann per la cinetica dei gas. Ricostruire il significato dei termini significa infatti ricostruire gli stretti collegamenti tra teorie scientifiche che vigono in una determinata epoca. Una teoria non nasce dal nulla, ma origina dalle teorie precedenti: un’idea, questa, che spinse Kuhn a cercare una metafora evoluzionistica da applicare alla storia della scienza. Tale metafora è quella della tassonomia, per cui i concetti scientifici hanno una loro gerarchia ed è possibile ricostruirne in retrospettiva l’evoluzione. La distinzione che Kuhn fa tra “tipi tassonomici” e “tipi singoli” è piuttosto concettosa, probabilmente perché il capitolo in cui doveva entrare più nel dettaglio su questi elementi non fu mai scritto; ma è probabilmente anche ridondante, perché l’idea è in realtà molto semplice. Concetti come “pianeta”, “stella”, “satellite”, “galassia” sono stati usati in modi diversi a seconda delle epoche: dire che per i Greci il Sole è un pianeta non vuol dire affermare che i Greci avevano una concezione sbagliata dell’universo, perché “pianeta” aveva un significato diverso per loro e nella loro tassonomia celeste “il Sole è un pianeta” ha perfettamente senso. Quando si arriverà a dire che il Sole è una stella, il concetto di “stella” è ormai completamente cambiato rispetto a quello usato dai Greci, così come il concetto di “pianeta” (che ora può essere applicato anche alla Terra). Dunque, le tassonomie lessicali mutano nel corso del tempo e sono questi mutamenti a consentire le rivoluzioni scientifiche, perché affinché un cambio di paradigma sia possibile occorre mutare il linguaggio che descrivere le cose.
Incommensurabilità
“Il lavoro dello storico richiede l’apprendimento della lingua in cui è stato espresso il sapere del passato. Ciò comporta la padronanza di un lessico strutturato incommensurabile con quello dello storico”
(Kuhn, 2024).
Cosa vuol dire? Che, se da un lato è compito dello storico ricostruire l’originario significato di un concetto nell’accezione che esso possedeva in una data epoca, nella misura in cui tale accezione è oggi distante dalla nostra i due concetti restano incommensurabili. Possiamo ricostruire l’attrezzatura mentale da cui derivarono le teorie scientifiche del passato, ma non possiamo usarla, e ciò in quanto entrambi i lessici sono veri in mondi diversi. In questo sta l’incommensurabilità e anche, al tempo stesso, la soluzione escogitata da Kuhn per uscire dal relativismo: due verità diverse non possono coesistere nello stesso tempo, dunque il loro statuto di verità è tale all’interno di mondi che non possono interagire, esattamente come nel caso del mondo della fisica contemporanea e del mondo della fisica aristotelica. Questo significa, si domanda Kuhn, dire che nel XVII secolo esistevano davvero le streghe o che il flogisto esisteva davvero nella chimica del XVIII secolo? In parte sì, anche se il filosofo americano ha difficoltà a spingere fino a tali estremi il suo relativismo. Avrebbe forse trovato più solidi appigli se avesse conosciuto le teorie dell’antropologo italiano Ernesto De Martino, che a questi problemi aveva dedicato i suoi studi da una prospettiva chiaramente diversa da quella khuniana. Poiché infatti De Martino muoveva da una prospettiva originariamente storicistica – non, precisiamo, lo storicismo nel senso di Karl Popper (l’idea di una storia che procede inesorabilmente verso il progresso, ciò che Kuhn chiama storia Whig), ma lo storicismo nel senso di Benedetto Croce, ossia una lettura della realtà che ha senso solo da una prospettiva storica – la sua conclusione, nei celebri studi sul magismo, era che “per la nostra civiltà la magia sia impostura, illusione, puro negativo, qualcosa di cui ci si spoglia nel processo della ragione; non lo era però per le civiltà primitive” (Gronda, 2016). La stessa dizione demartiniana di “mondo magico” anticipa quella di Kuhn: la magia è possibile solo in quel mondo, che è incommensurabile al nostro. Lì la magia ha uno statuto di verità simile a quello che nel nostro mondo ha la scienza; i due termini non sono antitetici come nel nostro mondo e lì la credenza magica può produrre effetti tangibili. In questo senso il concetto demartiano e quello kuhniano di mondo sono perfettamente coincidenti:
“Se e in che misura i poteri magici sono reali è quistione che non può essere decisa indipendentemente dal senso della realtà che qui fa predicato del giudizio. Ma questo senso può essere appreso solo per entro la individuazione del dramma storico del mondo magico”
(De Martino, 2022).“Il mondo descritto con il lessico che ne risultava (quello precedente o quello successivo) era concreto. Si potevano sviluppare teorie sui tipi naturali che conteneva, ed era possibile, in base all’osservazione e all’esperimento, assegnare valori di verità agli enunciati che derivavano da tali teorie”
(Kuhn, 2024).
L’opera incompiuta di Kuhn lascia molte questioni aperte. L’ultimo capitolo, un tentativo di sviluppare una teoria evolutiva della scienza sulla base di quella biologica, risente evidentemente di una stesura provvisoria, ed è chiaro che se l’autore non riuscì a portare a termine l’opera prima della sua morte (nonostante contasse di pubblicarla alla fine degli Ottanta) è anche perché il suo pensiero non era ancora giunto a una formulazione precisa. Può essere che Kuhn abbia imboccato un vicolo cieco, facendosi prendere la mano dalle metafore evolutive; ma a chi rileggesse oggi La struttura delle rivoluzioni scientifiche dopo aver preso in mano questi ultimi scritti, tutto apparirebbe più chiaro: concetti come l’incommensurabilità delle teorie e i paradigmi intesi “come costellazioni di credenze condivise da un gruppo” (nella definizione del Poscritto del 1969) assumono ora un chiaro significato e ci permettono di apprezzare maggiormente un pensiero al quale tornare a rivolgerci per meglio comprendere il significato dell’impresa scientifica oltre gli angusti limiti dello scientismo.
- Ernesto De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, Torino, 2022.
- Roberto Gronda, Civiltà e mondo magico: Croce e De Martino, in Michele Ciliberto (a cura di), Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa, Treccani, Roma, 2016.
- Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 2009.
- Bojana Mladenović, Kuhn’s Legacy: Epistemology, Metaphilosophy, and Pragmatism, Columbia University Press, New York, 2017
- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Feltrinelli, Milano, 2022.