Da Re del Brivido a “Re dei racconti” il passo è breve o, per certi versi, inesistente: nulla esclude infatti che le due anime universalmente riconosciute di Stephen King, l’una legata al genere horror e l’altra alla sua fortuna nella forma-racconto, convivano e coincidano nel tempo, anziché attraversarlo in forma di mutazione. Ma è pur vero, a ulteriore riprova di tale intreccio, che i due baluardi del King autore siano nati e cresciuti di pari passo, dagli albori della sua formazione in avanti, fino a questa ultima raccolta, Il bazar dei brutti sogni, che tra storie già edite, rivisitate, o inedite, aggiorna sullo stato delle cose e ne conferma la regalità, per così dire, accentuandone l’unità tematica, come vedremo più avanti.
Infatti, prima ancora di conoscere la fama mondiale con la storia lunga di Carrie (1974), gli esordi (ufficiosi) dell’allora giovanissima promessa del Maine sono segnati da un discreto numero di storie brevi, destinate a pubblicazioni scolastiche e di settore; aspetto, quest’ultimo, che chiarisce sin dall’inizio la natura del rapporto di Stephen Edwin King con i grandi modelli e maestri di genere, dai libri di Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft e Richard Matheson alle distopie cinematografiche di mezzo secolo firmate da Robert Wise e Don Siegel.
Certo, che la pratica del mestiere di scrivere cominci con la stesura di racconti non è evento né eccezionale né degno di nota, ma guardando alla carriera di King assume tutta una serie di significati esterni alla dimensione dell’ordinario. Nel 1978, anno della pubblicazione di A volte ritornano, sua prima e più rinomata raccolta ufficiale di racconti, le storie kinghiane hanno già conosciuto una seconda e altrettanto redditizia forma di diffusione: quella al cinema.
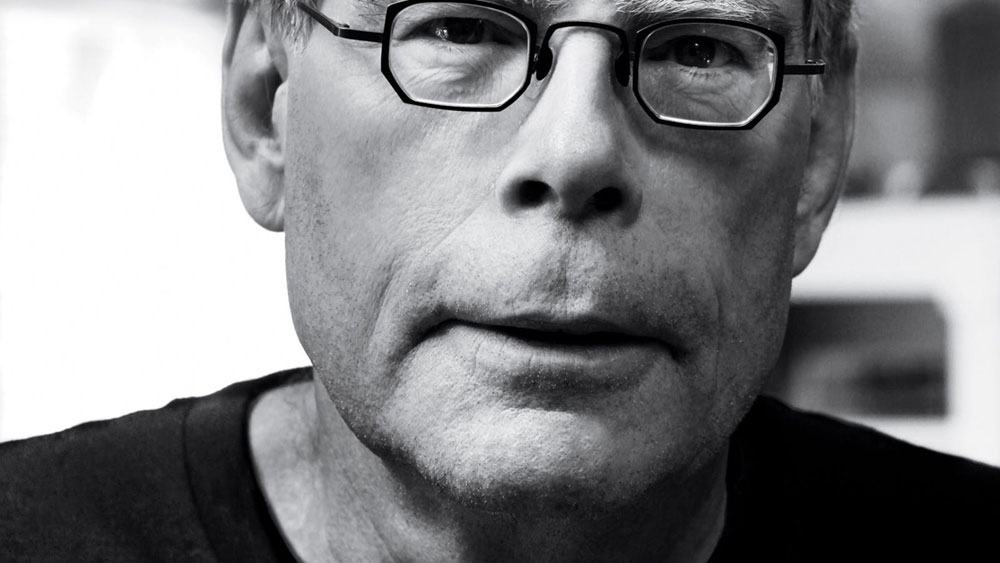
È il 1976 quando la Settima Arte inizia a trarre linfa vitale dalle inquietanti avventure dello “zio Stevie”, andando a ipostatizzarne l’opera nel bacino delle produzioni orrorifiche con il classico di Brian De Palma Carrie – Lo sguardo di Satana. Che non sarà il primo né l’ultimo romanzo kinghiano a ricevere l’onore e, talvolta, l’onere di un adattamento cinematografico, prova cui peraltro verranno sottoposti, con il trascorrere degli anni, diversi racconti, dalle short novel alle short story vere e proprie. In tale vastissimo panorama di riscritture, le quali vanno a costituire un punto di svolta definitivo “non solo all’interno del genere horror, ma anche nei rapporti tra lettore e romanzo, tra letteratura e cinema, tra cultura alta e cultura di massa” (Ascione, 1996), quello delle storie brevi va fin da subito a configurarsi come terreno fecondo di suggestioni e sperimentazioni narrative, potenziamento ennesimo della fervida creatività a monte della scrittura kinghiana nel suo complesso.
A questo punto però diventa necessario precisare almeno alcune fra le ragioni che motivano il successo della produzione letteraria di Stephen King fra gli ingranaggi dell’industria culturale; ragioni che per la maggior parte riconducono al punto d’incontro fra genere e forma-racconto menzionato in apertura. Perché, per quanto abbia a lungo finito col rappresentare una gabbia concettuale, capace di svilire in partenza la qualità dei testi kinghiani, è la Paura messa su carta fra quelle pagine a costituire uno dei principali motivi alla base della loro risonanza storica. È l’Orrore, in qualità di dimensione considerata erroneamente delimitabile, genere la cui particolarità è stata spesso confusa con una specificità chiusa e fine a sé stessa, la veste più congeniale a King, che ne rende la produzione riconoscibile e, al tempo stesso, aperta ai più diversi tipi di approfondimento e contaminazione.
Un legame che King medesimo ci tiene a sottolineare quando passa in esame, fra le pagine del suo indispensabile saggio Danse Macabre (1981), i testi fondanti le origini letterarie dei “miti dell’oscurità”, dal Frankenstein di Mary Shelley (1818) al Dracula di Bram Stoker (1897). Lì è dove prendono forma e si sviluppano le prime, folgoranti raffigurazioni di quella scomposizione dell’Io che ha caratterizzato la transizione dell’individuo verso l’età moderna, ancor prima di complicarsi e frammentarsi ulteriormente con l’avvento della cultura post-umanistica, di cui King, assieme ad altri, si è fatto appunto portavoce, o cantastorie.
L’universo narrativo creato dal prolifico autore statunitense trabocca di quei mostri dell’immaginario collettivo che, per dirla ancora con Ciro Ascione, ne forniscono la rappresentazione spettacolare, una traduzione metaforica e simbolica che sfocia in esemplare ritualizzazione; utilizza, cioè, un linguaggio che trasforma tali figure in forme di critica emotiva ai mutamenti paradigmatici della società, avvenuti o futuri: l’atavica (e lovecraftiana) paura dell’ignoto, ad esempio, attraversata a propria volta dal sempre latente terrore della morte, ancor più se cruenta, che varia tanto le sue fonti quanto, conseguentemente, i suoi modi di apparire. Sta di fatto che, migrando dal romanzo al racconto, la messa in scena di questi orrori non si differenzia soltanto per una mera questione di lunghezza ma, anche e soprattutto, in virtù di una diversa struttura semantica. Se infatti, da un lato, nella forma lunga il settaggio dello scenario implica l’introduzione e l’elaborazione di un certo numero di temi, con la specificazione di altrettanti riferimenti concreti e più o meno dettagliati (o almeno coerenti rispetto al mondo immaginario ivi creato), dall’altro la forma breve sorge e si struttura poggiando su di un apparato simbolico molto più ridotto ma, per contro, con l’obbligo di un impatto evocativo assai più forte.
Avvincere (e terrorizzare) in poco tempo appare il diktat primario di racconti come Il compressore, I figli del grano, Quitters Inc., Il cornicione e La donna nella stanza, tutti contenuti in A volte ritornano e tutti riadattati per il grande schermo durante gli anni successivi all’esordio della raccolta, rispettivamente da Tobe Hooper nel 1995, Fritz Kiersch nel 1984, Lewis Teague nel 1985 e Frank Darabont nel 1983.
Diverse le modalità di trasposizione, dal classico lungometraggio di genere scelto da Hooper e Kiersch al film a episodi di Teague, gli adattamenti di Quitters Inc. e Il cornicione fanno entrambi parte della pellicola intitolata L’occhio del gatto, passando per il corto girato da un giovanissimo Darabont in apertura della sua carriera da regista; mentre persiste, invece, il leitmotiv della morte, a volte violentemente connessa alla sfera del sovrannaturale, altre amaramente quotidiana; in ambedue i casi, inesorabile generatrice di vuoti.
Una cifra, questa, che si ripete fino a percorrere l’intera produzione kinghiana di short stories, da Scheletri (1985) a Il bazar dei brutti sogni (2016), la raccolta più recente: le brevi allegorie mortifere tratteggiate da King sono concrete, vere e proprie metafore plastiche che uniscono con sapienza il dato storico alla proiezione immaginifica, senza rinunciare a descrivere i segreti del primo come della seconda. L’orrore in senso kinghiano, pur prendendo le mosse dal modello di un maestro quale Lovecraft, si distanzia dalla sua intrinseca tendenza all’astrazione per mostrarsi, rivelarsi, farsi guardare; uno svelamento che non di rado, come ammette l’autore stesso in Danse Macabre, comporta il rischio di far notare “la lampo sulla schiena del mostro” (King, 2006), portando al fallimento la costruzione della metafora narrativa di genere. Ma che in compenso, e proprio grazie allo stesso concetto di limite insito al suo interno, sa tornare a favore del sistema di codici e adozioni caratteristico della Settima Arte.
È là che la natura di circuito potenzialmente spalancato, proprio perché, si diceva, evocativo, del racconto può essere sfruttata al meglio, assumendo una fra le sue molteplici forme; è là che il finale aperto e deprimente de La nebbia, tra le storie più note di Scheletri, ottiene la possibilità di rinnovarsi variando la collocazione formale dei propri simboli; è là che la storia può essere raccontata ancora, e in maniera diversa, con due ore di girato, come nel di The Mist di Frank Darabont, film del 2007, o una serie di episodi, il progetto televisivo dell’emittente Spike, per la regia di Christian Torpe, in uscita nel 2017. E d’altronde “King’s story is open-ended enough to allow for all kinds of changes and extensions”, come evidenziato giustamente da Jacob Hall su Slash Film (cfr. Hall, 2016); fattore che, nel caso specifico de La nebbia, è di fatto andato a vantaggio dell’adattamento cinematografico, meritevole di aver modificato in maniera sostanziale la conclusione del racconto lasciandone comunque intatto l’intrinseco e avvolgente senso di disperazione.
Nulla vieta, dunque, che la versione per il piccolo schermo fondi sul medesimo principio, pervenendo allo stesso campo semantico del testo d’origine per altre vie formali e strutturali, nel pieno rispetto di ciò che, da un certo punto di vista, costituisce il quid capace di rendere speciale qualsiasi operazione di rilettura non letterale, di interpretazione in senso stretto; e le inedite capacità contenute nel mezzo post-seriale non possono che allargare gli orizzonti di una prospettiva simile. Ma qui si fa appunto riferimento a quanto attende di compiersi, dopo il fallimento parziale, dovuto anche all’immaturità dei tempi, del connubio tra forma-racconto e serialità televisiva nell’ambito specifico dell’horror kinghiano.
Suggestioni, evocazioni, citazioni, che sul piccolo schermo non sono riuscite a in/trattenere il pubblico (cfr. Fichera, 2015) allo stesso modo dei grandi topos estrapolati dai romanzi di genere (vedi per esempio la neo-vittoriana e recentissima Penny Dreadful); come dimostra, fra le tante, l’impermanenza dei fantasmi kinghiani di Incubi e deliri (2006), obliata mini-serie tv legata alla raccolta omonima del 1993 e a una parte delle storie apparse in A volte ritornano e Tutto è fatidico (2002), con King nelle vesti di sceneggiatore.
Emerge così la sostanziale difficoltà che le rispettive forme di episodio e racconto riscontrano nel momento in cui si muovono l’una verso l’altra: forse perché, anziché afferrare il “tema che si dispiega in una narrazione” (Sarchi, 2015), in quest’ambito la pratica di adattamento dei testi muove dall’ostinazione a considerare l’unità-racconto, la sua trama, il suo sviluppo narrativo, come perfettamente sovrapponibile all’unità, o singolo frammento, costituente la forma-episodio della serie. E se ciò risulta efficace nel passaggio dal racconto al cortometraggio, al punto da incentivare la produzione, accanto ai più diffusi lungometraggi, di film brevi tratti dalle storie kinghiane di affine lunghezza, non è invece capace di adeguarsi ai tempi e al linguaggio della serialità televisiva odierna, al suo esigere variazioni ripetute e potenzialmente infinite.
Per giunta, in un’epoca caratterizzata dal profondo intreccio, quando non dallo sconfinamento di campo vero e proprio, fra cinema e televisione, l’idea di un adattamento per la tv limitato e limitante si prospetta come inutile, deleteria, perfino impensabile. Ed ecco ancora Stephen King, con la versione televisiva di 11.22.63 (2016) ispirata al suo romanzo omonimo del 2011, esempio lampante di come l’evoluzione della serialità al suo stato attuale vada a costituire l’ideale punto d’incontro ove attuare la traduzione e la rimediazione di con/testi diversi.
C’è da dire, riguardo al caso particolare delle produzioni audiovisive legate al Re ma anche rispetto a una scala più ampia, che il merito di un certo tipo di testo seriale, e la sua conseguente fortuna, sta nella sua capacità di individuare, scegliere ed elaborare un tema: il bandolo della matassa narrativa, quello che Sarchi (cfr. ibidem) osserva nel suo dispiegamento fra le righe della storia e che invita, per l’appunto, ad afferrare onde ricostituire la continuità fra i respiri e le pause della narrazione.
E di temi il multiverso kinghiano è tutt’altro che privo: poc’anzi si parlava, non a caso, di motivi ricorrenti, cerchi concentrici nati dal fulcro, vitale e letale insieme, del terrore, della paura, della morte. Discorsi che attraversano anche la produzione di racconti dello scrittore americano, oltre che il corpus dei suoi romanzi; e che tuttavia, con il trascorrere del tempo, hanno fatto in modo di riunire e condensare sotto la stessa copertina gruppi di short stories solo all’apparenza eterogenei. Quello che infatti è ancora latente e implicito in raccolte come Tutto è fatidico e Al crepuscolo (2008) diventa più che evidente nelle quattro storie di Notte buia, niente stelle (2010), cucite insieme dal fil rouge tematico della femminilità: un punto di vista molto caro a King, come provano le precedenti esplorazioni romanzesche di Dolores Claiborne (1993) e Rose Madder (1995), e che in questa sede l’essenzialità della forma breve contribuisce a potenziare ulteriormente, offrendo un imperdibile assist all’industria cinematografica. Ben due versioni filmiche, entrambe destinate alla distribuzione video on demand e ispirate alle rispettive vicende di Un bel matrimonio e Maxicamionista, vengono realizzate a ridosso del 2014 da Peter Askin, con A Good Marriage, e Jeff Beal, con Big Driver. Ma il processo di condensazione tematica delle opere brevi di Stephen King non si arresta, bensì prende una nuova e più sottile consistenza fra gli incubi di Il bazar dei brutti sogni, raccolta di “brutti sogni brevi” nonché ultima antologia in ordine cronologico di edizione.
Nel contesto di una nuova fase creativa, cui già preludevano romanzi come Insomnia (1995), Joyland (2013) e Revival (2014), oltre che alcune short stories di Al crepuscolo, specialmente Le cose che hanno lasciato indietro, ispirata al fantasma storico dell’11 Settembre, l’ufficiale ritorno dell’autore alla forma breve segna il compimento e insieme l’inaugurazione di un percorso di maturazione dove il tema esplicito della Morte e quello meno evidente del Tempo finiscono col mescolarsi senza soluzione di continuità. La sensazione di un King “radicalmente cambiato, tanto dallo scorrere del proprio tempo interiore quanto dall’avvicendarsi dei mutamenti storici sullo sfondo, che si rapporta sempre più alla dimensione del ricordo e al sentimento della nostalgia”, domina Il bazar dei brutti sogni dalla prima all’ultima delle sue pagine. E quell’idea di passaggio, di fine, che dà nome all’intersezione fra i concetti e gli effetti di Morte e di Tempo, si sveste del tutto, al netto di una manciata di storie, degli artigli, delle squame, del rosso del sangue e degli sguardi demoniaci: resta sovrannaturale, ma ostenta anche tutto la propria intrinseca normalità.
Come una risata al centro della notte, l’incubo in venti riprese de Il bazar dei brutti sogni sta a ricordare l’essenziale onnipresenza dell’Oltre, sia nella sua accezione di travalicamento dei confini dell’umano che in quella di distorsione dell’umano stesso, di devianza. E più di tutto è il morire a essere protagonista assoluto, diventando titolo, concetto asciutto, con il ritratto di un condannato contenuto in Una morte; diventando scrittura, nei sardonici La duna e Io seppellisco i vivi, quest’ultimo vincitore del prestigioso Edgar Award 2016, grazie alla storia di un ragazzo che inventa necrologi capaci di uccidere; diventando se stesso, cioè l’Altrove, negli amari Aldilà e Mister Yummy; e ritornando reale attraverso la messa in scena del lato tragico della sorte, con l’incidente al centro di Premium Harmony, o delle tremende e possibili visioni future dipinte in Tuono estivo, la conclusione post-apocalittica della raccolta.
A una prima lettura, sembra esservi poco che storie come Tutto ciò che ami ti sarà portato via (da Tutto è fatidico), sui graffiti inquietantemente profetici trovati in un albergo, non abbiano in qualche modo già detto a proposito della banalità del male e dell’inquietante imminenza del Nulla; e tuttavia è la coerenza tematica dei racconti de Il bazar dei brutti sogni a costituire, a parziale esclusione del precedente lavoro di Cuori in Atlantide (1999), il vero, lampante elemento di novità all’interno della produzione narrativa di Stephen King, quasi come se le sue parti fossero disposte su una linea continua per convergere verso un’unica direzione, un limite differibile. Con un che, quindi, di seriale.
Come abbiamo visto, però, il dialogo tra le due forme, almeno in relazione all’opera di King, ha finora dimostrato di funzionare poco e male, a favore delle più consolidate produzioni cinematografiche, sia lunghe che corte, e delle serie tratte dai romanzi. E un progetto quale il Dollar Babies, tramite cui il Re cede periodicamente i diritti dei suoi racconti, al costo di un dollaro, perché ne vengano tratti cortometraggi senza scopo di lucro, non può far altro che confermare la tendenza: nel 1983 ha portato fortuna a Darabont, del resto, e nulla esclude che possa fruttare qualcosa anche al biellese Massimo Volta, primo italiano direttamente coinvolto nell’iniziativa per merito dell’adattamento di Nona (2016), un’altra delle short stories di Scheletri. Resta la speranza che la futura trasposizione televisiva del racconto La nebbia sia in grado di sfruttare al meglio la spinta pionieristica che la muove: che sappia, cioè, afferrare il bandolo, il filo rosso, il cuore del discorso, per srotolarlo attraverso il tempo e i mille schermi che si accenderanno. E lasciare, eventualmente, il solco per successive rimediazioni dello stesso tipo: quella de Il Bazar dei brutti sogni, per esempio.
Estensioni narrative
Utilizzare il fattore di coesione argomentativa che caratterizza l’ultima raccolta kinghiana, quell’atmosfera di morte che attanaglia, pervade, impregna dichiaratamente ogni sua singola storia, si configura come soluzione ideale per connettere l’insieme delle forme-racconto all’universo audiovisivo seriale, aprendo un canale proficuo fra i due sistemi di codici che sappia parlare, e usare a proprio vantaggio, il linguaggio del genere. E in tal senso, un possibile indirizzo provvedono a fornircelo le più note serie antologiche in circolazione: American Horror Story e, soprattutto, Black Mirror, la quale più si avvicina alla struttura e all’impostazione tematica di una raccolta come Il Bazar dei brutti sogni, con le sue visioni autonome e allo stesso tempo convergenti, sono la dimostrazione che il dispositivo del genere presenta già da sé, nel suo carattere di immediata e stilizzata riconoscibilità, una prima, univoca chiave di lettura che possa valere da fil rouge narrativo, dipanabile ed esplorabile episodio dopo episodio, stagione dopo stagione.
Su questo esempio, al contrario che in passato, l’adattamento televisivo di un’antologia perderebbe il suo statuto di raffazzonato campionario per acquisire il ruolo di estensione narrativa, in senso stretto e lato, amplificando e non più ricalcando l’essenzialità delle singole storie. E andando ad aggiungere una nuova quanto fertile risorsa al già traboccante bacino di trasposizioni audiovisive che circonda il nome di Stephen King assieme alle sue parole: quelle che, per citare lui stesso, e nonostante i segni del tempo sul corpo, “non invecchiano”. Mai.
- Ciro Ascione, La grande bottega degli orrori – Le ossessioni commerciabili di Stephen King, Bulzoni, Roma, 1996.
- Francesca Fichera, Racconti alla tv: ai confini della serialità, 2015.
- Jacob Hall, Stephen King’s ‘The Mist’ Gets 10-Episode Order From Spike TV, 2016.
- Stephen King, A volte ritornano, Bompiani, Milano, 1986.
- Stephen King, Cuori in Atlantide, Sperling & Kupfer, Milano, 1999.
- Stephen King, Tutto è fatidico, Sperling & Kupfer, Milano, 2005.
- Stephen King, Danse Macabre, Sperling & Kupfer, Milano, 2006.
- Stephen King, Al crepuscolo, Sperling & Kupfer, Milano, 2008.
- Stephen King, Notte buia, niente stelle, Sperling & Kupfer, Milano, 2010.
- Stephen King, Stagioni diverse, Milano, Sperling & Kupfer, 2013.
- Stephen King, Incubi e deliri, Sperling & Kupfer, Milano, 2014.
- Stephen King, Quattro dopo mezzanotte, Sperling & Kupfer, Milano, 2015.
- Stephen King, Scheletri, Sperling & Kupfer, Milano, 2015.
- Stephen King, Il bazar dei brutti sogni, Sperling & Kupfer, Milano, 2016.
- Alessandra Sarchi, L’intreccio e il tema. Qualche riflessione su “Tale of Tales” di Matteo Garrone, 2015.
- Charlie Brooker, Black Mirror, 4DVD, 2015.
- Stephen King, Incubi e deliri, Warner Home Video, 2007 (home video).
- Ryan Murphy, Brad Falchuck, American Horror Story, 20th Century Fox, 2013.


