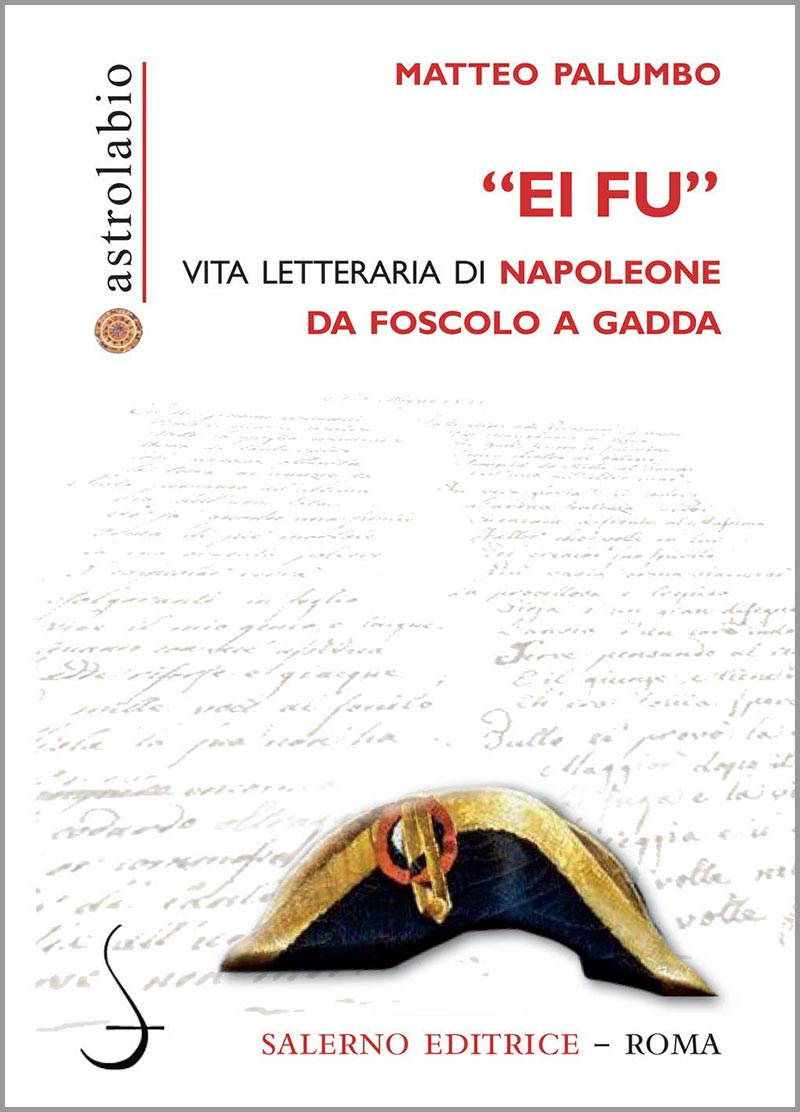Nel romanzo Lorenzo Benoni, ovvero scene della vita di un italiano (1853), il mazziniano Giovanni Domenico Ruffini racconta del penoso stato dell’Italia all’indomani della Restaurazione, della repressione della carboneria e delle speranze del primo Risorgimento. Verso la fine il protagonista, mentre cerca riparo in Francia, caduto in uno stato di dormiveglia, sogna un’isola:
“… e con altrettanta chiarezza vidi l’imperatore Napoleone giacer là morto, vestito come sempre si rappresenta, col suo noto cappello e con gli stivali. Non so come mai avessi in sogno una visione di Napoleone, col quale non avevo mai avuto nulla a che fare e che non avevo visto nemmeno. Egli però giaceva là distintamente innanzi ai miei occhi. Tutti i suoi congiunti e i marescialli quali li vediamo nelle incisioni, erano presenti e movevano processionalmente e riverentemente mentre passava, e tutti poi affollandosi intorno a lui in atto di venerazione”
(Ruffini, 2005).
Difficilmente si può immaginare una dimostrazione più evocativa di ciò che il mito di Napoleone e in particolare l’eco della sua morte in esilio rappresentarono per un’intera generazione di europei. L’entrata a Milano, scriverà Stendhal ne La Certosa di Parma (1839), ruppe il lungo sonno del popolo italiano, che d’un tratto “si accorse che quanto aveva fino allora circondato del suo rispetto era sovranamente ridicolo, odioso talora” (Stendhal, 2010). Napoleone non aveva ancora trent’anni ma era riuscito ad abbattere d’un colpo antichissimi regimi che sembravano come mummificati (l’Italia veniva definita non a caso, all’epoca, “il paese dei morti”; cfr. De Francesco, 2021) e avviare un rimescolamento sociale che avrebbe favorito giovani ambiziosi e di belle speranze che altrimenti non avrebbero potuto far altro che sospirare sui libri (stesso destino a cui era consegnato Napoleone se non fosse scoppiata la Rivoluzione). La Restaurazione aveva fatto dileguare quel mondo, ma il suo ricordo – quasi un sogno, come nel romanzo di Ruffini – non era scomparso. E non lo è nemmeno oggi.
“Queste ceneri non erano abbastanza fredde”
La notizia della morte di Napoleone, nel 1821, non lasciò indifferenti i giovani che sognavano un mondo nuovo. Se ancora Talleyrand poteva affermare che la morte del suo antico padrone non era un avvenimento, ma una notizia (la frase sembra però apocrifa), un liberale come Edgar Quinet rimase sorpreso dal riemergere, dentro di sé, di una passione che credeva ormai sopita:
“… egli irruppe di nuovo nel mio animo, lo assediò; si levò per così dire in piedi nella mia anima come in quelle di tutti gli uomini di quel tempo (…). Ritornò a infestare la mia intelligenza, non più come un imperatore o il mio padrone assoluto, ma come uno spettro che la morte ha quasi interamente cambiato”
(cit. in Criscuolo, 2021).
Fintanto che Napoleone era in esilio a Sant’Elena, buona parte dell’Europa era riuscita a dimenticarlo. Ora, invece, il suo spettro tornava a ricordare, tanto ai fedeli grognard (i veterani della Grande Armée) quanto ai giovanissimi cresciuti nel mito napoleonico, come Alexandre Dumas (che lo aveva visto nel 1815 sulla strada per Waterloo), che c’era qualcosa di più grande del misero ordine sociale in cui la Francia e l’intera Europa erano piombate all’indomani del Congresso di Vienna.
I liberali, che avevano tanto faticato negli anni della Rivoluzione e dell’Impero per salvare quel buono degli ideali dell’89 a loro dire adulterati dal giacobinismo prima e dall’Impero poi, si ritrovarono sopravanzati dal ritorno di fiamma della passione che per quasi vent’anni aveva inebriato la Francia. Già Benjamin Constant, durante i Cento giorni, si era convertito al mito dell’eroe accettando di lavorare per Napoleone alla stesura di una nuova costituzione. Quinet, nel 1835, gli avrebbe dedicato un poema eroico. Adolphe Thiers gli consacrò un’immensa Storia del consolato e dell’impero e, entrato nel governo, convinse l’ormai già indebolito regime orleanista a organizzare il ritorno delle spoglie mortali di Napoleone da Sant’Elena a Parigi. All’entusiasmo trascinante della traslazione delle ceneri agli Invalides rimase freddo Alphonse de Lamartine, che pure nel 1821 aveva composto un’ode intitolata Bonaparte: “Forse, da diversi punti di vista, queste ceneri non erano abbastanza fredde perché vi si mettesse mano” (cit. in Criscuolo, 2021).

L’obiettivo di raffreddare le ceneri della Rivoluzione e dell’Impero è stato a lungo la stella polare del moderatismo liberale francese. Disegno costantemente destinato alla sconfitta ma costantemente ritentato (cfr. Paura, 2020). Era stato Napoleone stesso ad abbattere il regime dei termidoriani, nato per “garantire la proprietà del ricco”, secondo la definizione di Boissy d’Anglas (Soboul, 2001), e che giustamente è stato definito, per il suo cerchiobottismo, la “repubblica delle banderuole” (Serna, 2005). Dopo la sua caduta si era cercato di rilanciare il progetto di una monarchia liberale che però Carlo X aveva affossato. Si ritentò con la monarchia di luglio, “che non riconosceva né la sovranità di un re di diritto divino, né quella del popolo” (Barjot, Chalin, Encrevé, 2003), e a cui proprio nel 1840 – anno del ritorno delle ceneri di Napoleone – François Guizot affibbiò lo slogan “arricchitevi!”.
La mediocrità di un’Europa di “bottegai”, come Napoleone definiva sprezzantemente la piccola borghesia e il suo costante desiderio di usare la politica solo per favorire gli interessi dei possidenti, si scontrava, all’indomani della morte dell’Imperatore, con una cenere ancora calda da cui già a Sant’Elena l’esiliato prevedeva sarebbe un giorno esplosa la conflagrazione generale che avrebbe distrutto l’ordine di Vienna.
“La mente più grande che il mondo avesse mai visto”
Le riflessioni di Quinet ci aiutano a capire come il mito napoleonico sia riuscito ad arrivare intatto fino ai giorni nostri e, soprattutto, come sia riuscito a irretire personalità politicamente tanto diverse, persino opposte, al punto che in seguito sarebbe stato coniato un aggettivo sostanzialmente errato, “bonapartismo”, per indicare il generico entusiasmo popolare per il leader carismatico e la sua presunzione di poter governare al di là delle fazioni politiche.
Bonapartismo che permise a un personaggio oggettivamente mediocre come Luigi Napoleone di diventare imperatore e restaurare la dinastia, ma a cui Victor Hugo affibbiò il nomignolo “Napoleone il piccolo” per distinguerlo da quel “Napoleone il grande” che è stato di recente anche il titolo di un’imponente biografia dello storico inglese (quindi non accusabile di piaggeria) Andrew Roberts (nuova ed. 2021). Bonapartismo che sarebbe, infine, stato ereditato dalla destra gollista, di cui oggi è non a caso espressione la Fondation Napoléon a Parigi. Ma si fa un errore a rileggere l’epopea napoleonica con il filtro politico moderno. Sfuggire “all’autocrazia del suo genio”, come scrisse ancora Quinet, era facile, poiché a nessuno piacciono i despoti e non a caso l’ordinamento politico che Napoleone impose all’Europa si sfaldò con straordinaria rapidità, a dimostrazione di quanto scarsa fosse la propensione ad accettare il disegno imperiale. Più difficile, persino impossibile, è sempre stato sfuggire al fascino magnetico dell’uomo Napoleone, al cui cospetto anche il più acerrimo nemico cedeva.

Lo zar Alessandro assicurò di non aver mai amato nessuno più di lui; la borghesia inglese, che aveva noleggiato le barche a Plymouth per scorgere “Booney” (come veniva sprezzantemente chiamato dai giornali inglesi, benché da tempo la magrezza ossuta avesse ceduto il passo alla pinguedine) prigioniero sul Northumberland, non poté fare a meno di scoprirsi il capo in segno di omaggio al momento della sua apparizione sul ponte della nave. La giovanissima Maria Luisa d’Austria, che fino a pochi mesi prima di sposarlo pregava, insieme a tutta la corte asburgica, per la sua morte, ne fu ammaliata al punto che ancora quando le truppe alleate erano ormai a poche leghe da Parigi, nel marzo 1814, propose una resistenza a oltranza (un anno dopo, sottrattasi all’ipnotismo del marito, lo avrebbe dimenticato tra le braccia del conte Neipperg). La piccola Betsy Balcombe, a Sant’Elena, spaventata dai racconti sull’Orco Napoleone, ne rimase incantata e ci ha lasciato un particolare rivelatorio:
“Molti ritratti raffigurano abbastanza bene Napoleone, ma ciò che nessun pennello ha saputo restituire erano proprio il suo sorriso e i suoi occhi straordinariamente espressivi, in una parola ciò che lo rendeva così simpatico e seducente”
(Balcombe, 2007).
Goethe, che Napoleone incontrò a Erfurt nel 1808, ne fu talmente colpito che non usciva di casa senza il nastro rosso di Gran Croce della Legion d’onore di cui l’Imperatore lo aveva insignito e (ci racconta Ernesto Ferrero nel suo Napoleone in venti parole) lo chiamava Mein Keiser, definendolo in seguito “la mente più grande che il mondo avesse mai visto”. Quella sensazione che irruppe nell’animo di Quinet alla notizia della morte di Napoleone è la stessa che Hegel aveva descritto anni prima, definendo Napoleone “quell’anima del mondo” quando lo vide dopo Jena, meravigliandosi che un uomo del genere potesse essere “concentrato in un punto”, dal quale s’irradiava un potere inarrestabile. Il romanticismo tedesco lo avrebbe definito streben, la tensione verso l’Assoluto che caratterizza l’Uomo romantico, lo sforzo prometeico di superare i limiti umani, gli ostacoli della vita, per realizzare il proprio desiderio di infinito.

Napoleone fu innanzitutto un mito romantico. Se si rilegge Clisson ed Eugénie, il romanzetto che scrisse nel 1795, poco prima di abbandonare ogni velleità letteraria per la politica, l’eco dei Dolori del giovane Werther (1774) di Goethe appare evidente e si può capire allora perché Napoleone, incontrando il poeta tedesco, lo abbia accolto con tanta ammirazione: “Vous êtes un homme!”. Né bisogna dimenticare che una delle letture preferite di Napoleone fossero i Canti di Ossian. Un giovane vorace lettore di opere come queste (ma anche di tantissime altre, tra cui l’immancabile Rousseau) non poteva perdere l’occasione di trasformare la sua vita in romanzo.
“Allora si sedette su un mondo in rovina una gioventù pensosa”
Il caso italiano è emblematico. Sul piano politico, gli entusiasmi descritti da Stendhal erano destinati a spegnersi presto. Basterà appena ricordare la parabola di Ugo Foscolo, autore di un’ode A Bonaparte liberatore (1797), a cui dieci anni dopo replicano i Sepolcri, in cui si elogiava la vittoria di Nelson a Trafalgar e il giudizio del “tradimento” di Bonaparte agli italiani è impietoso. Ma l’infatuazione per Bonaparte era legata non solo e non tanto alle speranze politiche, quanto al fascino romanzesco delle vicende. Guglielmo Ferrero non a caso intitolerà Avventura (1936) la sua storia della campagna d’Italia. È l’eroismo dei capitoli della battaglia del ponte d’Arcole o di quella di Lodi ad accendere le fantasie; un fuoco che resiste molto più a lungo di quello che infiamma i giacobini italiani, le cui speranze con la nascita delle prime “repubbliche sorelle” furono presto frustrate dalla preferenza di Napoleone per gli aristocratici e gli uomini di stato che mise al governo della Cisalpina, e dalla realpolitik che lo portò a disattendere gli ordini del Direttorio di rovesciare il papa (ci penserà più avanti, da imperatore) e a far la pace con l’Austria cedendo Venezia in cambio della riva sinistra del Reno. Dopo la sconfitta di Waterloo e l’esilio, il ritorno dell’ancien régime in Italia portò a far credere che gli anni dell’epopea napoleonica fossero stati poco più di un sogno.

Monaldo Leopardi poté tornare a rinchiudere i figli nel suo palazzo di Recanati e lo stesso Giacomo – ci ricorda Matteo Palumbo nel suo Ei fu. Vita letteraria di Napoleone da Foscolo a Gadda – scrisse negli appunti dello Zibaldone che Napoleone era diventato “un argomento neutro di storia, quasi staccato dalla cronaca di quegli anni e assunto nel quadro di una meditazione generale, fondata su possibili e utili esempi”.
Ernesto Ferrero, in Napoleone in venti parole, riporta il giudizio del piemontese Ludovico di Breme che, scrivendo alla contessa d’Albany, oppositrice di Napoleone, le rivelava la situazione dell’Italia ritornata all’ancien régime dopo il 1815: “Noi qui siamo tranquilli, molto tranquilli: la degradazione, l’estinzione di ogni energia nazionale, l’evaporazione di ogni pensiero, si operano senza rumore; il nulla non è più silenzioso: è la pace delle tombe”.
La morte di Napoleone cambia tutto. Come in Francia, così in Italia infiamma una cenere che si credeva già prematuramente estinta. Alessandro Manzoni, che poteva ben dire che “di mille voci al sonito / mista la sua non ha”, poiché “vergin di servo encomio”, a differenza di quelle di un Vincenzo Monti o dello stesso Foscolo le cui lodi del conquistatore d’Italia si erano sprecate, fu colpito non già dal genio politico o militare, quanto dalla vicenda umana. Scrive ancora Palumbo:
“La morte è diventata dunque il tema poetico: il punto di vista da cui osservare l’avventura militare e politica di Napoleone. Manzoni riprende parole e immagini che già Monti aveva utilizzato. Egli però le immette in un contesto nuovo e ne fa motivo di una scenografia radicalmente diversa (…). Ad accendere l’immaginazione non è più la grandezza delle spedizioni arrivate dovunque quanto l’evento della morte”.
Con la morte di Napoleone si concludeva una stagione durata oltre trent’anni, iniziata con il 1789; stagione politicamente finita già nel 1815, ma che perlomeno in linea teorica poteva ritornare, non tanto con un secondo ritorno “fisico” di Napoleone in Francia (da Sant’Elena la fuga era decisamente implausibile), quanto con un rigurgito bonapartista che, in nome del prigioniero di Sant’Elena, potesse rimettere in discussione gli equilibri del Congresso di Vienna. Non bisogna stupirsi allora di leggere, in quegli anni, i toni di un’enorme tragedia innanzitutto generazionale, perché per decenni avrebbe privato i giovani imbevuti di idee romantiche della possibilità di vivere l’epoca di rivolgimenti straordinari dei loro padri. Luigi Mascilli Migliorini, che al mito napoleonico ha dedicato tantissime pagine (fin da Il mito dell’eroe nel 1984, primo di una importante serie di studi), concludeva la sua insuperata biografia Napoleone (2001, ultima ed. 2021) citando un brano dalle Confessioni di un figlio del secolo (1836) di Alfred de Musset:
“I fanciulli uscirono dai collegi e non vedendo più né sciabole né corazze, né fanti, né cavalieri, chiesero a loro volta dove fossero i loro padri. Ma la risposta fu che la guerra era finita, che Cesare era morto, e che i ritratti di Wellington e di Blücher erano appesi nelle anticamere dei consolati e delle ambasciate con queste due parole in basso: Salvatoribus mundi. Allora si sedette su un mondo in rovina una gioventù pensosa…”.
Gli avrebbero fatto eco le parole di Chateaubriand nelle Memorie d’oltretomba (1848), anche lui tardivamente convertitosi al mito di Napoleone che invece aveva attaccato violentemente nel 1814 scrivendo un panegirico per i Borbone prossimi a tornare sul trono di Francia:
“Passare da Bonaparte e dall’Impero a ciò che li ha seguiti significa cadere dalla realtà nel nulla, dalla cima di una montagna nel baratro (…) l’anima mancò all’universo nuovo sin da quando Bonaparte ritirò il suo soffio vitale; gli oggetti sparirono alla vista dopo che non furono più rischiarati dalla luce che aveva dato loro il rilievo e i colori”
(cit. in Criscuolo, 2021).
Questo topos è ancora vivo a metà del Novecento, quando Italo Calvino scrive Il barone rampante (1957), di cui ci ricorda Matteo Palumbo nella sua ricostruzione dell’eco letteraria di Napoleone in Italia. Cosimo Piovasco di Rondò, che per sfuggire all’esistenza sepolcrale della Liguria di fine Settecento si trasferisce a vivere sulle cime degli alberi, incontra Bonaparte durante la campagna d’Italia, anche se l’incontro poco si sposa con i suoi ideali rivoluzionari. E tuttavia, nuovamente, quando Napoleone ormai sconfitto abbandona il mondo, anche se consapevole che “non c’era più da attendersi che il peggio”, continua nondimeno a sognare di veder “comparire l’Armata Imperiale ancora ricoperta di ghiaccioli russi, e Bonaparte in sella, il mento malraso chino sul petto, febbricante, pallido…”. Al contrario, quel che appare è invece “l’ombra della Restaurazione; tutti i novatori – giacobini o bonapartisti che fossero – sconfitti; l’assolutismo e i gesuiti rianno in campo; gli ideali della giovinezza, i lumi, le speranze del nostro secolo decimottavo, tutto è cenere”.
“In apparenza senza presente, in realtà senza avvenire”
Toccherà a Ernesto Ferrero, nel suo capolavoro N. (2000, premio Strega), continuare quella narrazione ininterrotta che si diparte da Julien Sorel, lettore disperato delle pagine del Memoriale di Sant’Elena nascosto sotto il cuscino ne Il rosso e il nero (1830) di Stendhal, per arrivare fino ai giorni nostri. Quando Napoleone, nel romanzo, arriva all’Elba per il primo suo esilio, a restarne vittima è il giovane Martino Acquabona, intellettuale di provincia che un itinerario esattamente opposto a quello di Pierre Bezuchov in Guerra e pace spinge prima a progettare di uccidere Napoleone per le sue atrocità, e poi una volta conosciutolo a diventarne suo malgrado bibliotecario e ammiratore al punto che, partito l’eroe per tentare l’avventura dei Cento giorni, si renderà conto che non gli resta alternativa che partire a sua volta, rapito dal figlio del secolo.
Nei pochi mesi di permanenza all’Elba, Napoleone riesce a ridestare un popolo intorpidito dal provincialismo e a mettere letteralmente a soqquadro la vita di ogni singolo isolano, convincendoli seppur per un tempo troppo breve di poter per una volta essere protagonisti della Storia, infondendo in loro quella stessa esaltazione adolescenziale che aveva entusiasmato gli uomini della Grande Armée. Ma poi tutto finisce tanto rapidamente com’era iniziato: Napoleone parte e agli elbani non resta che “tornare ad essere i sudditi insignificanti del dolce e pacifico Ferdinando”. Come dirà Martino nella frase, ripresa dal nipote, che chiude il romanzo: “Penso con sgomento che le isole non hanno altro domani che la partenza” (Ferrero, 2000).

Dovette pensarlo anche Napoleone a Sant’Elena, quando iniziò a rendersi conto che da lì sarebbero partiti tutti, tranne lui. Così accadde: prima il conte di Las Cases, poi il dottor O’Meara, quindi il generale Gourgaud, poi la famiglia del generale Montholon. Ed egli sapeva bene che con la sua morte sarebbero partiti anche gli altri, ma non lui, perché il governo inglese non avrebbe mai acconsentito a far rimpatriare la salma in Francia come chiedeva nel testamento, ma l’avrebbe fatta seppellire su quell’isola terribile. È per questo che il capitolo finale dell’epopea napoleonica assume sempre più rilevanza, pur essendo una mera appendice sul piano della vicenda politica (ma sempre più oggi si tende a comprendere quanto quel capitolo sia stato importante per la costruzione del mito politico).
L’idea che il punto in cui lo spirito del mondo hegeliano si concentrò tra l’agosto del 1815 e il maggio 1821 fosse quella minuscola isola dispersa nell’oceano non può non lasciare sgomenti. Come la zia Léonie della Recherche proustiana, che dopo la morte del marito “non aveva più voluto lasciare dapprima Combray, poi la sua casa di Combray, poi la sua camera, infine il suo letto” (Proust, 2017), l’universo di Napoleone – che aveva spaziato “dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno” – si rimpicciolì progressivamente fino a ridursi a una singola stanza, quella a cui Mascilli Migliorini ha dedicato il titolo del suo ultimo libro L’ultima stanza di Napoleone. Una corte in miniatura a stento poteva nascondere la claustrofobia del villino di Longwood, che su un pianoro spazzato dagli alisei accoglieva le circa cinquanta persone che condividevano l’esilio di Napoleone.
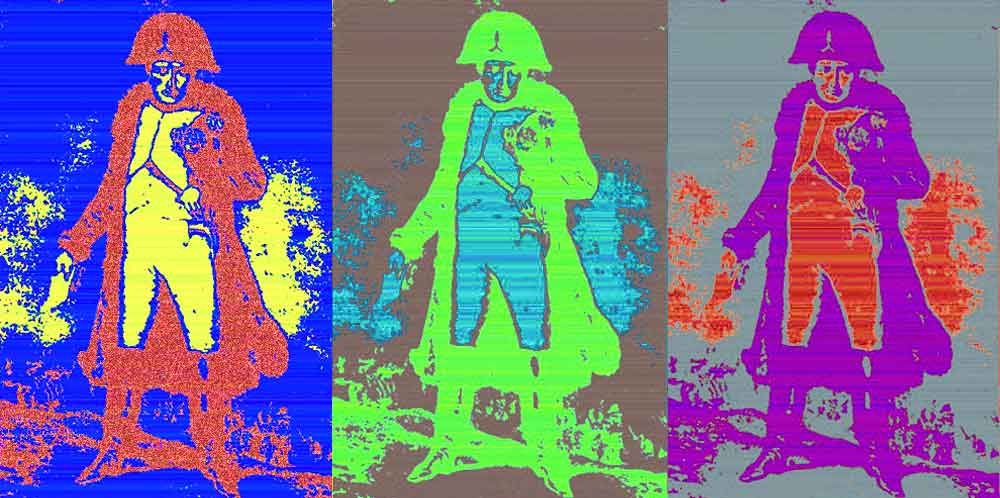
Le “giornate destinate a scorrere in apparenza senza presente, in realtà senza avvenire”, in cui persino le ore assumevano – scrive Mascilli Migliorini – “la densità di un’era geologica e di essa conservano pure l’immutevole consistenza”, dovevano rappresentare però soprattutto un presagio per il mondo che sarebbe seguito alla morte di Napoleone. È infatti il destino di un’intera generazione che Ernesto Ferrero aveva fotografato in N., identificata con il “piccolo mondo antico” dell’isola d’Elba. Con la partenza di Napoleone, l’isola si svuota come una triste località di mare quando gli ultimi attardati vacanzieri hanno fatto ritorno in città, portando con loro i ricordi dell’estate, degli amori appena sbocciati e spesso subitaneamente finiti, delle promesse destinate a non essere mantenute: il porto vuoto e malinconico di Portoferraio è l’Europa intera dal quale il soffio potente dell’avventura è ormai sparito e a cui non resta altro che una sequenza infinita di grigi giorni tutti uguali.
In questa cornice ha senso oggi ripensare all’epopea napoleonica, pur a duecento anni di distanza. Se ragionassimo con il freddo metro del giudizio politico, non potremmo che concordare con quanti oggi (ampiamente fuori tempo massimo, peraltro) chiedono in Francia di ridimensionare il mito di Napoleone accusandolo di aver ripristinato la schiavitù nelle colonie, di aver introdotto un diritto famigliare dichiaratamente ostile alle donne, di aver perfezionato i meccanismi dell’autoritarismo e del plebiscitarismo che avrebbero fatto scuola nei decenni a venire (non più comunque, va ricordato, degli altri regimi del tempo).

Politicamente la distanza tra il mondo di oggi e l’ordine europeo che Napoleone aveva in mente è siderale; viceversa è ancora di estrema attualità quel confronto tra il mondo che fu e il mondo che è, confronto che non lasciò indifferenti nemmeno un liberale insospettabile di bonapartismo come Quinet o un realista reazionario come Chateaubriand:
“Svanito l’entusiasmo industrialista, l’inazione e il decadimento morale diventavano i caratteri dell’età liberale, mentre i giorni dell’Impero napoleonico tornavano ad apparire circondati da un’aurea di fascino lontano”
(Mascilli Migliorini, 2003).
Anche noi oggi, “come aspettando il fato”, continuiamo a sognare, come i giovani romantici di allora, che giunga il richiamo dell’avventura e della gloria a scuoterci dal torpore e rompere gli equilibri di un mondo invecchiato. In questo, probabilmente, si situa quell’identificazione un po’ forzata tra la sorte di Napoleone e quella di Cristo che egli stesso cercò di propagandare durante l’esilio e che Manzoni e tanti altri avrebbero ripreso: la tensione tra il non più e il non ancora, tra quello che poteva essere e non fu e quello che potrebbe essere e ancora non è.
- Betsy Balcombe, Il mio amico Napoleone, Mondadori, Milano, 2007.
- Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline, André Encrevé, Storia della Francia nell’Ottocento, il Mulino, Bologna, 2003.
- Antonino De Francesco, Il naufrago e il dominatore. Vita politica di Napoleone Bonaparte, Neri Pozza, Vicenza, 2021.
- Ernesto Ferrero, N., Einaudi, Torino, 2000.
- Ernesto Ferrero, Napoleone in venti parole, Einaudi, Torino, 2021.
- Guglielmo Ferrero, Avventura. Bonaparte in Italia (1796-1797), Corbaccio, Milano, 1996.
- Luigi Mascilli Migliorini, Napoleone, Salerno Editrice, Roma, 2001.
- Luigi Mascilli Migliorini, Il mito dell’eroe, Guida, Napoli, 2003.
- Roberto Paura, La Rivoluzione francese e noi, Il Tascabile, 15 maggio 2020.
- Marcel Proust, Dalla parte di Swann, Mondadori, Milano, 2017.
- Andrew Roberts, Napoleone il grande, UTET, Torino, 2021.
- Giovanni Domenico Ruffini, Lorenzo Benoni, ovvero scene della vita di un italiano, De Ferrari, Genova, 2005.
- Pierre Serna, La République des girouettes, Champ Vallon, Cayzérieu, 2005.
- Albert Soboul, Storia della Rivoluzione francese, BUR, Milano, 2001.
- Stendhal, Il rosso e il nero, Mondadori, Milano, 2010.