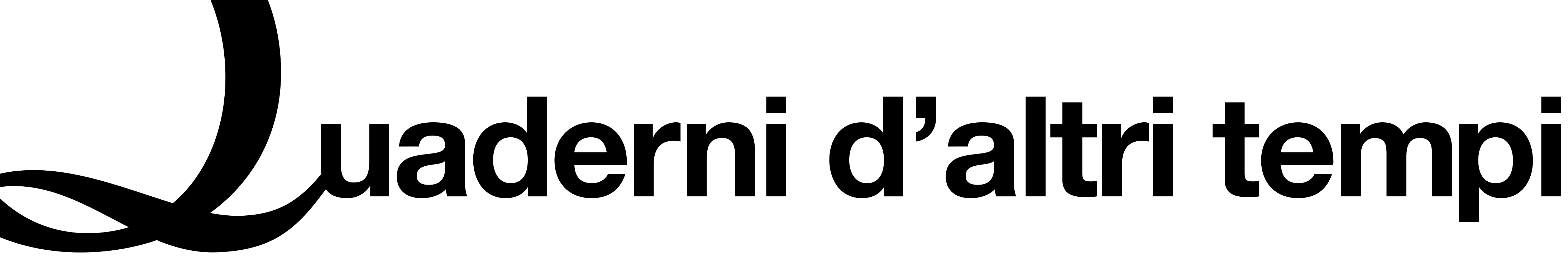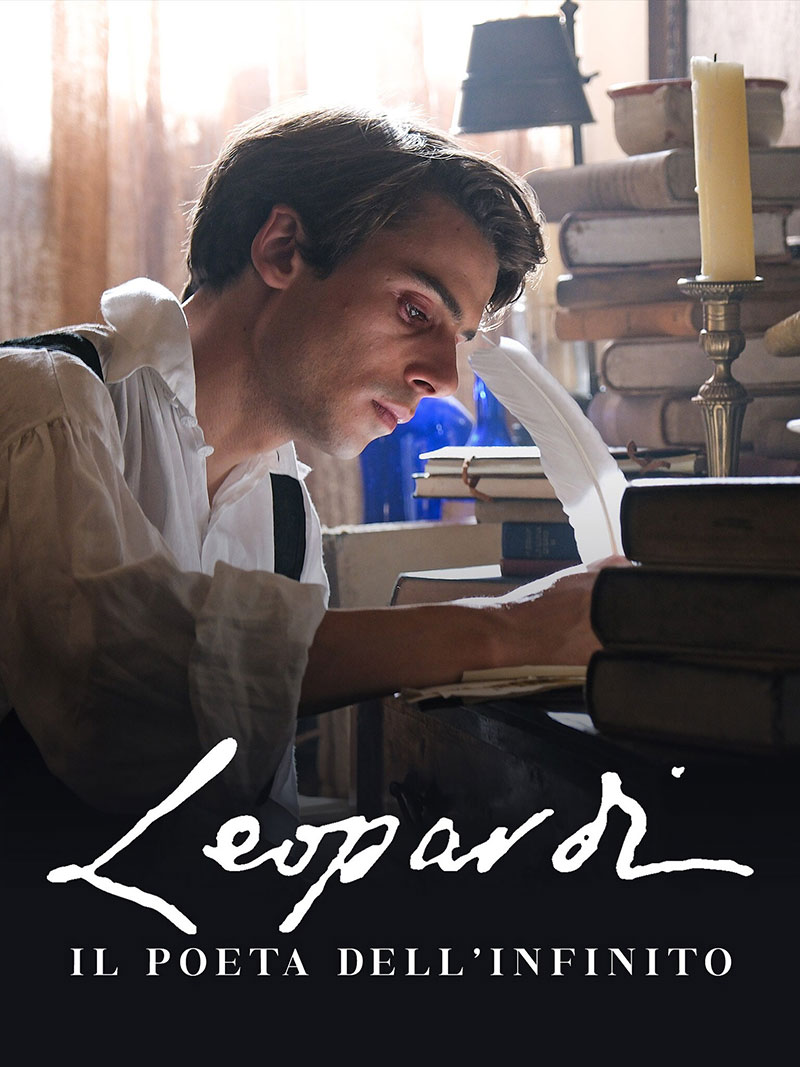In una scena della miniserie andata in onda su RaiUno il 7-8 gennaio 2025, Leopardi – Il poeta dell’infinito, diretta da Sergio Rubini, Niccolò Tommaseo, l’autore del monumentale Dizionario della lingua italiana, fornisce una mirabile prova del suo fiuto letterario (sic!) predicendo che, nel giro di un secolo, del poeta Giacomo Leopardi (Recanati 1798-Napoli 1837) nessuno si sarebbe ricordato un verso. La storia, per fortuna, si è incaricata di dar torto all’invidioso scrittore di origine dalmata, del quale forse solo quattro specialisti oggi si rammentano il nome, mentre le poesie e le opere di Leopardi non sono mai state così attuali: non è solo il poeta più rappresentativo, dopo Dante Alighieri, della nostra letteratura a livello mondiale. Leopardi anticipa il Novecento e il nuovo Millennio su non pochi temi, a partire da quelli esistenziali-filosofici. Due su tutti: le riflessioni sulla noia e sul nulla intrinseco all’esistenza umana. Se fosse vissuto nel XX e ancor più nel XXI secolo avrebbe forse pensato o scritto come Emil Cioran.
Se guardiamo anche distrattamente il contributo che il cinema e il piccolo schermo hanno dato negli ultimi venti, trent’anni alla costruzione di un filone narrativo e biografico del poeta recanatese, troveremo una striscia audiovisiva di gran lunga più succinta di quella legata all’Alighieri. La miniserie di Rubini, alla sua prima regia televisiva dopo aver diretto una quindicina di film, un lavoro presentato in anteprima all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, rimarrà, quindi, insieme a Il giovane favoloso (2014) di Mario Martone, un caposaldo del biopic cine-televisivo, a dispetto di tutti i limiti già evidenziati dalla critica e in parte condivisibili, come si vedrà, di questa nuova versione nella quale un Leopardi giovane, bello e un po’ maledetto, nonché imbranatissimo e ingenuo con le donne, esce da certi cliché del genio precoce, malandato e ingobbito, erudito e pessimista. Oltre a Il giovane favoloso di Martone, che aveva già curato nel 2011 una trasposizione scenica delle Operette Morali, ricordiamo il film Idillio del 1980 di Nelo Risi e Pisa, donne e Leopardi, diretto da Roberto Merlino nel 2011 e sceneggiato da Paola Pisani Paganelli, un lavoro incentrato sul soggiorno pisano del poeta. Ai quali affianchiamo le versioni teatrali e televisive di opere specifiche come Il Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero, realizzato da Ermanno Olmi nel 1954 e oggi visionabile su YouTube.
La natura matrigna
Leopardi è molto di più del giovane irrequieto che scalpita per evadere dal “natìo borgo selvaggio” di Recanati, animato da patriottismo poetico (la canzone All’Italia, composta a Recanati nel 1818), sempre vittima di amori impossibili, spesso per donne come Fanny Targioni Tozzetti che flirta con lui, ma desidera Antonio Ranieri, l’esule politico napoletano che Leopardi conobbe a Firenze. Il sodalizio con Ranieri iniziò nel novembre 1830. Antonio Ranieri era una decina d’anni più giovane di Leopardi: gli rimase vicino fino alla morte e ne pubblicò i Pensieri nel 1845. Uno dei limiti concettuali del film di Sergio Rubini è consequenziale alla scelta di dare troppo spazio alla storia con Fanny Targioni Tozzetti, indebolendo, così, il focus sulla Weltanshauung, la filosofia di Leopardi, il cui pessimismo era già ai suoi tempi da molti incompreso o tenuto in dispregio: per citare un episodio non rappresentato nel film di Rubini, nel 1830 l’Accademia della Crusca assegnò un premio di mille scudi per la Storia d’Italia dal 1789 al 1814 di Carlo Botta (13 voti) relegando a un solo voto (quello di Gino Capponi, uno dei pochissimi intellettuali amici veri di Leopardi) le Operette Morali, che erano uscite per i tipi dell’editore milanese Antonio Fortunato Stella nel 1827. Leopardi era troppo avanti, era già nel Novecento, anzi era nel nuovo Millennio: è infatti il primo esistenzialista italiano, Non a caso Emanuele Severino, che ha scritto libri fondamentali per la rilettura contemporanea del recanatese, lo colloca in principio del volume dedicato alla filosofia contemporanea.
Il film di Rubini non riesce, a nostro avviso, a cogliere i principali passaggi nell’evoluzione poetico-filosofica dello scrittore; impresa tutt’altro che facile anche per gli addetti ai lavori: la “mostruosa” produttività leopardiana si esplica su almeno cinque livelli spesso sincroni: filologia-erudizione-traduzione; poesia e curatela editoriale; critica letteraria, sociale e storica; speculazione filosofica con apice nelle Operette Morali; riflessioni sui più diversi campi dello scibile (l’immenso Zibaldone), dall’estetica alla morale, dalla linguistica alla religione. In qualunque manuale di storia della letteratura italiana si possono individuare almeno tre principali “conversioni” di Leopardi: 1) politica (da cattolica a laico-patriottica); 2) estetica (dal bello al vero) e 3) filosofica, con il passaggio al pessimismo e alla concezione di una natura “matrigna”, “l’antica Natura onnipossente/che mi fece all’affanno” (da La sera del dì di festa) che trova due esempi nel Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette Morali) e nelle considerazioni sviluppate ne La Ginestra, scritta nel 1836 a Napoli, in una villetta alle falde del Vesuvio. Affrontarne la biografia, così intrecciata a una poderosa produzione letteraria, è quindi un’impresa complicata, ma sempre meritevole se contribuisce a far conoscere al grande pubblico la vita del primo poeta contemporaneo italiano.
Gli studi matti e disperatissimi
Nel 1817 inizia la corrispondenza con Pietro Giordani (nel film interpretato da Fausto Russo Alesi), una figura di grande rilievo nella vita di Leopardi, che in quello stesso anno pubblica la traduzione del secondo libro dell’Eneide, molto apprezzata. Il giovanissimo poeta (non ha nemmeno vent’anni) è nel pieno della sua attività filologica, immerso in ‘studi matti e disperatissimi’, come scriverà al Giordani il 2 marzo 1818:
“[…] in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più…”
(Leopardi, 1993).
Ecco come si descrive Leopardi nel luglio del 1819 quando decise di fuggire da Recanati, “il natio borgo selvaggio”, come lo definisce nelle Ricordanze, chiedendo al conte Broglio di Macerata il passaporto per il viaggio:
“Età 21 anni. Statura piccola. Capelli neri. Sopracciglia nere. Occhi cerulei. Naso ordinario. Bocca regolare. Mento simile. Carnagione pallida”.
Anni dopo (1834) viene dipinto così da August von Platen:”
“Il primo aspetto del Leopardi, presso il quale il Ranieri mi condusse il giorno stesso che ci conoscemmo, ha qualche cosa di assolutamente orribile, quando uno se l’è venuto rappresentando secondo le sue poesie. Leopardi è piccolo e gobbo, il viso ha pallido e sofferente, ed egli peggiora le sue cattive condizioni col suo modo di vivere, poiché fa del giorno notte e viceversa. Senza potersi muovere e senza potersi applicare, per lo stato dei suoi nervi, egli conduce una delle più miserevoli vite che si possano immaginare. Tuttavia, conoscendolo più da vicino, scompare quanto v’è di disaggradevole nel suo esteriore, e la finezza della sua educazione classica e la cordialità del suo fare dispongono l’animo in suo favore”
(Platen, in Leopardi, 1993)
Una questione di gobba?
Leopardi era già cosciente di essersi rovinato il fisico, e che “virtù non luce in disadorno ammanto” come scrive ne L’ultimo canto di Saffo (1822). Ma il Leopardi impersonato dal ventisettenne Alessandro Maltese, un bravo attore ravennate, del vero Leopardi non ha fisicamente nulla, essendo Maltese un bel ragazzo, fascinoso, biondino, e pure senza la proverbiale gobbetta. Che invece non mancava al Leopardi recitato da Elio Germano ne Il giovane favoloso di Martone. Forse anche per questo il nuovo Leopardi di Rubini, molto abbellito e romanzato, ha riscosso un gran successo di pubblico, superando in ascolti il Grande Fratello (e questa è la più bella notizia) nonostante alcuni palesi limiti, fra i quali l’audio, ritenuto pessimo da molti ascoltatori. E d’altronde, è così necessario mostrare le deformità del poeta? Uno degli obiettivi dichiarati del film di Rubini è raccontare un Leopardi inedito, bramoso di vita, di gloria, di amore, di bellezza, un poeta romantico che vuole rompere le catene degli obblighi e delle coercizioni familiari per trovare una sua più autentica dimensione esistenziale e letteraria. Non è che Martone si ponesse obiettivi più tradizionali e conservativi: il suo Leopardi, se non è proprio un Kurt Cobain dell’epoca, è certamente un intellettuale e un poeta in disarmonia con la famiglia e con il suo tempo. In quel periodo tumultuoso, fra l’avvio del rapporto epistolare con il Giordani e il primo tentativo di fuga da Recanati (1818-1819) scrive due canzoni patriottiche, All’Italia e Sopra il monumento di Dante. La prima inizia così:
“O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l’erme
torri degli avi nostri
ma la gloria non vedo”.
E dalla canzone Sopra il monumento di Dante:
“Beato te che il fato
a viver non dannò fra tanto orrore….
Perché venimmo a sì perversi tempi?”.
Sono versi preveggenti quindi attualissimi se pensiamo all’Italia di un secolo dopo, ma anche all’Italia di oggi, cioè dal Dopoguerra in poi. Siamo nel periodo (1819) di un cambiamento nell’animo del poeta, che lo condurrà alla riflessione filosofica:
“La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, cioè nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai ad abbandonar la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose (in questi pensieri ho scritto in un anno il doppio quasi di quello che avea scritto in un anno e mezzo, e sopra materie appartenenti sopra tutto alla nostra natura, a differenza dei pensieri passati, quasi tutti di letteratura), a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo”
(Leopardi, 1993).
Non dobbiamo quindi dimenticare un dato biografico importantissimo: Leopardi comincia a scalpitare per evadere dalla dorata prigione di Recanati solo dopo aver cominciato la corrispondenza con Pietro Giordani, e soprattutto a causa dell’aggravarsi dei suoi molteplici malanni fisici. L’acuirsi dei problemi agli occhi gli impedisce la lettura e lo studio, sue uniche soddisfazioni. A 16-17 anni, Giacomo aveva scritto questa riflessione:
“La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per esser certa, e lo stato in cui vive, buono, non lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro. Questo divino stato l’ho provato io… trovandomi quietamente occupato negli studi senz’altri disturbi, e colla certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire… questa tale speranza che sola può render l’uomo contento del presente, non può cadere se non in un giovane di quella età [sedici diciassette anni] o almeno esperienza”
(ibidem).
A proposito di studi e letture voraci, la scoperta della biblioteca paterna (superba la prova di Alessio Boni nel ruolo del conte Monaldo, il padre di Leopardi), che contava oltre 10.000 volumi, da parte di un Leopardi ancora bambino è uno dei momenti più suggestivi del film di Rubini, che si apre con una scena a sua volta di grande effetto: Antonio Ranieri fa condurre la bara di Leopardi nella parrocchia di San Vitale e trova l’opposizione di Don Carmine (interpretato da Alessandro Preziosi), fermamente intenzionato a non ospitare nel luogo sacro il corpo di un grande poeta, una grande anima, come giustamente ricorda il Ranieri, ma ateo e materialista. Vigeva anche un editto che proibiva il seppellimento dei morti in città a causa del colera in quei giorni imperversante a Napoli. Ranieri rievoca, allora, l’esistenza dell’amico, dai primi anni di studio “matto e disperatissimo” nella biblioteca paterna, ai viaggi in Italia, vere e proprie peregrinazioni letterarie e mondane tra Roma, Milano, Bologna, Firenze, Pisa, e infine Napoli. Entrambe le versioni (quella di Martone e di Rubini) hanno il pregio di stimolare lo spettatore alla rilettura o alla scoperta di poesie e testi poco studiati nelle scuole che salmodiano-tiriterano con L’infinito, Alla Luna, A Silvia, Il passero solitario, riducendo Leopardi a uno stereotipo intellettuale, al poeta de “La donzelletta (che) vien dalla campagna” o del “e’l naufragar m’è dolce in questo mare” rubato già più volte dalla pubblicità.

Ben venga, invece, la rilettura di poesie più complesse come il Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia, Le Ricordanze o Aspasia, un testo straordinario, dietro il quale si avverte il tentativo di superare l’amore per Fanny Targioni Tozzetti, che nel film di Rubini confessa ad Antonio Ranieri il suo imbarazzo per quel titolo che la eterna assimilandola a una delle cortigiane più famose della classicità. Nel film di Rubini si accenna anche alla Palinodia al marchese Gino Capponi, poesia-manifesto di tutto il pensiero anti-modernista e anti-progressista di Leopardi. Una poesia fortemente ironica sul futuro di una società che attende miracolosi cambiamenti dal progresso, da “Le magnifiche sorti e progressive” per citare un famosissimo verso de La ginestra, o fiore del deserto. Gino Capponi, ricordiamolo, faceva parte degli amici di Toscana, insieme a Pietro Colletta e Giampietro Viesseux, fondatori dell’Antologia (1821). Bellissima, invece, nel senso più interiore dell’aggettivo, la figura di Marianna Brighenti, figlia del Pietro Brighenti, stampatore bolognese, che poi si rivelerà un informatore degli austriaci. Interpretata dalla deliziosa Emma Fasano, Marianna, insieme a Paolina, amata sorella del poeta, è l’unica figura bella e positiva di donna intorno allo sfortunato Leopardi che in materia di approcci con l’altro sesso era così incapace da risultare, proprio per questo, molto romantico e sognatore.
La mancanza di Pisa e Milano
Se è vero che anche il film di Mario Martone non manca di licenze poetico-narrative, come le scene finali di Leopardi accompagnato dall’amico Ranieri nei bassifondi popolati da prostitute e femminielli, ancor più ricca di invenzioni è la versione di Rubini, a partire da quel bacio tra Leopardi e Ranieri che sembra occhieggiare a un pubblico gay o bisessuale. È anche vero che molte lettere del poeta ai suoi interlocutori più cari (e non solo il Ranieri) sono intrise di patetismi e dichiarazioni d’amore amicale che, rilette oggi, suonano un po equivoche. Per quanto riguarda i numerosi luoghi nei quali si articola l’inquieto pellegrinaggio leopardiano, il film di Rubini non considera due soggiorni importanti: Pisa e Milano. Fra Pisa e Leopardi scoppiò un innamoramento au premier coup d’oeil (at first sight), e a Pisa scrisse fra l’altro A Silvia, uno dei testi che non può mancare in qualunque antologia poetica leopardiana. Sul soggiorno meneghino di Leopardi, che giunse a Milano la sera del 30 luglio 1825, ci limitiamo a proporre il seguente passo da una lettera a Carlo Antici:
“Io vivo qui poco volentieri e per lo più in casa, perché Milano è veramente insociale, e non avendo affari, e non volendo darsi alla pura galanteria, non vi si può fare altra vita che quella del letterato solitario”
(Leopardi in Brilli 2017).
Chiudiamo tornando al Leopardi filosofo con una riflessione di Severino:
“È vero che Nietzsche conosceva Leopardi. È vero che Wagner conosceva Leopardi. È vero che Schopenhauer conosceva Leopardi. Ma erano quelle suggestioni in cui coloro che davano questo riconoscimento facevano anche il peggiore servizio a Leopardi, perché quando Nietzsche scrive che Leopardi è il maggiore prosatore del secolo XIX, è un modo per nascondere che Leopardi è uno dei giganti del pensiero filosofico. Un gigante a livello di Hegel, Kant. Anzi, il più radicale, perché proprio Leopardi […] mostra che se c’è un eterno non ci può essere il divenire”
(Severino, 2018).
- Attilio Brilli, In viaggio con Leopardi, il Mulino, Bologna 2017.
- Pietro Citati, Leopardi, Mondadori, Milano, 2010.
- Giacomo Leopardi, Canti, Einaudi, Torino, 1993.
- Giacomo Leopardi, Operette Morali, Mondadori, Milano, 2017.
- Giacomo Leopardi, Operette Morali, Garzanti, Milano, 2002.
- Giacomo Leopardi, Epistolario, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
- Giacomo Leopardi, Zibaldone, Newton Compton, Roma, 2007.
- Mario Martone, Ippolita Di Majo, Il giovane favoloso. La vita di Giacomo Leopardi, Mondadori Electa, 2014.
- Anna Poerio, Leopardi e Poerio nel film di Sergio Rubini, La voce impertinente, 10 gennaio 2025.
- Emanuele Severino, Il nulla e la poesia. Alla fine dell’età della tecnica: Leopardi, Rizzoli, Milano, 2005.
- Emanuele Severino, Lezioni milanesi. Il nichilismo e la guerra (2015-2016), Mimesis, Milano-Udine, 2018.
- Mario Martone, Il giovane favoloso, Rai Cinema, 2014.
- Ermanno Olmi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Edison e Archivio nazionale del cinema d’impresa,1954.
- Nelo Risi, Idillio. L’infinito di Giacomo Leopardi, Rai, 1980.