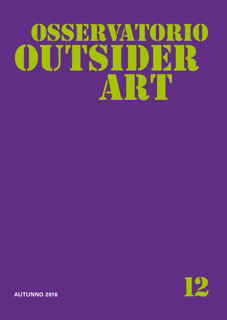- MAPPE | Quaderni d'altri tempi | #64 sommario
MAPPE | QDAT 64 | 2016




di Eva di Stefano
La
passione di Jean Dubuffet per i valori selvaggi
Fuori dalla
cultura artistica ufficiale o sperimentale esiste una produzione
espressiva indipendente, dove si manifesta spontaneamente uno spirito
creatore, che non segue modelli, ignora le correnti artistiche e le
tecniche, né si propone una finalità esterna alla
propria necessità interiore, ma inventa da sé le
proprie regole e il proprio vocabolario. Per questi autori
“ignoranti” creare è
un’attività privata, una forma inconsapevole di
autoterapia, un impegno totalizzante che coincide con la propria
vita. Il progressivo riconoscimento estetico di queste creazioni
anarchiche e irregolari è strettamente intrecciato con la
storia dell’arte del XX secolo, che ha progressivamente
spostato i confini e destabilizzato la visione, implicando una
trasformazione dello sguardo che ai canoni classici preferisce la
“forma perturbante”.
A inventare nel 1945 la nozione di Art Brut (arte grezza) è un artista francese in polemica con la cultura artistica ufficiale: Jean Dubuffet, al termine di un celebre viaggio “iniziatico” in Svizzera alla ricerca dei “primitivi del XX secolo”, le cui opere scopre all’interno degli ospedali psichiatrici. In comune con altri grandi artisti dell’età contemporanea, Dubuffet ebbe un atteggiamento di sfida verso l’eredità illuminista. Per questo, nel solco delle esplorazioni esotiche e africane che, da Paul Gauguin alle avanguardie storiche, avevano rinnovato i linguaggi artistici dell’occidente, decise di indagare se nei margini della società europea si celassero ancora dei “valori selvaggi”.
Non era naturalmente il solo, e nella rivalutazione della eccentricità creativa era stato preceduto da psichiatri eterodossi, come Hans Prinzhorn e Walter Morgenthaler, che negli anni Venti, anche sulla scia dell’estetica espressionista, avevano attribuito alle opere dei loro pazienti un valore estetico e non puramente patologico. E anche dai surrealisti, che avevano sempre esaltato l’energia creativa degli stati allucinatori e le ossessioni creative di autodidatti come il celebre postino Cheval, autore di un babelico palazzo ad Hauterives. Ma Dubuffet fu colui che si spinse più in là negli antri della mente dove le cerimonie del sociale vengono capovolte. Ciò che gli interessava era ritrovare la spontaneità e l’energia vitale del processo creativo dei primordi, la forza bizzarra della visione senza condizionamenti, che scopriva nei “militi ignoti” dell’arte, quei creatori che vivono ai margini e che nei loro manufatti trasferiscono di peso il proprio delirio, senza la zavorra del sapere artistico:
“L'Art Brut designa opere realizzate da persone indenni da cultura artistica, nelle quali il mimetismo, contrariamente a ciò che avviene negli intellettuali, abbia poca o nessuna parte, in modo che i loro autori traggono tutto (argomenti, scelta dei materiali, tecnica, ritmo, modi di scrittura etc.) dal loro profondo e non da stereotipi dell'arte classica o dell'arte di moda […] Questi lavori creati dalla solitudine e da impulsi creativi puri e autentici – dove le preoccupazioni della concorrenza, l'acclamazione e la promozione sociale non interferiscono – sono, proprio a causa di questo, più preziosi delle produzioni dei professionisti” (Dubuffet, 1971).
Raccolse più di 5.000 opere, ne fece nel 1949 una mostra a Parigi, fondò un’associazione, scrisse ed editò dei quaderni, infine regalò la sua collezione alla città di Losanna, dove nel 1976 fu inaugurato un museo-antimuseo, secondo la concezione del suo primo direttore Michel Thévoz. Un lascito straordinario per l’arte del XX secolo che mette in moto il riconoscimento di creazioni nate nell’ombra, che, con il loro modello di libertà creativa, hanno costituito una sorgente d’ispirazione per molti artisti celebri, come per esempio: Alfred Kubin, Paul Klee, Max Ernst, Jean Arp, il Gruppo Cobra, Jean Tinguely, Arnulf Rainer, Daniel Spoerri, Annette Messager, Georg Baselitz, Julian Schnabel, Jonathan Borofski.
Prevalgono nella collezione storica di Dubuffet le opere dei malati mentali, in primo luogo perché la sua indagine iniziale nelle istituzioni psichiatriche svizzere ha alle spalle la tradizione francese di interesse per l’arte psicopatologica: dal libro pionieristico di Marcel Réja nel 1907 fino alla mostra del 1950 all’ospedale Sainte-Anne a Parigi di opere provenienti da diversi manicomi europei e d’oltreoceano, a cui è dedicato il libro di Robert Volmat del 1956 che analizza le produzioni artistiche di psicotici dal punto di vista estetico. Influente fu anche il celebre e molto illustrato volume del 1922 del già citato psichiatra tedesco Hans Prinzhorn, vero livre de chevet della generazione surrealista, che Dubuffet conosceva bene:
“Le immagini riprodotte nel libro di Prinzhorn mi hanno enormemente colpito da giovane. Mi mostrarono il cammino ed ebbero su di me un’influenza liberatrice. Presi coscienza che tutto era permesso, tutto era possibile. Esistevano milioni di possibilità per esprimersi fuori dai sentieri culturali battuti” (Dubuffet, 1971).
C’è da dire che Dubuffet non crede affatto che la produzione espressiva degli alienati sia di per sé artistica (“Non esiste un’arte dei malati mentali così come non esiste un’arte dei dispeptici o dei malati al ginocchio”), è convinto invece che ci siano “artisti naturali” reclusi nei manicomi, e che la loro condizione di isolamento ed esilio sociale abbia favorito un’urgenza creativa, probabilmente destinata a non esprimersi in un contesto meno drammatico.
La follia non dispensa talento, ma le ragioni per cui un individuo è giudicato inadatto alla vita sociale contano poco sul piano dell’arte, quando si prescinde, come Dubuffet, da posizioni formalistiche: ci sono altre doti più sottili, come l’istinto, la chiaroveggenza, la poesia, che possono mettere in crisi la costruzione ufficiale del mondo indicando altri valori. Bisogna sgombrare il campo dall’idea che l’Art Brut non sia che un’ennesima variante del tema genio e follia.

Foto: Claudine Garcia, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
02. Pietro Ghizzardi, Susi, Tecnica mista su cartone, 1965. Casa-Museo Pietro Ghizzardi, Boretto (Reggio Emilia)
03. Michel Nedjar, Senza titolo, 1982. Assemblaggio di tessuto, paglia, spago, cenci, bottoni, tessuto a maglia. Altezza: 95,5 cm.
Foto: Arnaud Conne, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
Dall’Art
Brut all’Outsider Art
Il termine Art Brut ha
assunto nel tempo un fisionomia storicizzata che coincide con la
Collezione di Losanna, mentre oggi più che una categoria
artistica, rappresenta un motore di pensiero critico
sull’arte e le sue definizioni, nello spirito dello stesso
Dubuffet:
“l’art brut, lo stato selvaggio o la libertà non devono essere concepiti come luoghi, soprattutto non come luoghi fissi, ma come direzioni, aspirazioni, tendenze” (Dubuffet, 1969).
Da allora, il riconoscimento di questa regione anomala della creatività contemporanea non si è più arrestato, acquisendo anche – oltre il suo nome storicizzato – molte altre denominazioni, tra le quali prevale Outsider Art, affermatasi nel mondo anglosassone da quando lo storico dell’arte Roger Cardinal ebbe a titolare così il primo volume inglese sul tema, pubblicato nel 1972.
Rimandando semplicemente a un concetto spaziale in cui è implicita una dialettica tra Dentro e Fuori, universi paralleli con un differente destino, Outsider Art è un termine più flessibile rispetto alla nozione storica di Art Brut, e ha consentito la crescita di un vero e proprio sistema dell’arte parallelo che ha i suoi musei, le sue gallerie, i suoi collezionisti, le sue riviste, le sue fiere e le sue aste. Oggi si contano nel mondo più di ottanta istituzioni museali dedicate, una Outsider Art Fair che si tiene a Parigi e a New York, un processo di “artificazione” culminato nella Biennale di Venezia del 2013, che ha affiancato negli stessi spazi gli artisti professionisti e gli irregolari “ridando centralità all’opera a prescindere dal sistema che la sostiene” (De Grandi, 2016). Molte barriere tradizionali sono crollate: lo studioso di estetica Mario Perniola parla di arte espansa e di svolta fringe dell’arte contemporanea (cfr. Perniola, 2015).
Mentre le mostre “ibride” sono diventate sempre più di tendenza, il termine stesso Outsider Art viene oggi messo in discussione in quanto confermerebbe differenza e esclusione, fino ad essere rifiutato da alcuni specialisti come Ricardo Aquino, direttore del Museo Bispo do Rosario a Rio de Janeiro, o James Brett, creatore a Londra del Museum of Everything, grande collezione privata itinerante. Che senso ha mantenere questa discriminazione? – si chiede anche il critico Jerry Saltz affascinato dalle opere esposte all'Outsider Art Fair di New York. Di fronte a queste opere i parametri consueti infatti vacillano e l'unico discrimine ancora certo appare il mercato speculativo che domina e definisce il mondo dell'arte contemporanea. Sono in molti a ritenere che l’attuale crescita di interesse per l'Outsider Art sia il sintomo di una debolezza dell’arte contemporanea, di un canone in crisi in un’epoca dove il surplus visuale ha creato una velocissima obsolescenza e standardizzazione delle immagini, e dove l’arte è assoggettata come tutto il resto all'economia. In questa situazione l’Outsider Art si pone come un antidoto, rappresenta un valore non omologato di intensità e di comunicazione forte, e finora anche di autenticità rispetto alle leggi di mercato, perciò una sua assimilazione definitiva nel paese glamour dell'arte contemporanea non è esente da rischi.

Foto: Olivier Laffely, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
05. August Walla, In Hölle ich…, ca 1982, matita, pastelli colorati e pastelli a cera su cartone stampato sul retro, 31,5 x 30,2 cm.
Foto: Garance Dupuis, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
La via italiana:
l’arte irregolare
Paradossalmente le uniche
collezioni italiane di Art Brut sono nate non sulla base di un
interesse estetico, ma come testimonianza della devianza, oggetto di
studio della scienza positivista che negava loro qualsiasi valore
artistico. Sono gli oggetti raccolti nei Musei Antropologici Cesare
Lombroso e Giovanni Marro di Torino, o nel Centro di Documentazione di
Storia della psichiatria “San Lazzaro” di Reggio
Emilia. La diffidenza della cultura italiana verso produzioni
artistiche non formaliste non ha creato condizioni favorevoli ad
un’accoglienza dell’Art Brut. Si aggiunge
l’assenza di un sistema forte dell’arte
contemporanea che, nel resto del mondo occidentale, ha determinato in
parallelo la crescita di interesse per l’arte fuori norma, e
si comprende come l’Italia non partecipi
all’attuale clima internazionale di de-marginalizzazione e
non abbia praticamente recepito la svolta estetica proposta dalla
Biennale di Venezia del 2013. Il dibattito resta confinato tra pochi
specialisti, e le rare iniziative espositive hanno un impatto culturale
limitato. Anche il collezionismo privato, potente in altri paesi,
è ancora quasi inesistente: la Collezione Cei, esposta al
pubblico da un anno nel Castello di Casale Monferrato, è
un’eccezione e comunque comprende pochissimi autori italiani.
L’unica raccolta istituzionale di autentica Art Brut
è quella pionieristica, dedicata a creatori siciliani, del
piccolo museo civico di arte contemporanea di Caltagirone, del tutto
periferico rispetto ai circuiti influenti.
Negli stessi anni in cui Dubuffet mette assieme la sua portentosa raccolta, si attesta invece in Italia tra il 1950 e il 1970, attorno al caso di Ligabue, la nozione di arte naïve, che trova il suo territorio d’elezione nella Pianura Padana soprattutto per merito delle esplorazioni di Cesare Zavattini, la cui collezione è esposta dal 1968 al Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara in Emilia Romagna, e per l’azione promozionale di Dino Menozzi con la sua rivista L’arte naïve (1973-2002) che si apre solo con il tempo all’arte marginale in senso più ampio (cfr. Danchin, 2013). Un confluire di sensibilità culturali diffuse, che non si è verificato per la più ruvida Art Brut, e che forse, esaurita l’originaria spinta populista, produce semmai fraintendimenti.
Art Brut, infatti, non è uguale ad arte naïve: se hanno in comune l’origine popolare, la spontaneità fantasiosa, il primitivismo e l’infantilismo tecnico dell’autodidatta, l’arte naïve ha però le sue convenzioni costanti mutuate dall’arte colta, così come ne imita i mezzi usando tecniche e materiali tradizionali, ed è compiacente, idilliaca, esteriore, mimetica, gradevole, rassicurante, si adegua alle richieste del pubblico e del proprio mercato, è insomma la sorella povera dell’arte ufficiale. L’Art Brut invece è come un’orfana ribelle che non conosce parenti, ascendenze e discendenze, non si adegua, è – non per scelta ma per natura e circostanze – sovversiva, indipendente, clandestina, autarchica, si nutre solo di se stessa e della propria ossessione.
La distinzione dunque è chiara e riguarda sia i mezzi espressivi che i contenuti, oltre che l’atteggiamento dell’autore rispetto al consenso esterno, ma nella prassi le categorie a volte si sovrappongono e non sempre risulta agevole collocare gli artisti su una delle due sponde, perché tra le due rive del fiume della spontaneità ci sono molti ponti e traghetti. Un caso esemplare è Pietro Ghizzardi (1906-1986) pittore contadino scoperto da Zavattini, catalogato come “naïf”, ma oggi per la sua grezza intensità riconosciuto come “brut”. O viene definito “irregolare”, poiché la nozione di art brut continua a fare fatica ad essere accettata nella terminologia critica italiana forse anche per la sua assonanza con “brutto”. “Arte irregolare”, termine coniato dal critico Bianca Tosatti per superare la contrapposizione tra naïf e brut, e proposto dalla stessa Tosatti in numerose grandi mostre dal 1997 al 2006, resta in Italia la definizione più in uso fino alla recentissima esposizione Irregolari. Sguardi laterali nell’arte italiana da Antonio Ligabue all’Atelier dell’Errore, curata da Daniela Rosi a Cles (2016).
Un altro momento chiave della vicenda italiana è la contestazione dell’istituzione psichiatrica che culminerà nella sua abolizione con la riforma Basaglia (1978). La nuova attenzione volta alla soggettività e al mondo emozionale del paziente porta ad una moltiplicazione degli atelier d’arteterapia, di cui è antesignano l’atelier creato nel 1957 dallo scultore inglese Michael Noble all’interno dell’ospedale S. Giacomo alla Tomba di Verona. In questo ambiente orizzontale dove gli utenti erano lasciati liberi di esprimersi, esplode il talento di Carlo Zinelli (1916-1974), i cui moduli grafici appaiono in sorprendente e spontanea sintonia con il proprio tempo. Portato a conoscenza di Dubuffet nel 1962 dal giovane psichiatra Vittorino Andreoli sarà il primo creatore italiano ad entrare nella Collection de l’Art Brut e resta ancora oggi l’autore più internazionalmente riconosciuto.
Nel tempo, gli atelier operativi all’interno di istituzioni socio-sanitarie si sono costituiti come il principale vivaio dell’arte irregolare italiana, così lo storico La Tinaia di Firenze, il non più esistente Atelier Adriano e Michele a Pavia, Blu Cammello a Livorno, La Manica Lunga a Cremona, e oggi l’Atelier dell’Errore a Reggio Emilia e Bergamo per citarne solo alcuni. Nella situazione italiana di cronica indifferenza, gli atelier si pongono come centri di produzione e promozione che riescono a catturare l’attenzione oltreconfine. Vita più dura hanno i “battitori liberi”, i creatori individuali che devono attendere il loro scopritore: qualcuno, tra i pochi curatori in questo settore, che tuteli la loro opera, condannata alla dispersione in quanto considerata senza valore.

Foto: Claude Bornand, Collection de l’Art Brut, Losanna.
07. Adolf Wölfli, Dieu-le-pére Cambridge, 1909, matita e pastelli colorati su carta, 50 x 37 cm.
Foto: Arnaud Conne, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
08. Carlo Zinelli, Senza titolo, realizzato tra il 1957 e il 1958, gouache (guazzo) su carta da disegno, 50 x 35 cm.
Foto: Arnaud Conne, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
Visioni e passioni
L’Art Brut è anche una questione di incontri: tra
Adolf Wölfli e lo psichiatra Walter Morgenthaler che favorisce
la sua attività di creazione all’interno del
manicomio svizzero di Waldau; tra Aloïse Corbaz e la giovane
dottoressa Jacqueline Porret-Forel nel manicomio di Losanna. Per
ambedue la valorizzazione dell’opera dei loro
pazienti-artisti diventa centrale, sconfinando oltre
l’impegno medico professionale.
Ed è anche un insieme di autobiografie immaginarie, di reinvenzione della vita passata per sopportare l’esistenza presente. Per Adolf, che scrive e disegna le mappe di territori immaginari e sconosciuti nel suo straordinario codice miniato colmo di riferimenti segreti, importa poco la realtà materiale della reclusione; il suo vero luogo è quello dell’immaginario, dove egli conduce una vita utopica ben al di là dei limiti reali. Con il nome di Sant’Adolfo e poi di Sant’Adolfo II, inizia a costituire il proprio regno dal 1912, grazie a un potere conquistato con l’immaginazione.
Aloïse (1886-1964), nei suoi grandi disegni colorati con una libertà che ricorda Matisse, vive un suo amore immaginario con un principe azzurro e crea un proprio “teatro dell’universo” (Porret-Forel, 1993) abitato da prosperose cantanti liriche e figure di amanti. Disegna e dipinge di nascosto, nelle pause del suo compito di stiratrice della biancheria dell’ospedale, estraendo i colori da erbe e petali di fiori del giardino, almeno finché la Porret-Forel non scopre la sua attività clandestina e le procura i materiali.
Anche Carlo Zinelli rielabora a suo modo le proprie esperienze ambientali e di guerra nelle silhouettes bucate e seriali e nel ritmo dei geroglifici che si ripetono nelle sue tempere. Per l’austriaco August Walla (1936-2001), ricoverato nell’ospedale di Gugging presso Vienna, dove già alla fine degli anni Sessanta lo psichiatra Leo Navratil stimolava i pazienti al lavoro artistico fondando anche una Casa degli artisti per i più dotati (oggi Art Brut Center/Gugging), parole e immagini si combinano in un’unica griglia figurativa a celebrare un pantheon personale di dei, demoni e profeti aureolati da giaculatorie di nomi, vocaboli stranieri e termini inventati. Non solo psicotici tra gli artisti storici della collezione di Dubuffet, ma anche medium: come Augustin Lesage (1876-1954), ex-minatore che dipinge sotto “dettatura degli spiriti” decoratissime architetture immaginarie fondate sul principio di simmetria e sull’horror vacui, un caso studiato anche dagli appassionati di metapsichica dell’epoca. O l’inglese Madge Gill (1882-1961), che disegna di notte in stato di trance su rotoli di stoffa lunghi anche dieci metri, intarsi geometrici, scale multiple e scacchiere, abitate da una fantasmatica figura femminile sempre uguale.
Sono molti i creatori che sostengono di essere guidati da spiriti o voci. Si può suppore che queste “voci” siano prodotte da un bisogno subliminale di emancipazione che il contesto sociale non consente a queste persone, e che quindi può essere liberato solo a patto di essere autorizzato da un’autorità oltremondana: la voce o il sogno darebbero licenza di esprimersi a chi non è socialmente legittimato a farlo (Thévoz, 1990).
L’horror vacui caratterizza molti autori: Willem van Genk (1927-2005) nelle sue tecniche miste di grande formato accosta i suoi ricordi di viaggio in vertiginose vedute urbane, fino a colmare tutto lo spazio disponibile: multiple cartoline della lontananza da una vita molto travagliata. Stereotipia, stilizzazione, decorativismo ossessivo, ripetizione seriale, horror vacui, combinazione di scrittura e immagine sono caratteri ricorrenti ma non esclusivi. La varietà dei linguaggi e delle tecniche è sorprendente e rispecchia la singolarità di ogni creatore.
Molto forte è, ad esempio, l’attitudine al bricolage, come i mascheroni fatti con conchiglie di Pascal Maisonneuve (1863-1934), collezionati anche da André Breton, o le commoventi costruzioni mobili in legno di Émile Ratier (1894-1984), contadino diventato quasi cieco. E tra le produzioni più recenti possiamo annoverare anche i fucili di materiali riciclati di André Robillard (1934).
Anche il riciclaggio di elementi trovati è uno dei procedimenti oggi più frequenti, rivelando abilità e fantasia straordinaria nel trasmutare gli scarti quotidiani, dalla cartastraccia ai ritagli di lamiera di barili di petrolio dismessi. A volte con esiti inquietanti, come nel caso di Michel Nedjar (1947) creatore di molteplici bambole-feticcio utilizzando vecchi brandelli di stoffe intinte di terra e sangue: imprescindibile il rapporto di queste opere con il vissuto dell’artista, la cui famiglia ebrea di sarti e commercianti di tessuti fu decimata dall’Olocausto. L’uso di stoffe, ricami e materiali tessili è molto diffuso: Judith Scott (1943-2005) usa grossi fili colorati, spaghi e fibre per avvolgere oggetti quotidiani fino ad occultarli e a trasformarli in scultura tessile.
Le storie personali degli artisti sono fondamentali per una buona comprensione delle opere. Accertata preliminarmente la loro qualità estetica, conoscere l'origine e il contesto della loro genesi è fondamentale: se si tratta di “mitologie individuali” per usare la felice definizione di Harald Szeemann (Szeemann, 1985), è necessario partire dalla singolarità dell'individuo e dalle sue “pieghe” esistenziali. Per capire il senso del lavoro incessante della Scott, occorre infatti sapere che, bambina down e sordomuta, viene separata dalla famiglia e dalla amatissima sorella gemella, e vive per trentasei anni in istituto, finché la gemella diventata adulta non la prende con sé. Sarà solo allora che la Scott, frequentando il Creative Growth Art Center di Oakland, recupera una forma di comunicazione con l’esterno creando i suoi bozzoli, come un rituale di seppellimento e resurrezione, un’azione forse inconsapevole di simbolizzazione e autoterapia. L’esperienza della Scott rende anche chiara la funzione maieutica svolta dagli atelier protetti di creazione.

Foto: Olivier Laffely, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
10. Emile Ratier, Senza titolo, sd, 219 x 73 x 79 cm.
Foto: Caroline Smyrliadis, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
Una storia esemplare
Solitudine, silenzio, segreto caratterizzano spesso
l’attività creativa degli autori brut o outsider.
Un caso paradigmatico è quello di Henri Darger (1892-1973) e
del suo lascito straordinario. Nato a Chicago, orfano di madre,
trascorre infanzia e adolescenza in un istituto da cui fugge a
diciassette anni. Dopo alcuni anni di vagabondaggio, attorno al 1920
torna a Chicago dove lavora come lavapiatti in un ospedale dove
resterà tutta la vita. Conduce un’esistenza
abitudinaria e solitaria, abitando in un monolocale. Nessuno sa della
sua incessante attività creativa notturna, che
sarà scoperta dal padrone di casa quando a ottantuno anni
Darger lascia l’abitazione per ritirarsi in una casa di
riposo. In quella stanza da svuotare c’è un
tesoro: una saga illustrata di 15.000 pagine intitolata Nei
regni dell’irreale. Le magnifiche
illustrazioni sono strisce orizzontali lunghe da due a tre metri,
create mescolando collage, gouache, acquarello e calchi con carta
carbone. Vi si racconta una lunga e crudele guerra tra bambini e un
esercito di adulti malvagi, i Glandeliniani. Le sette Vivian Girls sono
le eroine ermafrodite che liberano i bambini dalla schiavitù
e dai soprusi. Il riferimento agli abusi vissuti probabilmente da
Darger nell’istituto è palese. Con la sua fantasia
traspone, riscatta e vendica le torture subite, e non gli basta una
vita.
La storia, scrive il suo autore: “coinvolge le nazioni di un mondo sconosciuto o immaginario, o paesi, aventi la nostra Terra per Luna… Questo pianeta immaginario è mille volte più grande del nostro mondo” (Romano Pace, 2015).
Le sue fonti sono le immagini ritagliate dalle riviste, i quotidiani, i fumetti, le pubblicità, i libri per l’infanzia, che incolla sul foglio o ricalca con la carta carbone ricombinandole nelle scene della sua epopea, sicché nelle illustrazioni, di cui ciascuna costituisce un’opera a sé, si può rintracciare un vero repertorio della cultura visiva popolare americana tra gli anni Venti e gli anni Sessanta.
Forse questo aspetto, insieme alla singolarità di questa creazione, ne ha decretato il successo post mortem: le sue opere, rimaste di proprietà dei padroni di casa, raggiungono nelle aste quotazioni alte per un artista brut, che vanno da 145.000 a 200.000 euro. E, inoltre, hanno varcato la frontiera che separa l’universo dei musei di arte contemporanea dalle collezioni specializzate in creazioni marginali: le sue opere si trovano infatti non soltanto nella Collection de l’Art Brut di Losanna, ma anche al Museum of Modern Art di New York e al Museo di Arte Moderna di Parigi.

60 x 276 cm. Foto: Claude Bornand, Collection de l’Art Brut, Losanna.
Fuori dal museo
La creazione necessaria può presentarsi anche nella forma di
opera ambientale: una costruzione spontanea e visionaria, un giardino o
un edificio caratterizzato da un insieme decorativo e sculturale
originale, parchi di sculture e assemblaggi realizzati spesso con
materiali di recupero, opere totali nate dalla dedizione e ossessione
di un creatore autodidatta e autosufficiente. Una fenomenologia ampia
con punte d'eccellenza, dove sembra esprimersi – ancora oggi
al massimo grado – la libera creatività
individuale dell'uomo comune e il paradigma poetico di
Dubuffet.
La storia inizia con Ferdinand Cheval (1836-1924), un postino di campagna che decide di costruire il suo Palazzo Ideale, in cui combina e giustappone babelicamente stili e reminiscenze che vanno dall’Egitto ai templi indiani, torri, pinnacoli, sculture di animali, personaggi storici o leggendari. Lavora eroicamente da solo per trent’anni anche di notte alla sua creazione onirica, tra l’incomprensione dei concittadini di Hauterives. Ma con il tempo la sua opera sincretista sarà considerata un capolavoro di architettura spontanea e nel 1969 verrà iscritta nel registro dei monumenti storici di Francia e sottoposta a tutela, oggi è un’attrazione turistica che porta circa 150.000 visitatori all’anno a Hauterives (cfr. www.quadernidaltritempi.eu/numero6). Un altro eroe della costruzione solitaria è un emigrante italiano negli Stati Uniti, Sabato Rodia (detto anche Sam, 1879-1955), che nella zona di Watts alla periferia di Los Angeles, erige nell’arco di trentatré anni un complesso di diciassette strutture a torre, dove le più alte raggiungono trenta metri di altezza. Costruite senza un progetto e senza attrezzature sofisticate, con cemento ed acciaio e abbellite con formazioni musive di tegole rotte, piatti, bottiglie, e una varietà di oggetti ritrovati, le strutture piene di colore furono fabbricate con un’abilità che stupisce gli architetti e gli ingegneri contemporanei, e hanno resistito a vari terremoti. Entrate nell’immaginario americano, citate da molti scrittori, definite perfino “una cattedrale del jazz” (De Lillo, 1999), da poco sono anche un sito protetto dall’UNESCO.
Sembra una fiaba la storia di Nek Chand (1924 -2015), che per cinquant’anni costruisce da solo nella foresta presso Chandigarh (India) con pietre, cemento e cocci il Rock Garden, una favolosa città alternativa abitata da migliaia di sculture-personaggi, prima clandestina, poi accusata di abusivismo, oggi una delle maggiori attrazioni turistiche dell’India Settentrionale.
Queste imprese creative straordinarie non sono un’eccezione: in tutto il mondo esistono individui positivamente visionari che, da soli e senza alcuna patente professionale, decidono di sfuggire al pragmatismo utilitario dedicando la loro vita alla costruzione di una casa dell'anima e intercettando la risonanza di un genius loci. Anche in Italia, dove sono catalogati sul sito dell’associazione Costruttori di Babele.
Ad esempio, il Santuario della Pazienza a San Cesario di Lecce: una installazione imponente di figure e totem in cemento incrostato di cocci, vetri, ferro e molteplici materiali di scarto, che Ezechiele Leandro (1905-1981) artista poliedrico e di mestiere riparatore di biciclette, ha realizzato nel cortile adiacente alla sua casa, mescolando ispirazione sacra e profana.
Un altro insieme monumentale si trova in Sicilia presso Sciacca: è il Castello Incantato, un giardino dove tra gli ulivi migliaia di teste di pietra sono disposte ad anfiteatro o aggregate in cumuli piramidali. Le ha scolpite con mezzi rudimentali, dagli anni Venti agli anni Sessanta, Filippo Bentivegna (1888-1967), un contadino analfabeta, emigrato giovanissimo per alcuni anni in America, che dopo il suo ritorno sceglie una vita isolata e nella pietra si fabbrica un mondo parallelo, la propria grandiosa trincea dall’effetto fiabesco e inquietante. Due esempi tra i tanti, scelti perché recentemente sono stati riconosciuti ufficialmente e pionieristicamente come bene artistico da tutelare, e sono ambedue visitabili. Un segno che i codici estetici contemporanei sono diventati più inclusivi e che la consapevolezza del valore di queste creazioni eccentriche è in crescita.

Foto: Beppe Gernone, courtesy Osservatorio Outsider Art.
13. Filippo Bentivegna, Il Castello Incantato, Sciacca, particolare.
Foto: Pavel Konečný, courtesy Osservatorio Outsider Art..

Foto: Laura E. Ruberto, courtesy Osservatorio Outsider Art.
15. Judith Scott, Senza titolo, 2003, assemblaggio di fili di lana e materiali diversi, 33 x 49 x 43 cm.
Foto: Arnaud Conne, Atelier de numèrisation – Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Losanna.
16. Ferdinand Cheval, Palais Idéal, Hauterives (Francia).
Foto: Hidehiko Nagaishi,Collezione Palais Idéal, Hauterives.
LETTURE
— Giorgio Bedoni, Francesco Porzio, Carlo Zinelli. Cronache visionarie, Glifo Edizioni, Palermo, 2014.
— Giorgio Bedoni (a cura di), Outsider Art. Contemporaneo presente. Collezione Fabio e Leo Cei, Jaca Book, Milano, 2015.
— Laurent Danchin, Art Brut. L’instinct créateur, Gallimard, Parigi, 2006.
— Laurent Danchin, Dall’Arte Naïve all’Art Brut. La vicenda italiana, in O.O.A., 6, ottobre 2013, Glifo edizioni, Palermo.
— Francesco De Grandi, Fiori di ciliegio, in Osservatorio Outsider Art, 11, primavera 2016.
— Don De Lillo, Underworld , Einaudi, Torino, 1999.
— Antonella Di Marzo et al. (a cura di), Leandro unico primitivo, Grenzi, Foggia, 2016.
— Eva Di Stefano, Irregolari, Art Brut e Outsider Art in Sicilia, Kalòs, Palermo, 2008.
— Jean Dubuffet, Asfissiante cultura, Feltrinelli, Milano, 1969.
— Jean Dubuffet, I valori selvaggi. Prospectus e altri scritti, Feltrinelli, Milano, 1971.
— Gustavo Giacosa, Martine Lusardy (a cura di), Banditi dell’arte, Halle Saint-Pierre, Parigi, 2012.
— John M. Macgregor, Henry Darger. Nei regni dell’irreale, Fondazione Galleria Gottardo, Lugano; Collection de l’Art Brut, Losanna, 1995.
— Gabriele Mina (a cura di), Costruttori di Babele. Sulle tracce di architetture fantastiche e universi irregolari in Italia, Elèuthera, Milano, 2011.
— Lucienne Peiry, I feticci magici di Judith Scott, in Osservatorio Outsider Art, 11, primavera 2016.
— Mario Perniola, L’arte espansa, Einaudi, Torino, 2015.
— Jacqueline Porret- Forel, Aloïse et le théâtre de l’univers, Skira, Ginevra, 1993.
— Alba Romano Pace, Henry Darger nel paese delle crudeltà e delle meraviglie, in Osservatorio Outsider Art, 10, autunno 2015.
— Daniela Rosi (a cura di), Irregolari. Sguardi laterali nell’arte italiana da Antonio Ligabue all’Atelier dell’Errore, Effe e Erre, Trento, 2016.
— Harald Szeemann, Individuelle Mythologien, Neuer Verlag, Berlino, 1985.
— Michel Thévoz, Art Brut, psychose et mediumnité, Editions de la Différence, Parigi, 1990.
— Bianca Tosatti (a cura di), Figure dell’anima. Arte irregolare in Europa, Mazzotta, Milano, 1997.
— Bianca Tosatti (a cura di), Oltre la ragione. Le figure, i maestri, le storie dell’arte irregolare, Skira, Milano, 2006.