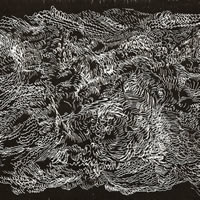
-
Silverwater
di The Necks
ReR 2009
Distribuzione Goodfellas
Nelle foto sotto: The Necks (da sinistra a destra, Lloyd Swanton, Tony Buck e Chris Abrahams), le copertine degli album Townsville, Hanging Gardens, The Boys e un’altra foto del trio.





ascolti / di Gennaro Fucile
Niente sul pianeta Terra somiglia a The Necks, un progetto sonoro che sfugge ad ogni tentativo di classificazione. The Necks sono: Chris Abrahams (piano, organo, tastiere elettroniche), Tony Buck (batteria, percussioni e nell’ultimo disco anche chitarra), Lloyd Swanton (basso elettrico e contrabbasso). Arrivano dall’Australia (anche se Abrahams è neozelandese), sono in attività da oltre vent’anni, hanno pubblicato quindici dischi, il primo nel 1989 intitolato Sex, l’ultimo qualche mese fa è Silverwater, nome di un sobborgo industriale di Sidney (città dove ha base la formazione e che ha dato i natali agli altri due componenti del trio).
The Necks immaginano, compongono ed eseguono musica che appartiene all’ordine della trance. Possiedono un notevole senso dello swing, concepiscono lunghe reiterazioni come richiede la scuola minimalista, colorano con uso misurato dei timbri ottenendo un proprio sound come esige la tradizione pop, architettano una ragnatela di rimandi, come richiedono le più elementari norme postmoderne, ma si tengono distanti anni luce dal citazionismo.
Il trio frulla, distilla, destruttura e ricompone porzioni disomogenee della musica del Novecento: Steve Reich, Miles Davis, Bill Evans, Terry Riley, Brian Auger, Paul Schultze, Morton Feldmann, Can, Brian Eno per fare qualche nome. Svolgendone la trama, il recente Silverwater illustra a dovere il metodo The Necks.
I primi sei minuti sono affidati all’organo che vibra, risuona, quasi sibila. Tremola, dominando la scena. È accompagnato da piccole percussioni. Risuona un sonaglio, un’intrusione sconcertante. Sette minuti e mezzo: rulli di tamburo e pianoforte affollano la scena, l’organo quasi impercettibilmente si ritira.
Nove minuti e mezzo: irrompe il contrabbasso, una rapida incursione, svanisce nel nulla, riappare. Le percussioni, ostinate, insistono.
Verso il dodicesimo minuto prende forma un solo di tamburo, la batteria diventa protagonista come si usava un tempo. Quattordici minuti e mezzo, vi si affianca il contrabbasso, ripetendo quattro semplici note. Si prosegue così fino al diciassettesimo minuto, quando la sequenza viene reiterata anche da colpi secchi sui piatti. Rientra l’organo, si profila un tema melodico, arioso, avvolgente, ma anche vagamente ansiolitico. È lo sciame di piccole percussioni che mantiene alta la tensione.
Le tastiere vengono sovrapposte, echi di musica cosmica, ma è una suggestione tra le tante.
Al ventinovesimo minuto, una chitarra elettrica attraversa la scena, l’atmosfera si fa vagamente post rock alla Tortoise.
Verso il trentaduesimo minuto, basso e batteria si fanno pesanti, volutamente squadrati, le tastiere sempre più avvolgenti, il pianoforte riemerge e torna a far da strumento guida.
Minuto 36: entra di nuovo una chitarra a rimescolare le carte, una breve meditazione vagamente tormentata, poi tutto sembra frenare. La scena si sfalda.
Al minuto 41, ci sono unicamente piccole percussioni e un minuto dopo basso e batteria rientrano precipitosamente per sparire di lì a poco. Ancora l’esile tessitura delle percussioni, sequenza quasi tribale, piccola danza sciamanica, di nuovo irrompe la sezione ritmica, rispunta una chitarra, arpeggi melanconici, un’altalena che prosegue fino a circa 48 minuti e mezzo, quando, come un segnale a intermittenza, un synth con timbro a là Terry Riley sembra condurre tutto verso il silenzio.
Quasi al cinquantaduesimo minuto, però, riecco più soul che mai un organo in sottofondo, anche una batteria, sembrano provenire dalla stanza accanto. Dopo un paio di minuti folate d’organo sempre più ravvicinate, ora il tono decisamente cool, una ripresa e uno sviluppo delle battute iniziali, anche il pianoforte ritorna più ritmico che mai.
Quasi al minuto 60 riecco la chitarra sentita venti minuti prima. Ogni strumento si ricava ancora un attimo di gloria prima di procedere verso lo spegnimento di ogni ardore.
Chiude il classico trio piano, contrabbasso e batteria, un battito secco, poi tenue, ripetuto prima della fine.
Ritmi ossessionanti, atmosfere pacate, squisitamente ambient, il timbro groovy di un organo hammond, quello liquido di un piano elettrico, un solido baricentro costruito sulle corde di un contrabbasso, figure melodiche e ritmiche essenziali, riff ostinati, morbido e secco lavoro di spatole e piatti, pulsanti, fughe psichedeliche. Il trio suona trance jazz, si potrebbe ipotizzare. La loro immaginazione musicale sembra già risuonare in una considerazione del pianista Alfred Cortot che, nel 1938, a proposito delle composizioni per solo piano di Erik Satie, Gnossiennes, scrisse che: “Non ci si può impedire di condividere il piacere quasi ipnotico del musicista, che ripete a se stesso, senza stancarsi, la stessa frase che accarezza il suo orecchio, come un orientale che respiri, un minuto dopo l’altro, il penetrante profumo di una rosa che si sfoglia” (Satie, 1980). Uno stato d’estasi che di rigore è il passo che precede l’accesso ad una soglia superiore di conoscenza, ad una perdita del precedente Sé e, d’altronde, il neologismo di Satie incorpora la gnosi come coerente radice. La ripetizione è sempre condizione necessaria per abbandonarsi, per deprivare i sensi, astrarsi e Satie alzò il tiro in questa chiave, concependo qualcosa a cavallo tra il sadomaso e la pura ascensione: Vexations.
Come sottolinea David Toop: “Vexations si rivela una sezione tratta da un’opera scritta da Paracelso, il filosofo e fisico alchimista del XVI secolo, che scriveva soprattutto a proposito della ‘luce naturale dell’uomo’ e della tranquillità della mente che dovrebbero sopraggiungere alla fine di un procedimento alchimistico” (Toop, 1999). Il brano è sempre per pianoforte solo e venne composto tra il 1893 e il 1895. È costituito da 840 ripetizioni di un unico motivo, opera la cui esecuzione integrale richiede circa 19 ore. Durò 18 ore e 40 minuti nella prima integrale organizzata da John Cage al Poker Theatre di Manhattan, dalle ore 18 del 9 settembre 1963 alle 12 e 40 del giorno successivo, una performance che vide alternarsi ben 12 pianisti. La raccomandazione di Satie all’esecutore è la seguente: “Per suonare a se stessi 840 volte di seguito questo motivo, sarà bene prepararsi previamente, e nel massimo silenzio con delle serie immobilità” (Satie, ibidem).
Chi ha visto in concerto o in video (si cerchi su YouTube) The Necks, troverà un’inaspettata applicazione di queste istruzioni applicate a un secolo di distanza dal loro concepimento.
Le loro composizioni durano in media un ora, quasi tutti i loro dischi sono composti da un’unica traccia, con la sola eccezione di The Boys (1998) che, essendo la colonna sonora di un omonimo film, presenta solo brani di durata normale (se non lillipuziana se usiamo l’unità di misura di The Necks), e di The Chemist (2006) che insolitamente propone tre tracce, ognuna di circa venti minuti. Nella discografia si contano diversi live, il penultimo, Townsville (2007, un concerto tenuto al Riverway Arts Centre di Thuringowa in Australia, vedi Quaderni d’Altri tempi n. 11), il box quadruplo Athenaeum, Homebush, Quay & Raab (2002), Photosynthetic (2003) registrato a Mosca, Piano, Bass, Drums (1998). Difficile distinguere queste performance dai lavori in studio per l’identico meticoloso dipanarsi di una trama che si rende complessa perché costituita da molteplici inizi e ritorni. Come scrive Michele Rago a proposito di Jacques le Fataliste et son Maître (1778) di Denis Diderot: “Quanto più si procede tanto più i racconti minori si moltiplicano. È come se un'irruente gemmazione rivestisse il tronco che da principio appariva come racconto principale… Sbucano altre storie, racconti – miniatura, favole, apologhi, aneddoti, quadretti satirici. In pratica è il sistema detto in francese del roman a tiroirs, romanzo a tiretti” (in Diderot, 1979). Lo stesso procedimento adottato nel rutilante Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1760). Un gioco serio, quindi, come la partecipazione che esige Satie e poco importa se conducano alla via interiore, se aprano le porte della percezione, se consentano l’ascesi. La musica di The Necks sembra piuttosto funzionare per associazione “che mette a contatto idee completamente diverse, e slegate (tranne che nella mente che le ha casualmente unite)… e non appena l’una si affaccia all’intelletto, l’altra associata appare anch’essa; e se ce ne sono più di due così unite, l’intera banda, sempre inseparabile, si mostra tutt’assieme” (Locke, 1971). Il sospetto che tutta la musica funzioni così è fondato, ma di sicuro il procedimento vale per The Necks. Nelle loro composizioni – sorta di micro sinfonie che ben si addicono ai tempi post moderni –, si può rintracciare un doppio, una dimensione meta-musicale, che si svela man mano che i brani, (ri)prendono forma. È solo un effetto collaterale, in The Necks il concettualismo è assente, il suono sgorga naturalmente, le trame si dipanano senza un fine apparente, agitate da un moto perpetuo, rigenerandosi all’infinito, volatilizzandosi, strutturandosi con rigore e passione. I tre musicisti davvero respirano insieme.
La loro musica è fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i mantra.
:: letture ::
— Diderot J., Jacques le Fataliste et son Maître, 1778, trad. it. Jacques il fatalista e il suo padrone, introduzione di Michele Rago, Einaudi, Torino, 1979.
— Satie E., Quaderni di un mammifero, Adelphi, Milano, 1980.
— Toop D., Ocean of Sound, 1995, trad. it. Oceano di suono, Costa&Nolan, Ancona-Milano, 1999.
:: ascolti ::
The Necks:
— Townsville, ReR, 2007.
— Chemist, ReR, 2006.
— Hanging Gardens, Fish Of Milk, 1999 – ReR 2001.
— The Boys, Fish Of Milk, 1998 – ReR 2004.
— Drive By, ReR, 2003.
— Aether, Fish Of Milk, 2001 – ReR, 2002.
Tutti i dischi indicati sono distribuiti da Goodfellas.