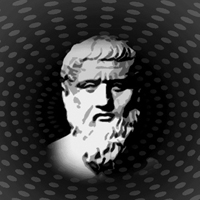 Cosa hanno in comune un antropologo americano di origini ispaniche e uno sciamano erede dell’antica
Sapienza degli stregoni toltechi ed un tecnomistico1, critico della
cultura dei media e della tecnologia? Molto, se si tratta
rispettivamente di Carlos Castaneda e di Erik Davis2. Chiunque li
conosca bene non farà fatica ad individuare gli elementi comuni, a
condizione, però, di non ignorare “il mondo della conoscenza”.
Attualmente il termine conoscenza è costantemente utilizzato
nel linguaggio comune, brulica di significati e di molteplici
accezioni: istruzione, informazione, sapere, cultura, cognizione,
familiarità. In passato essa veniva utilizzata solo di rado; per
riferirsi al sapere nella sua accezione più ampia si adoperava la sua
derivazione greca: gnosis. Un sistema gnostico è un sistema
caratterizzato anzitutto dal primato della conoscenza su qualsiasi
altro mezzo di salvezza, un primato riscontrato in tutte le epoche ed
in tutte le culture. Ci fu gnosis nell’antico Egitto, in Grecia, a
Roma, in Persia, in Cina, in Messico. È opinione condivisa che gli
uomini siano per natura protesi alla conoscenza. Ciò è confermato dalla
dicitura sul frontespizio del tempio di Delfi: “Uomo conosci te stesso
e conoscerai l’Universo e gli Dei che in essi dimorano”. E ancor più
dall’ingente pila di scritti filosofici e metafisici che trattano la
questione. In particolar modo è con Platone che la questione della
conoscenza si allontana dal gergo dei miti e dei simboli superando così
la visione degli orfici e dei pitagorici, derivata dall’arcaica
tradizione sciamanica della Scizia e della Tracia. Ed è infatti proprio
in Platone che si riscontra maggiormente uno dei concetti-base che
guidano il pensiero davisiano; non è un caso che Davis gli dedichi
alcune pagine del suo testo Techgnosis. Cosa hanno in comune un antropologo americano di origini ispaniche e uno sciamano erede dell’antica
Sapienza degli stregoni toltechi ed un tecnomistico1, critico della
cultura dei media e della tecnologia? Molto, se si tratta
rispettivamente di Carlos Castaneda e di Erik Davis2. Chiunque li
conosca bene non farà fatica ad individuare gli elementi comuni, a
condizione, però, di non ignorare “il mondo della conoscenza”.
Attualmente il termine conoscenza è costantemente utilizzato
nel linguaggio comune, brulica di significati e di molteplici
accezioni: istruzione, informazione, sapere, cultura, cognizione,
familiarità. In passato essa veniva utilizzata solo di rado; per
riferirsi al sapere nella sua accezione più ampia si adoperava la sua
derivazione greca: gnosis. Un sistema gnostico è un sistema
caratterizzato anzitutto dal primato della conoscenza su qualsiasi
altro mezzo di salvezza, un primato riscontrato in tutte le epoche ed
in tutte le culture. Ci fu gnosis nell’antico Egitto, in Grecia, a
Roma, in Persia, in Cina, in Messico. È opinione condivisa che gli
uomini siano per natura protesi alla conoscenza. Ciò è confermato dalla
dicitura sul frontespizio del tempio di Delfi: “Uomo conosci te stesso
e conoscerai l’Universo e gli Dei che in essi dimorano”. E ancor più
dall’ingente pila di scritti filosofici e metafisici che trattano la
questione. In particolar modo è con Platone che la questione della
conoscenza si allontana dal gergo dei miti e dei simboli superando così
la visione degli orfici e dei pitagorici, derivata dall’arcaica
tradizione sciamanica della Scizia e della Tracia. Ed è infatti proprio
in Platone che si riscontra maggiormente uno dei concetti-base che
guidano il pensiero davisiano; non è un caso che Davis gli dedichi
alcune pagine del suo testo Techgnosis.
“Platone ha dato all’idea un fondamento cosmologico e metafisico,
sposandolo così con il suo più ampio progetto razionalistico. Infatti
la simultanea accettazione platonica di misticismo e pensiero razionale
sottolinea uno dei sospetti che guidano questo libro: che i prodotti della ragione non possono essere tanto facilmente separati da ricerche ultraterrene… Platone chiama psichè la
sua anima intelligibile. Per Platone, il pianeta Terra è la polverosa
base di una ascesa cosmologica a più piani. Nell’attico residenziale
risiedono le forme pure, ed è qui che le nostre anime razionali sono
nate. Quando però scendiamo al piano inferiore, queste essenze
immortali sono sommerse nelle indolenti sacche di fluidi e ossa che ci
trasciniamo per il pianeta3.”
La polarità sottesa alle dinamiche del tecnomisticismo davisiano,
così come anche a quelle dello sciamanesimo castanediano, è quindi una
sorta di dualismo spirito(anima)/materia(corpo) in cui l’esperienza
sensoriale raggiunge i massimi livelli; la conoscenza non è
raggiungibile nel regno del male, non è presente nel nostro mondo
materiale, ma s’innalza ad una dimensione suprema, verso un mondo non
visibile all’occhio superficiale moderno imprigionato dalla
materia/corpo: il mondo della “Gnosi”.
L’aspirazione alla Gnosi nasce dalla consapevolezza della natura ingannatrice della realtà apparente. Negli Insegnamenti di Don Juan4, Don Juan Matus5, potente sciamano tolteco afferma: “Gli occhi di un uomo possono svolgere due funzioni: vedere
l’energia e guardare le cose di questo mondo; guardare solo è una
rinuncia disonorevole”.
Lo sciamanesimo ed il tecnomisticismo mirano a
dare una spiegazione, non sempre plausibile, alla questione ed
all’interrogativo:il mondo che percepiamo è l’unico reale e possibile?
La risposta è negativa per entrambi. Secondo lo sciamanesimo tolteco il
mondo è il prodotto di un consenso sociale, di un trucco; è più
complesso di quanto siamo disposti ad ammettere di solito. Risulta
evidente che una simile constatazione non è chissà quanto lontana
dagli studi sociologici. Il punto di vista dello sciamanesimo non fa
altro che riprendere e confermare la visione di ciò che è definita
“sociologia della conoscenza” ed in particolar modo quanto sostenuto
dagli studi di Peter Berger e di Thomas Luckmann. Nell’opera La realtà come costruzione sociale6 i
due autori si occupano delle modalità con cui costruiamo la nostra
conoscenza della realtà, intendendo per realtà tutti i fenomeni che
consideriamo indipendenti dalla nostra volontà prescindendo dalla
questione della validità o meno di questa conoscenza. La nostra
coscienza, affermano, è sempre coscienza di qualcosa. Gli oggetti si
presentano alla coscienza come appartenenti a diverse sfere di realtà.
Tra queste sfere di realtà ve n’è una che ha un ruolo dominante: la
realtà quotidiana, che la coscienza percepisce come una realtà
ordinata, preesistente, intersoggettiva. Ciò deriva dal fatto che il
processo di socializzazione, quando funziona, ci convince che le
interpretazioni della realtà che noi condividiamo sono anche i suoi
confini. Analogamente, ciò che noi chiamiamo normale percezione, è in
realtà per lo sciamanesimo tolteco, solo frutto di una convenzione
sociale, ovvero di una descrizione del tutto arbitraria che può essere
smantellata da altre forme di percezione parimenti reali ed oggettive.
La natura, per lo sciamanesimo, non è quindi come appare, è dominata
da spiriti, il cui mondo è percepito quale dimensione tanto reale,
unica ed assoluta quanto il nostro mondo profano di ogni giorno. Scopo
dello sciamano è quindi accedere ad essa attraverso la manipolazione
della percezione. Allo stesso modo il tecnomisticismo davisiano ritiene
che il mondo sia interamente dominato dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Al mito della macchina7, nato a
seguito della rivoluzione industriale e del processo di
secolarizzazione, fondato sul valore dell’efficienza, del controllo,
dello sviluppo tecnologico sfrenato, si sostituisce ciò che Davis
definisce il “mito dell’informazione”, dei cervelli elettronici, delle
previsioni computerizzate, delle biblioteche ipertestuali, di una
cultura planetaria che ci avvolge con le sue reti di telecomunicazione
globale. Davis definisce le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione ibridi tecnoculturali :da una parte sono creazioni
artificiali in quanto meccanismi materiali concepiti, costruiti ed
utilizzati a scopo di lucro; dall’altra sono animate da qualcosa che
non ha nulla a che fare con la materia e la tecnica, trascendono il
loro status materiale poiché permettono la codifica e la trasmissione
immateriale del pensiero e del significato.
Le tecnologie, secondo il pensiero davisiano, nonostante siano gli
strumenti più razionali costruiti dall’uomo, devono dividere la scena
cosmica con ogni sorta di dei, stregoni e spiriti animisti, sono
intrise di sacralizzazione, sono tecnologie del sacro.
Il patrimonio mistico, diversamente da ciò che affermano gli storici
ed i sociologi, non si è frantumato con l’avvento della società
moderna, ma i vecchi fantasmi e desideri metafisici, in molti casi, si
sono camuffati ed hanno proceduto sottoterra scavandosi la loro strada,
come lombrichi, nei moventi culturali, psicologici e metodologici che
stanno alla base del mondo moderno.
Per molti un accostamento simile tra due scrittori apparentemente
così diversi, potrebbe apparire avventato. È evidente che negli scritti
di Castaneda non vi è traccia degli impulsi tecnomistici e del dominio
dei robot e della cibernetica che dominano la realtà americana
descritta da Davis. Allo stesso modo non è possibile negare che in Techgnosis
è del tutto assente l’accurata e dettagliata descrizione, presente
invece nei diversi scritti di Castaneda, dei rituali sciamanici e dei
loro effetti sulle percezioni sensoriali e sulla nozione del tempo.
Nonostante ciò, tali differenze risultano irrilevanti se ci si
concentra sull’unica soluzione a cui lo sciamanesimo ed il
tecnomisticismo attingono, sull’unica speranza di salvezza dell’anima a
cui entrambi aspirano: la Gnosi, la poesia della conoscenza, l’eterna
primavera mistica, la rosa della filosofia. Secondo gli uni e gli
altri, raggiungerla non è semplice, infiniti sono gli ostacoli e le
incertezze durante l’oscuro e incerto cammino.
Don Juan ci mette in guardia: “Un uomo di sapere è colui che ha
affrontato tutte le difficoltà che comporta la conoscenza: la paura,
la chiarezza, il potere, la vecchiaia.
Un
uomo va alla conoscenza come va in battaglia, con gli occhi aperti, con
paura, con rispetto, con assoluta fiducia…8”
::
note ::
1. Il termine techgnosis/tecnomisticismo è stato coniato da Erik Davis che, in un articolo del 1994
e poi nel libro Techgnosis Miti,magia e misticismo nell’era dell’informazione (Ipermedium, S.Maria C.V., 2001) del 1998,
è stato il primo ad analizzare questa peculiare tendenza spirituale.
2. Cfr. A colloquio con lo sciamano Erik Davis, http:quadernisf.altervista.org/numero7/indexsf.htm.
3. Cfr. E. Davis, cit., pag. 47.
4. C. Castaneda, Gli insegnamenti di Don Juan, Rizzoli, Milano, 1999, pag. 323.
5. Vecchio indiano Yaqui, studioso, uomo di conoscenza, incontrato da
Castaneda nel 1960
in una stazione d’autobus della Greyhound, al
confine tra l’Arizona ed il deserto di Sonora.
6. Peter L.Berger Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1997.
7. Lewis Mumford, Il mito della macchina, Il Saggiatore, Milano, 1969.
8. Cfr. Castaneda, cit., pagg. 113-119.
|

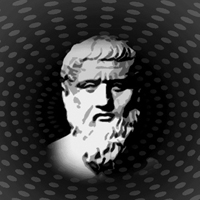 Cosa hanno in comune un antropologo americano di origini ispaniche e uno sciamano erede dell’antica
Sapienza degli stregoni toltechi ed un tecnomistico
Cosa hanno in comune un antropologo americano di origini ispaniche e uno sciamano erede dell’antica
Sapienza degli stregoni toltechi ed un tecnomistico