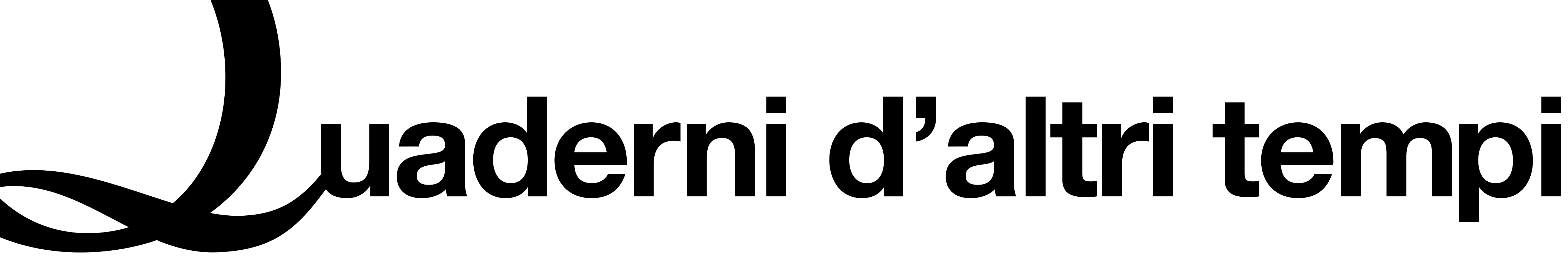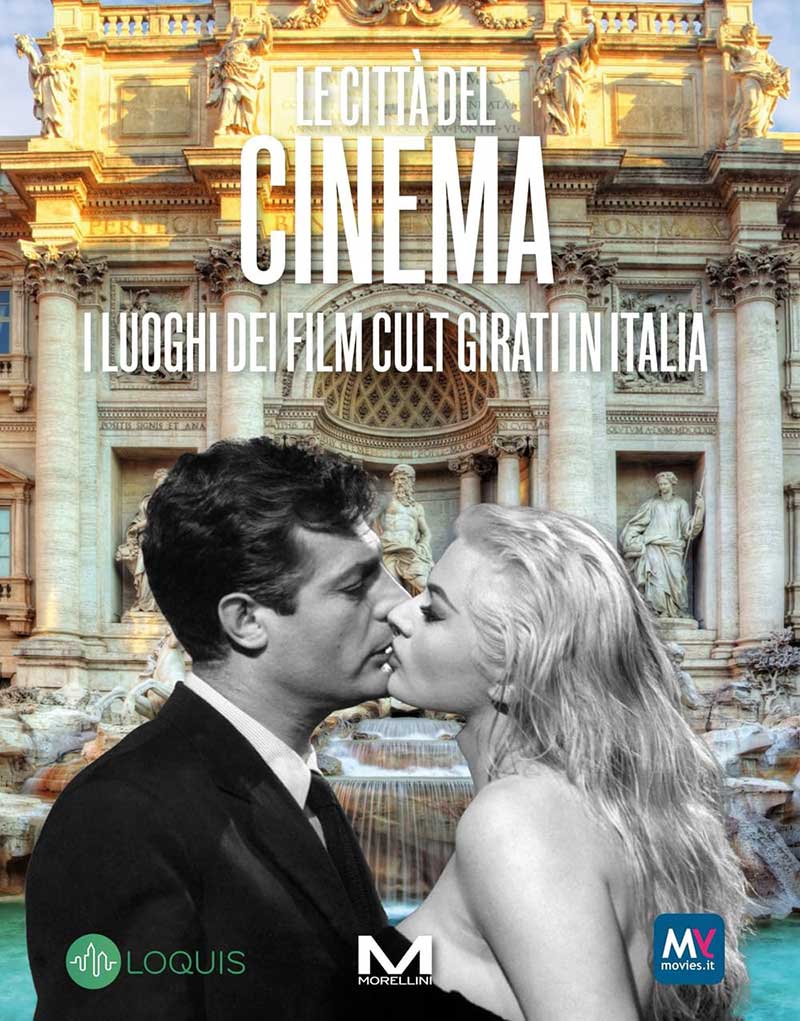Nella bella monografia Le città del cinema. I luoghi dei film cult girati in Italia, che cita duecentotrenta film fra Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e la Sardegna, il team di team di giornalisti di MYmovies non ha la pretesa di essere esaustivo. Non è il primo libro che racconta il legame indissolubile tra cinema e ambientazione urbana: per esempio Giorgia Zabbini, nella guida turistica dedicata a Bologna, ha contato oltre cento pellicole girate nel capoluogo emiliano, e oltre alle città menzionate ne Le città del cinema, ci sono mille altri luoghi entrati nel nostro immaginario grazie al cinema, dalla Ravenna industriale di Deserto Rosso (Michelangelo Antonioni, 1964) alla Castellabate di Benvenuti al Sud (Luca Miniero, 2010). Come si precisa nella guida, l’obiettivo non è quello di preparare un’enciclopedia, ma di
“giocare con il lettore, sposando la grande competenza dei giornalisti di MYmovies, il più grande e prestigioso portale di cinema, con un ricco apparato iconografico, spunti di visita, estensioni digitali per collegarsi subito ai video dei trailer o delle scene clou dei film citati. Un apparato multimediale che viene ulteriormente impreziosito dai contenuti audio del canale cinema di Loquis, la piattaforma di distribuzione dei contenuti turistica e culturali”.
Quando si parla di cinema e ambientazioni urbane e geografiche, le prime città italiane che vengono in mente allo spettatore medio sono Roma e Milano. E non è un caso vista la quantità di film che hanno come quinte proprio i paesaggi urbani di questi due centri-fucina (cuori pulsanti, per usare un’espressione comune e quasi automatica nei mass media) per la cultura, l’economia e la politica italiana. Città che non di rado spiccano già nei titoli: fra gli esempi più famosi/iconici, Vacanze romane (1953) con il famoso giro in Vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn. E si può immaginare La dolce vita (1960) senza lo scenario monumentale e urbano della Roma di via Veneto e della Fontana di Trevi? Più di quarant’anni anni dopo, Paolo Sorrentino ha filmato la Roma bene ne La grande bellezza (2013), passando dal Fontanone a via Bissolati, dal Colosseo –visibile dalla casa di Jep Gambardella (Toni Servillo) – a Villa Medici, sede dell’ambasciata francese, dal Museo nazionale etrusco fino al Salone delle Fontane del Palazzo Uffici all’Eur.
Roma è ovviamente protagonista del cinema italiano già dal dopoguerra (Roma città aperta di Roberto Rossellini, 1945). Si va da Bellissima di Luchino Visconti (1951), in cui Anna Magnani vuol avviare alla carriera del cinema la figlia e viene irretita nei dintorni di Cinecittà dal faccendiere interpretato da Walter Chiari a Guardie e ladri di Monicelli e Steno (1951) dove, durante l’inseguimento fra la guardia interpretata da Aldo Fabrizi e il ladro impersonato da Totò, si riconoscono fra le tante, via del Tritone, via Due Macelli e piazza delle Cinque Scole. L’incidente avvenuto in largo Circense, che provocò la morte di un gruppo di operaie narrato in Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952), è in realtà avvenuto in via Savoia, nel quartiere Salario-Trieste. Si svolge fra il centro storico con vista sul Colosseo e i Fori Imperiali e il Ghetto Un americano a Roma di Steno (1954) con Nando Mericoni-Alberto Sordi, mentre ne Il Conte Max (1957, regia di Giorgio Bianchi) un nobile decaduto e scroccone, il conte Max Orsini Varaldo (Vittorio De Sica) incontra il giornalaio Alberto Boccetti (Alberto Sordi) all’edicola tra via Veneto e via Ludovisi. Ma c’è anche la Roma suburbana e sottoproletaria inquadrata dalla cinepresa di Pierpaolo Pasolini: l’Accattone (1961) si aggira per il Pigneto, allora periferia della Capitale, oggi quartiere boho-chic. A sua volta, Mamma Roma (1962) si svolge in zone ora riqualificate come Casal Bertone e il Tuscolano dove si trova il Boomerang, l’abitazione della prostituta interpretata da Anna Magnani.
 I fratelli Capone alla “scoperta” di Milano in Totò, Peppina e la malafemmina (1956).
I fratelli Capone alla “scoperta” di Milano in Totò, Peppina e la malafemmina (1956).
Salendo dall’Eterna al nebbioso (un tempo) capoluogo lombardo, Vittorio De Sica in Miracolo a Milano gira una scena fondamentale davanti al Teatro del Piermarini (la Scala), quando un barbone ruba la borsa a Totò il buono che poi segue il ladro fino alle baracche di Lambrate: tre simboli di Milano, la Scala, il Duomo (visto dall’alto dai netturbini che nella scena finale volano sui manici di scopa) e le baracche di periferia. Proprio in Piazza Duomo si svolge la celeberrima scena con i fratelli Capone (Totò e Peppino De Filippo) alle prese con il ghisa a cui domandano – totalmente ignari del luogo in cui si trovano – “noio volevons savoir l’indiriss”. Siamo in Totò, Peppino e la malafemmina (Camillo Mastrocinque, 1956) e Milano assurge a simbolo di un Nord che appare ai due campagnoli provenienti dal Sud così lontano nella sua modernità da sembrare un altro mondo, sconosciuto e temibile. In L’audace colpo dei soliti ignoti (Nanni Loy, 1959), la sgangherata ma simpatica banda di ladri capitanata da Peppe er Pantera (Vittorio Gassman) si trasferisce da Roma a Milano grazie all’intermediazione di un ladro che cerca collaboratori non milanesi (e quindi ignoti alle forze dell’ordine) per un colpo al Totocalcio. E qui non c’è solo la Milano del Duomo e di vie (allora) più periferiche come Ferrante Aporti, ma la contrapposizione di due mondi e visioni della vita diverse se non opposte: la pratica Milano versus la Roma filosofica e teorica; la Roma un po’ pigra e balorda contro la Milano efficiente e lavorativa, la Milano dei ragiunatt e dei cumenda. Memorabile la lezione di dialetto milanese che la deliziosa ballerina interpretata da Vicky Ludovisi impartisce a un Gassman che non riesce a pronunciare la u (ö) lombardo-meneghina: “in alto le mani, möves”. Anche nella commedia anni Settanta-Ottanta, pellicole come Il ragazzo di campagna (Castellano e Pipolo, 1984) o Un povero ricco (Pasquale Festa Campanile,1983) hanno come sfondo, tutt’altro che indistinto, vie e scorci tipici della Milano anni Ottanta, dal centro storico ai Navigli: ne Il ragazzo di campagna, Artemio (Renato Pozzetto) guida con nonchalance il trattore ingombrando un corso Vittorio Emanuele, oggi tutto pedonale, allora zeppo di auto in marcia e parcheggiate ai lati; poi si vedono insegne a quel tempo famosissime, oggi scomparse, come i Supermercati Brianzoli (SB) o i grandi magazzini La Standa di piazza Cairoli ne Il povero ricco. Anche questi aspetti rendono molti film italiani testimonianze storiche, simboli di un’epoca mai vista dagli spettatori contemporanei più giovani, dagli Zedder agli Alpha.
 A Roma con Jep Gambardella (interpretato da Toni Servillo) in La grande bellezza (2013).
A Roma con Jep Gambardella (interpretato da Toni Servillo) in La grande bellezza (2013).
In un film come Bianco, rosso e Verdone (1981) si rivede una Roma con alcune attrazioni ormai inconcepibili come lo zoo. Per non parlare dei giri o delle corse in auto per le vie e i viali di Roma e Milano; bastano due esempi, Ieri oggi e domani (Vittorio De Sica, 1963) con l’episodio centrale (Mara-Sophia Loren che in Rolls Royce attraversa mezza Milano, da Piazza della Scala fino al Ponte della Ghisolfa e via lungo il ponte che porta all’imbocco delle autostrade nord), e Il sorpasso di Dino Risi dove la Lancia Aurelia guidata da Vittorio Gassman sfreccia in una Roma deserta (siamo a Ferragosto del 1962). Ma si può dire che quasi tutto il cinema nostrano, dal neorealismo alla grande commedia all’italiana fino ai più recenti film di Aldo, Giovanni e Giacomo, sia molto legato all’ambientazione urbana; anche quando i film non sono espliciti o indiretti omaggi a determinate città – come la New York di Woody Allen o, sempre di Allen, la Parigi di Midnight in Paris e quella anni Cinquanta che vediamo ne I 400 colpi di François Truffaut – si può immaginare La dolce vita senza pensare ad Anita Ekberg che invita Marcello Mastroianni a immergersi nella Fontana di Trevi? Sì, propria quella che Totò cercherà di vendere allo sprovveduto Decio Cavallo, l’italoamericano rientrato in Italia alla ricerca di un “buon bisnìss”. Non a caso la scena si è aggiudicata la copertina del libro. Si possono concepire Amarcord (Federico Fellini, 1973) senza pensare a Rimini e alla Romagna, o I giardini dei Finzi Contini (De Sica, 1970) fuori da Ferrara? E La donna del fiume (1954) di Mario Soldati, con Sophia Loren, operaia in uno stabilimento per la coltura e la lavorazione delle anguille, non poteva essere girata se non a Comacchio.
Da Firenze a Torino
A Firenze è ambientato Camera con vista (1986), il film di James Ivory, tratto dal romanzo pubblicato nel 1908 da E.M. Forster, che a quasi quarant’anni dall’uscita sul grande schermo rimane il più noto ritratto straniero della città di Dante. A Firenze sono stati girati Hannibal di Ridley Scott (2001) e Inferno di Ron Howard ispirato al romanzo di Dan Brown (2016), ma quando dici Firenze chissà perché non pensi subito a Le ragazze di San Frediano (1954) di Valerio Zurlini o a Cronaca familiare (1962), ispirati ai romanzi di Vasco Pratolini. Come scrive Roberto Manassero, uno dei curatori del volume:
“Dici Firenze al cinema e pensi subito ad Amici miei. Le bischerate condite da supercazzole del conte Mascetti, dell’architetto Melandri, del giornalista Perozzi, del barista Necchi e del medico Sassaroli (cioè Ugo Tognazzi, Gaetano Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Prete, Adolfo Celi), abbracciano l’intera città; citiamo quattro luoghi: la stazione Santa Maria Novella degli schiaffoni ai passeggeri in partenza; il bar Necchi di via dei Renai 17, oggi chiuso (ma a fianco c’è il Supercazzola Store); il cimitero di San Miniato dove Sassaroli fa credere a un vedovo di essere stato l’amante della moglie defunta; il Museo Archeologico da dove inizia la passeggiata del Mascetti e della Titti”.
Torino è l’altra grande metropoli industriale del Nord, che si presta non meno di Milano ad essere cornice metropolitana di film dalla forte impronta operaia. Nella città della Mole Antonelliana – oggi sede del Museo del Cinema – è ambientato Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) di Lina Wertmüller. Nel famoso Mercato di Porta Palazzo, Mimì (Giancarlo Giannini) incontra Mariangela Melato ed è subito amore proletario. Mimì infelicemente sposato con Rosalia, è un povero diavolo che si ritrova senza lavoro dopo aver votato un candidato comunista. Segnalato alla Mafia e costretto all’esilio, sbarca il lunario a Torino: finirà per fare carriera e realizzare tutto quello contro cui combatteva. Marzia Gandolfi, altra curatrice del volume, annota:
“Lo sfaldamento dei rapporti umani è dietro l’angolo e in una promenade solitaria nel parco del Valentino, Mimì incarna la solitudine del migrante inurbato e perduto nella nebbia del quartiere Mirafiori, la dimensione estranea delle periferie e della lotta nelle fabbriche”.
A Torino è ambientato anche il romanzo giallo di Fruttero&Lucentini, La Donna della domenica, pubblicato nel 1972. Il film diretto da Luigi Comencini è del 1975 e vede fra i protagonisti Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset, Jean Louis Trintignant, Lina Volonghi, Aldo Reggiani e Pino Caruso. A Torino un noto architetto viene trovato assassinato nel suo appartamento, il cranio sfondato da un fallo di marmo. Il commissario Santamaria (Marcello Mastroianni) e il collega De Palma (Pino Caruso) indagano. Anna Carla Dosio (Jacqueline Bisset), una borghese dell’alta società, e il suo amico Massimo Campi (Trintignant), omosessuale segretamente legato alla vittima, sembrano coinvolti nel caso. Un film che restituisce l’atmosfera di una Torino sospesa tra mistero e dura realtà metropolitana, l’opposizione di classi sociali in una città che prosperava con la Fiat e incontrava ricchi e poveri al Balon, il famoso mercato delle pulci di Porta Palazzo che si sviluppa tra le vie Borgo Dora, Lanino, Mameli e Canale Morassi. La carrellata non termina qui e il volume consente di rivedere alcune scene chiave, contenuti filmati collegati al libro grazie a Extended Book tramite QR code.