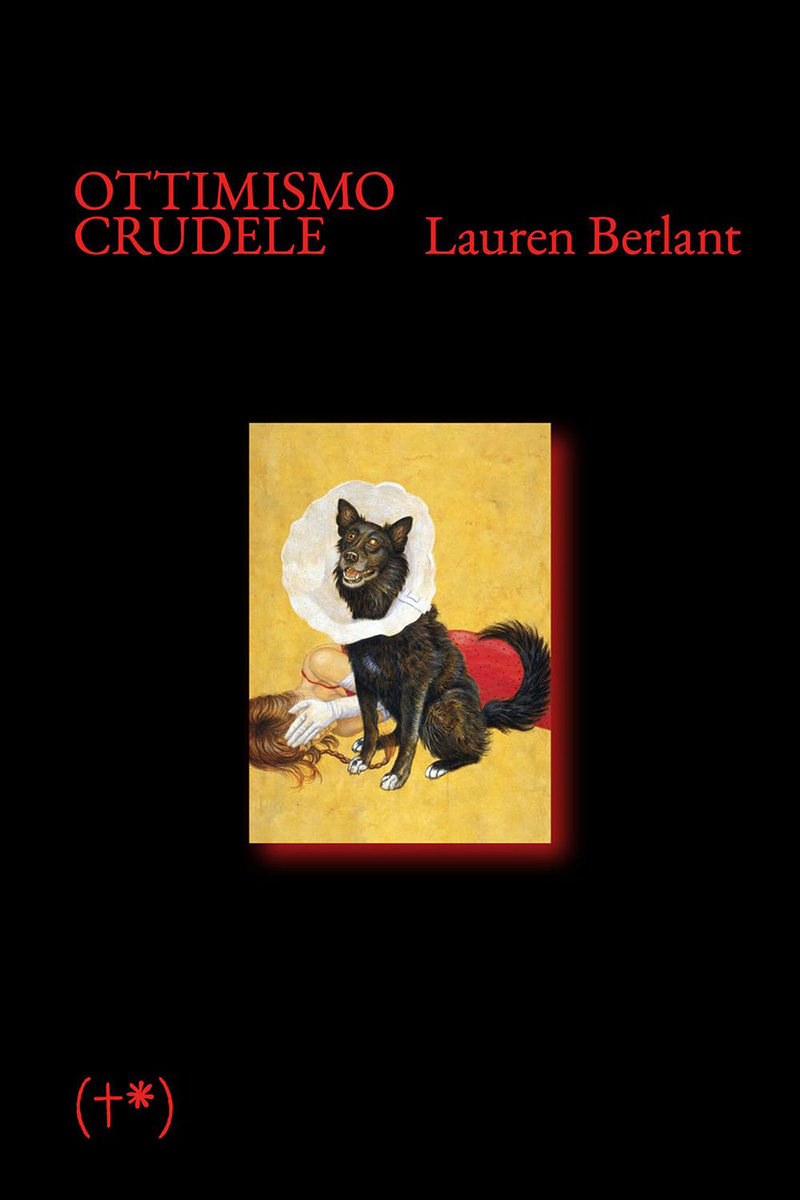“La recita è la performance di un’interruzione senza rischio”, così Lauren Berlant individua il concetto di Ottimismo crudele, nell’esplicitarsi dell’improvvisazione ordinaria, in termini estetici, delle fantasie di adattamento al quotidiano. Quel sollievo operato dall’abitudine alla riproduzione della vita, o meglio la buona vita, fantasia di sostentamento originariamente garantita dalla logica capitalista che rende ancor oggi palpabile, in un presente dove la politica non è più vissuta come azione ma consuetudine, un’ambiente collettivo, perché tendente a “spiegazioni che hanno un senso, quel senso di soddisfazione che permette la sopportazione”.
Si tratta della reiterazione di tutti quei comportamenti sociali alimentati dall’ideale di meritocrazia, intesa come soluzione per fuggire dalla precarietà economica dilagante, ignorando con ciò l’obiettività del divario di possibilità e risorse fornite dal capitale. La promozione del successo individuale come risultato della perseveranza allontana ogni barriera sistemica, discriminazioni razziali, povertà, disuguaglianze. Così l’individuo contemporaneo, nella convinzione di poter auspicare a un futuro migliore, finisce invece con l’illudersi di un crudele ottimismo, metafora di una più drammatica e radicata morte lenta nell’impasse del presente. Grazie alla recente pubblicazione in versione italiana, l’influenza del pensiero di Lauren Berlant può ora estinguere il debito dei quattordici anni dalla sua prima edizione. È nella critica, nel cinema e nella letteratura contemporanea che l’autrice individua i comportamenti più comuni messi in atto dall’uomo per la propria sopravvivenza, in una generalizzazione che vuole includere ogni variante di classe, etnia, età e genere, di modo che l’unico fattore in comune che possano avere i modelli presi in considerazione non sia altro che la condivisione dello stesso tempo, il presente. Nell’analizzare, per esempio, alcuni casi del nuovo realismo nel cinema francese degli anni Novanta (i lavori dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, per esempio), Berlant identifica i temi di fragilità e adattamento alla solitudine nella singolarità collettiva contemporanea, definendo il passaggio della precarietà da struttura limitata ad ambiente di vita dilagante, con l’emergere di varie forme di paralisi vivente riconducibili a un’ultima disperata possibilità di espressività nel sociale. Un’estetica minimalista e l’uso di ambientazioni spoglie riflettono ulteriormente la desolazione e l’instabilità delle condizioni di vita degli individui, le situazioni di stallo vengono invece rappresentate attraverso narrazioni frammentate e ritmi lenti, ad enfatizzare la monotonia e ripetitività dei momenti ordinari.
Il campo dell’affect theory in cui si muove Berlant, presuppone che l’affetto emerga sempre come sentimento politico e politicizzante, che il capitalismo si espanda a livello del desiderio, rendendone quindi possibile quel formalismo ottimistico dell’attaccamento abitudinario, in quanto “la sua attività satura le performance corporee, intime e politiche di adattamento che rendono palpabile un’atmosfera condivisa”. La concettualizzazione dell’affettività aiuta a chiarire le caotiche dinamiche di auto-continuità e riproduzione della vita nel momento in cui, sommata al contesto di relazioni storico culturali, si dimostra in grado di determinarne l’importanza, la portata dell’evento.
“Affetto, nella sua forma più antropomorfica, è il nome che diamo a quelle forze – forze viscerali sottostanti, accanto o generalmente diverse dalla conoscenza cosciente, forze vitali che insistono oltre l’emozione – che possono servire a spingerci verso il movimento, verso il pensiero e l’estensione, che possono allo stesso modo sospenderci (come se fossimo in folle) attraverso un accumulo appena percettibile di relazioni di forza, o che possono persino lasciarci sopraffatti dall’apparente intrattabilità del mondo”.
(Seigworth, Gregg, 2010. Trad. dell’autrice, ndr).
Partendo quindi dal presupposto che ogni affetto sia ottimista se, come afferma Berlant, “consideriamo l’ottimismo come la forza che ci spinge a uscire da noi stessi e a entrare nel mondo per avvicinarci a quel qualcosa di soddisfacente che non siamo in grado di creare da soli”, la crudeltà emerge nel momento in cui la struttura del sentimento si cristallizza attorno alle speranze riposte in un futuro la cui esistenza non potrebbe mai prendere materialmente forma; eppure la si continua a pretendere, chiamandola normatività promessa. Se la crisi finanziaria e la conseguente imposizione di politiche di austerità nella gran parte dei paesi occidentali hanno da un lato accentuato quella percezione di precarietà e insicurezza, ciò ha inevitabilmente condotto al rafforzamento dell’idea di autogestione individuale, poiché nel momento in cui il successo diviene l’unico obiettivo di vita, non ne può derivare altro che un’alienazione dall’atto politico, quindi dalla comunità stessa. In questa forma di presente storico i cui limiti rimangono indefiniti, il domani non arriva mai, e nella temporalità dell’oggi si sviluppano le più varie manifestazioni di una sopravvivenza amaramente auspicata come fase transitoria, due termini ne conducono il filo: cecità ed esercizio. Cecità di fronte alla reiterazione dell’ordinario, all’assunzione dell’attaccamento emotivo alle promesse politiche come sostituto di ogni relazione sociale, dove l’identità non è più condivisa ma soffocata in un tentativo di autoconservazione propriocettiva. Limitare quello stato d’ansia generalizzato di fronte all’inevitabilità di un futuro incerto, si pone fatalmente come resistenza a ogni forma di cambiamento. Ecco che la quotidianità della crisi emerge nella forma singolare di esercizio, “allenamento dei sensi per costruire mondi possibili e belli a partire da mondi impossibili” lo chiama l’autrice, atto volto quindi a mantenere il controllo della situazione.
L’ottimismo crudele è l’esercizio della consuetudine, dell’autodisciplina, di chi si concede di sopravvivere nell’unico modo in cui quest’epoca permette di evitare il rischio della sopraffazione: la stasi. Ecco che quando Berlant parla dell’impatto dell’affettività politica sulla dilagante precarietà contemporanea, oggi estesa in maniera trasversale a ogni classe sociale, dalla vita pubblica ai più stretti legami familiari, afferma:
“L’unica membrana […] tra la perdita assoluta, psicotica, irrintracciabile e la vita immaginata è l’ottimismo delle buone maniere, della compostezza, un formalismo dell’essere che richiede il minimo di attenzione affettiva o di performance emotiva, che permette ai soggetti di tenere le cose per sé e che rappresenta la privatizzazione neoliberale di tutte le risorse in un linguaggio di emozioni private, il cui corpo è un contenitore per gli affetti del soggetto, mentre il volto aspira a restare in superficie”.
Non apatia quindi, ma rassegnazione alla consapevolezza di non poter fare nulla contro il sistema, la stessa impressione descritta da Mark Fisher nella sua definizione di Realismo capitalista,
“la sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema politico ed economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginarne un’alternativa coerente”.
(Fisher, 2018)
Una fantasia senza più appigli non può far altro che ripiegarsi su sé stessa, trasformandosi in trappola emotiva, perché questo processo di adattamento non è privo di sofferenze. Se Fisher percepisce però il capitalismo come l’inevitabile “fine della storia”, in grado di far scomparire la capacità di pensare a forme di socialità al di fuori di esso, Berlant è ancora in grado di giustificare la fantasia come impostazione possibile per la creazione di un nuovo mondo, ma solo a patto di assumere la vita come un processo del presente, che dimentichi ogni sorta di obiettivo finale per dedicarsi alla pura meditazione del qui e ora. Il testo apre, a concludere, il varco alla prospettiva di abolire la positività dell’ottimismo neoliberale, nell’ipotizzare uno spazio di transizione in cui continuare a mettersi in gioco reinventando nuovi linguaggi dell’appartenenza, e quindi del politico, perché possa avvenire una solidarietà libera.
Il pensiero prende vita nell’ottica della depressione anarchica di una serie di attivisti e artisti che pongono il gesto del silenzio come presupposto necessario a creare l’apertura per “un mondo sociale potenziale”. L’arte è quindi inclusa non solo come mezzo di critica ma vera e propria forma di resistenza che, tramite un’esperienza estetica, vuole evidenziare le potenzialità di questo presente, mantenendo in vita un’eticità civile che si opponga attivamente al rumore incessante del consumismo e dell’auto-realizzazione, ostacoli alla rappresentazione del discorso.

Rosetta (1999) scritto e diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne, film che ben esprime il nuovo realismo nel cinema francese degli anni Novanta.
Seguendo diversi modelli d’arte avanguardista statunitense, Berlant si focalizza sull’andamento dell’anti-drammaticità postmodernista, nell’emergere di una politica laterale basata sull’avversità riguardo a modalità irruente d’espressione. L’oggi viene completamente ridimensionato tramite una disidentificazione sensuale collettiva nel silenzio dell’attesa, della distrazione, dell’esitazione, ma non del rifiuto. Interruzione quindi a immagine del fallimento nel politico, ma che può a sua volta essere convertita in registri emotivi riflessivi, dov’è il punto di vista stesso a mancare volontariamente l’occasione di esprimersi, prendendo le distanze dal presente: non più sofferenza, nemmeno empatia, si tratta di osservare la vita senza aggiungerle alcuna intensità, perché “non c’è nessun movimento sociale nello sguardo estetico”. L’astensione dalla performance non è altro che una strategia per interrompere il flusso di quell’affettività crudele. Data la consapevolezza di non poter agire, nella necessità di cambiamento, è il sensorio stesso a rivolgersi alla potenzialità di una realtà differenziata. Si tratta, in sostanza, di una forma di dissociazione, ma non meno di interferenza: senza poter identificare una strada univoca per il cambiamento sociale, tanto meno assumere su di sé il potere di guidare la folla, questi artisti si limitano ad abbracciare l’ipotesi che possa esistere dell’altro, nel tentativo di riappropriarsi di una nuova concezione di comunità, in chiave emancipatoria.
L’autenticità, intesa come rinuncia di quel già precario senso d’appartenenza, è ciò che si dimostra allora, secondo Berlant, in grado di rendere l’arte autosufficiente nel reindirizzare il desiderio, criticizzando l’espressione singolare tramite “l’ascolto affettivo che plasma il senso di immediatezza in seno al pubblico intimo mass-mediato del presente storico”. Silenzio e stasi non sono sinonimi, né effetti della stessa reazione emotiva, perché il silenzio appartiene a coloro che scelgono di intromettersi nella tendenza, caotica psicosi di quell’immagine di bella vita. Quando Giorgio Agamben parla dell’onnivalenza dell’essere qualunque come carattere della “comunità che viene”, definisce un individuo che sfugge dall’appropriazione di un’identità, non per indifferenza verso il mondo, ma per poter “essere tale qual è” (Agamben, 2001). Rifiutare ogni forma di linguaggio per poter divenire la prima sillaba del proprio.
“L’essere che non resta sotto sé stesso, che non si presuppone a sé come un’essenza nascosta […] un tale essere non è accidentale né necessario, ma è, per cosi dire, continuamente generato dalla propria maniera”
(Agamben, 2001).
Incompatibile con un’etica che prescriva all’uomo di compiere una qualche essenza, una vocazione storica o spirituale, quest’individuo non dichiara appartenenza. Un concetto a cui anche Berlant aspira, dove la socialità è vista come uno spazio di potenziale liberazione e sperimentazione, distaccandosi quindi dalle strutture normative, senza aspettative di realizzazione concreta, ma fuori dalle logiche tradizionali di speranza. L’autrice promuove allora un’inclinazione ad agire, dove lo spettatore del capitalismo sia in grado di mantenersi nel campo del valore culturale, creativo, di un ottimismo non ancora crudele, fertile. La particolarità del metodo di Berlant dunque, nella convinzione della necessità di un “immaginario per articolare una nuova forma di reciprocità”, consiste nel considerare l’affettività come metro d’analisi per dimostrarne le potenzialità intrinseche nell’identificare le forme di adattamento al neo-capitalismo. L’ottimismo crudele emerge allora a sua volta come strumento teorico per individuare le angosce che abitano il presente. Un’analisi che non ricade sull’impronta lasciata, piuttosto sul procedimento: non si tratta solo di comprendere un fenomeno sociale, ma come ognuno lo incarni nella propria quotidianità, offrendo quindi uno spazio per l’autocoscienza critica che possa emergere in nuove forme di resistenza e liberazione. Rendendo quindi la contestualizzazione non automatica, ma di stampo individuale e riflessivo, la ricerca si pone come non più che un’ipotesi nell’individuazione di
“lavori che aprono diverse strade per distaccarsi dall’ottimismo crudele della politica della società civile, se non dal desiderio politico stesso”.
Perché soltanto abolendo la positività dell’ottimismo si potranno creare spazi sociali di emancipazione collettiva, nel momento in cui quelle aspettative di realizzazione si sostituiranno al continuo rigenerarsi della possibilità.
- Giorgio Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.
- Mark Fisher, Realismo capitalista, Produzioni Nero, Roma, 2018.
- Gregory J. Seigworth e Melissa Gregg (a cura di), The Affect Theory Reader, Duke University Press, 2010.