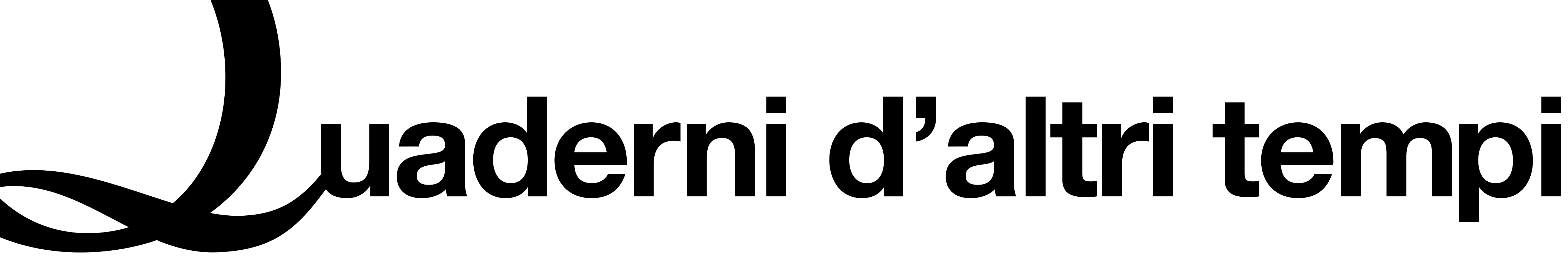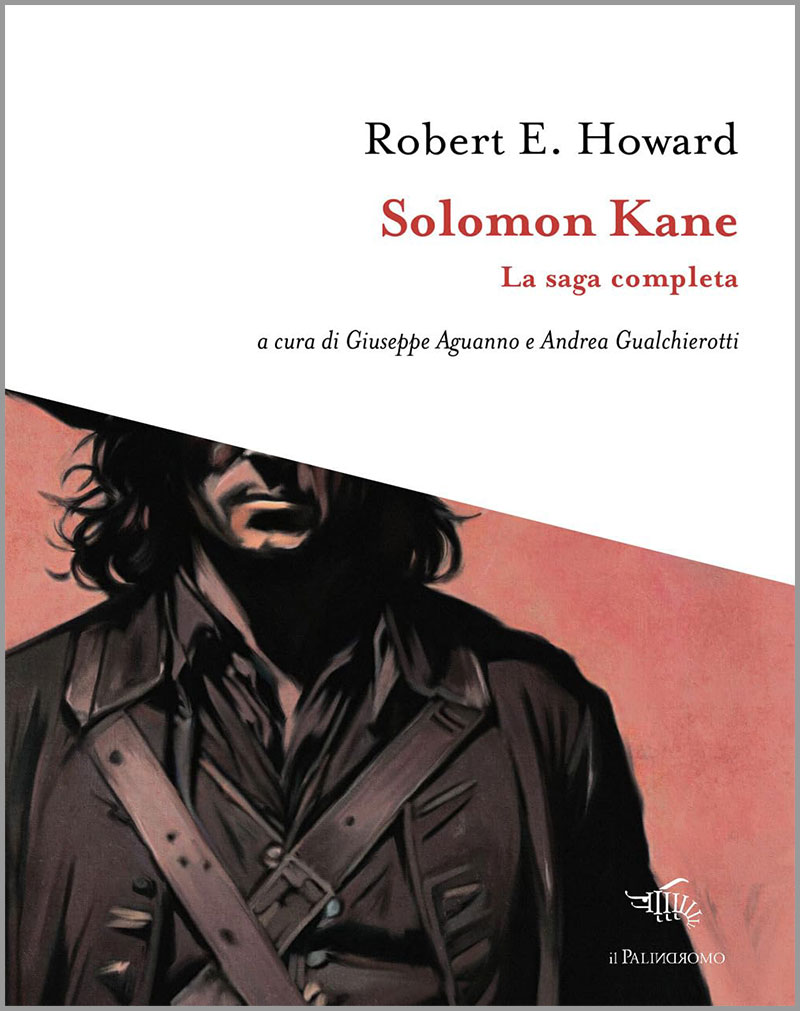Gli eroi ritornano. È un destino ineludibile. È una missione eterna, compiuta ciclicamente incurante del singolo episodio che volta per volta si svolge sotto i nostri occhi. Gli eroi ritornano e Solomon Kane non fa eccezione, pur essendo per natura sfuggente alla regola su cui si basano tutti gli eroi: incarnare il Bene che si oppone al Male. Solomon Kane, per certi versi antieroe, come si vedrà, nato dalla penna di Robert Ervin Howard, ritorna anche sul fronte editoriale, ripubblicato nella collana I tre sedili deserti dell’editore Il Palindromo. È una nuova voce che si aggiunge agli altri titoli di quella biblioteca dell’immaginario che il suo direttore, Giuseppe Aguanno, sta erigendo con dedizione e scrupolo sin dal 2017 quando la collana venne inaugurata dal romanzo di Arthur Machen, La collina dei sogni. Ritorna puntuale, va detto, la cura editoriale consueta per la collana de Il Palindromo anche nell’occasione con un apparato critico sostanzioso. Oltre ai sedici testi firmati di proprio pugno dallo scrittore texano, nove racconti completi, quattro non terminati e tre poesie, il volume include un saggio introduttivo di Pietro Guarriello, quello storico di Gianfranco de Turris che apparve nella prima edizione italiana del ciclo di Kane pubblicata da Fanucci nel 1979, un terzo contributo firmato da Andrea Gualchierotti, curatore del volume assieme ad Aguanno che a sua volta ha redatto una nota biografica di Howard. Non solo, tutti i testi howardiani sono commentati da Gualchierotti e arricchiti da illustrazioni che comparvero nelle edizioni originali su Weird Tales e integrati dalla Mappa dei luoghi nei quali si svolgono le avventure di Solomon Kane, che venne realizzata dall’illustratore Mauro Marchesani sempre per l’edizione Fanucci.
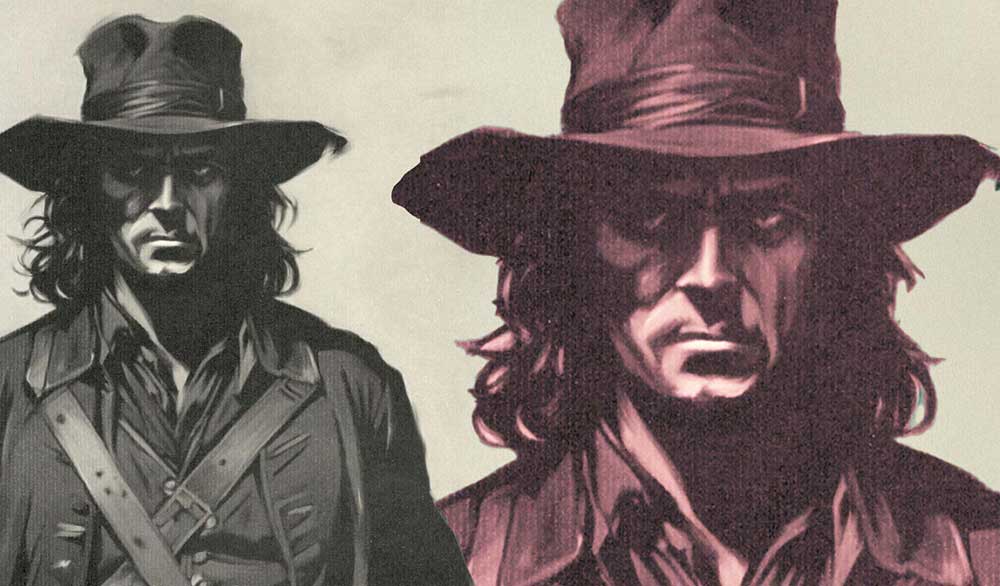 Illustrazione di Simone Geraci.
Illustrazione di Simone Geraci.
Armato di tutto punto anche dal punto di vista editoriale, dunque Solomon Kane ritorna, dopo essere stato protagonista di altre tre edizioni (Nord, poi Newton Compton e Coniglio Editore) tutte oggi fuori catalogo. Un trascorso editoriale che sommato alle varie reincarnazioni del personaggio nel cinema, nel fumetto, nei giochi di società, porta con sé una mole di riflessioni e appunti critici sul personaggio tali da rendere più che condivisibile la domanda che si pone Gualchierotti in apertura del suo saggio:
“C’è ancora qualcosa di nuovo da dire su Solomon Kane? Cosa si può analizzare ancora delle sue arcinote avventure, storie che hanno conosciuto riduzioni fumettistiche, cinematografiche, e i cui esordi sulle pagine del celebre «Weird Tales» risalgono ormai a quasi un secolo fa?”.
Che altro annotare, aggiungiamo noi, ora che questo volume offre ulteriori contributi d’analisi? Prima di azzardare qualsivoglia spunto d’analisi, sarà utile abbozzare un ritratto essenziale di Kane, noto sicuramente a molti ma in possesso di minor fama dell’eroe howardiano più famoso al mondo, ovvero Conan il Cimmero. Solomon Kane nacque nel 1928 con il racconto Ombre rosse pubblicato sulle pagine di Weird Tales nell’agosto di quell’anno ottenendo anche la copertina del numero. Nella cronologia delle sue gesta, ricostruita a posteriori, la storia funge da terzo capitolo della saga e lo vede non solo incrociarsi con un avversario duro a morire, un vilain noto come LeLoup, ma anche a spostarsi, per vendicare la morte di una innocente fanciulla, dalla Francia all’Africa, in terre selvagge confinanti con quelle tarzaniane di Edgar Rice Burroughs, già fortemente incise nell’immaginario collettivo e in parte prefiguranti il minaccioso, lo sconosciuto e altrettanto territorio perduto che si vedrà di lì a poco sul grande schermo: l’isola del Teschio, il regno di King Kong. Il lato oscuro dell’exotica che da sempre accompagna le fantasie sulle terre ignote. Niente che potesse impensierire il Puritano immaginato da Howard. Quando Kane fa il suo ingresso nei territori del fantastico viene descritto così:
“[…] vestito di nero da capo a piedi, con abiti semplici e aderenti che in qualche modo si accordavano al suo volto cupo. Le braccia slanciate e le spalle larghe restituivano l’idea dello spadaccino, confermata dal lungo stocco che impugnava. I lineamenti dell’uomo erano sprezzanti e tetri. Nella luce incerta, una sorta di torvo pallore gli donava un aspetto spettrale, effetto, questo, accresciuto dal diabolico cipiglio delle sue sopracciglia incurvate”.
Fu da allora che il ventiduenne Howard iniziò a far sul serio come scrittore di professione dopo aver scritto e pubblicato una manciata di racconti (di cui uno, Lancia e zanna, pubblicato sul celebre pulp magazine nel 1925). Scriverà circa cinquecento racconti, esplorando e rivisitando vari generi popolari, il western innanzitutto, la letteratura orrorifica non tralasciando nessuna delle figure che la popolano (lupi mannari, vampiri, fantasmi, stregoni), le storie del soprannaturale costruite sulla falsariga di quelle lovecraftiane, per non dire delle storie avventurose, di pirati, di cappa e spada, dei racconti polizieschi (d’azione e di investigazione), sportivi (pugilato) fantascientifici, fantastiche e finanche diversi di carattere romantico. Creerà soprattutto Conan il Cimmero, capace di oscurare il suo creatore e tutte le altre sue creature. Oltre ai racconti scrisse un numero imprecisato di poesie e due romanzi fino a quell’undici giugno del 1936 quando seppe che sua madre era entrata in coma. Era legato a lei in modo morboso e fu un colpo fatale. Si sedette alla scrivania e battè a macchina due versi della poesia The House of Cæsar di Viola Garvin, questi:
“All done, all fled, and now we faint and tire / The Feast is over and the lamps expire! (Tutto è andato, tutto è finito, ponetemi sul rogo / La festa è terminata e le lampade si estinguono)”.
Ciò fatto, salì in macchina e si diresse nel deserto. Alle otto di mattina, la fece finita puntandosi una pistola alla tempia e tirando il grilletto. Anni prima (1931) aveva detto a Farnsworth Wright, il direttore editoriale di Weird Tales “Ogni tanto uno di noi trova che la strada sia troppo difficile e si fa saltare le cervella, ma fa parte del gioco, credo” (Jones, 2024). Toccò a Howard Philip Lovecraft ricordarlo nel necrologio pubblicato da Fantasy Magazine nel settembre del 1936 con parole che esprimevano ammirazione (e dolore per la scomparsa) per uno scrittore che
“non eccelleva soltanto nel dipingere scene di lotta e di massacro, ma era pressochè unico nella capacità di creare vere emozioni di terrore spettrale e spaventosa suspense”
(Lovecraft, 2011).
Questo è stato Howard, detto assai in breve, mentre tornando a Solomon Kane, ne fornì la più esauriente descrizione egli stesso nel racconto La fiamma blu della vendetta:
“Sono un uomo senza terra […] Giungo dal tramonto e nell’alba mi eclisso, vado ovunque il Signore mi guidi miei passi. Forse cerco la salvezza della mia anima. Sono giunto seguendo le orme della vendetta […] Io eseguo la volontà di Dio. Finché il male prospererà e i soprusi si diffonderanno, finché gli uomini saranno vessati e le donne umiliate, finché le creature deboli che siano umane o animali saranno tormentate soffrono, non vi sarà riposo per me pace per me sotto questo cielo, né troverei pace attorno a una tavola o in un letto”.
Insomma, Kane è senza mezzi termini un fanatico, Howard lo ripete a più riprese nelle storie di questo puritano che si trova ad agire ai tempi di Sir Francis Drake e Sir Richard Grenville, viaggiando, combattendo, sfidando la morte ripetutamente per tutta la seconda metà del XVI secolo ossessionato dal fare giustizia in nome del Bene con qualsiasi mezzo e a qualunque prezzo, monomaniacale, avvolto nel mistero perché la sua vicenda biografica è una tela strappata, costellata di assenze, la sua vita quotidiana tra un’avventura e l’altra, tra un combattimento e l’altro. Kane forse ha lasciato meno eredi di Conan, oltre a godere tutt’ora di minor fama, ma appare nel suo tormentarsi e interrogarsi, sfumando il manicheismo di tanti eroi suoi contemporanei e anche di quelli dei nostri tempi, assai vicino al nostro Zeitgeist. Una tipologia di anti eroe che pare reincarnatosi nel cavaliere oscuro immaginato da Christopher Nolan, in parte prigioniero della sua maschera, del tutto introspettivo e soprattutto condannato alla solitudine. L’uomo pipistrello di Gotham City è fatto della stessa anima di cui è fatto Kane. In tale condizione esistenziale pare situarsi tra un’avventura e un’altra, tra uno scontro e il successivo, ma quando si tratta di entrare in azione, allora la musica cambia e non c’è tempo per ulteriori riflessioni. Vale per Batman, vale in special modo per Kane. Difatti, tira una brutta aria quando ci si scontra con il Puritano. Quando il cattivo di turno ci si imbatte, inizia per lui il conto alla rovescia e sulle sue malefatte si inizia a scrivere la parola fine. Solomon Kane è un tiratore infallibile, è micidiale nel corpo a corpo sia nel combattimento all’arma bianca sia a mani nude, è agile nello schivare colpi di ogni genere, ha riflessi fulminei, gli avversari lo sfiorano lo colpiscono di striscio e poco più, tuffi, capriole e salti completano le attività ginniche che gli consentono di sopravvivere. Eccolo a confronto con un avversario che pare invincibile in La Luna dei Teschi:
“Kane scattò in piedi come una molla d’acciaio. Il pugno destro, seguendo il suo movimento, si elevò dall’altezza del fianco, descrivendo dal basso un sibilante semicerchio, per andare a impattare contro la mascella del gigante nero. Sferrato con tutta la forza del braccio e della spalla, cui si sommava la spinta data dalle gambe durante il balzo, il montante ebbe lo stesso effetto di una randellata”.
Kane insegue senza tregua chiunque oltrepassi il confine della giustizia e della morale (la sua). Lo fa ricorrendo ad ogni mezzo e non arrestandosi di fronte a nessun ostacolo, non si ferma di fronte a ostacoli naturali che lascerebbero morto stecchito chiunque altro; non arretra, ma continua ad avanzare su sentieri, foreste, boschi che pullulano di agguati, trappole, di ogni genere di insidie; non si arresta quando si scontra con nugoli di avversari, soverchianti per numero e armamenti; non conosce frontiere e non si fa scrupolo di lasciare in un angolo regole e remore, perché Kane non fa sconti a nessuno, è inflessibile. Il pericolo è il suo mestiere, la giustizia la sua missione. C’è un altro eroe post moderno erede di questa coazione a far giustizia, seriale, come deve essere ogni eroe degno di tal nome: Tex Willer. Il ranger bonelliano condivide quella irrefrenabile sete di giustizia che muove Kane, che letteralmente gli impone di agire. Imperativo morale, o forse residuo di quella mente bicamerale che ipotizzò lo psicologo statunitense Julian Jaynes in special modo nel magistrale Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza. Condizione umana prima dell’(in)sorgere della coscienza, la mente bicamerale è in buona sostanza una mente divisa a metà: una parte esecutiva da un lato e dall’altro una decisionale, incarnata dalla voce degli dèi, l’allucinazione imperativa che comanda quegli eventi. Un esempio eloquente si trova nel secondo libro dell’Iliade, quando il sogno ingannatore inviato da Zeus ad Agamennone gli impone di conquistare Troia ed è quanto mai esplicito:
“Vengo messaggero di Zeus che, pur lontano, di te ha pena e pietà; lui ti comanda di far armare subito gli Achei dai lunghi capelli; ora potrai conquistare la grande città dei Troiani”
(Omero, 2018).
Assente qualsivoglia facoltà critica, nessuna funzione coscienziale, semplicemente siamo di fronte alla voce del sogno che impone e alla volontà della veglia che dispone. Una logica a cui nessuno sfugge secondo Jaynes:
“I personaggi dell’Iliade non hanno momenti in cui si fermano a riflettere sul da farsi. Non hanno come noi una mente cosciente, e certamente non hanno la facoltà dell’introspezione. Per noi, esseri dotati di soggettività, è impossibile renderci conto in modo adeguato di tale situazione”
(Jaynes, 1996).
Solomon Kane pare agire (o agito) così a volte. Si legga questo passo del racconto I passi nel mausoleo che comporterà il confronto con una masnada da carovanieri trafficanti di schiavi:
“Agì senza pensare. Prima ancora che avesse contezza di ciò che aveva fatto, si ritrovò a impugnare la pistola fumante nella mano, mentre il macellaio arabo giaceva riverso nella polvere del sentiero con le cervella spappolate.”
D’altro canto Kane è un eroe, come Achille. È eterno come tutti gli eroi, lo si è detto, e di conseguenza sottostà come tutti i suoi fratelli d’arme alle medesime leggi. Lo comprese per bene Michael Moorcock inscenando un fantastico (in tutti i sensi) gioco metaletterario con Il campione eterno (1970), dapprima un romanzo poi primo tassello di un ciclo romanzesco che non a caso si ispirava al Conan howardiano. Erekosë, il campione eterno possiede molte altre identità (Corum, Elric di Melniboné, Hawkmoon e molti altri ancora) tutte impegnate nella lotta senza fine, eterna, appunto, contro le possibili varianti del Male convenzionale, ma non solo, anche per garantire l’equilibrio metafisico tra l’Ordine ed il Caos. Sono tutti guerrieri, eroi disincantati, tormentati, etici, determinati e fatalmente letali per gli avversari.
Il campione eterno è uno e molteplice, è Achille, è Batman, è Tex Willer, è Solomon Kane.
- Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Adelphi, Milano, 1996.
- Stephen Jones, Weird tales, Boys, Agenzia Alcatraz, Milano, 2024.
- Howard Philip Lovecraft, Ricordo di Robert E. Howard, in Teoria dell’orrore, Bietti, Milano, 2011.
- Omero, Iliade, Marsilio, Venezia, 2018.