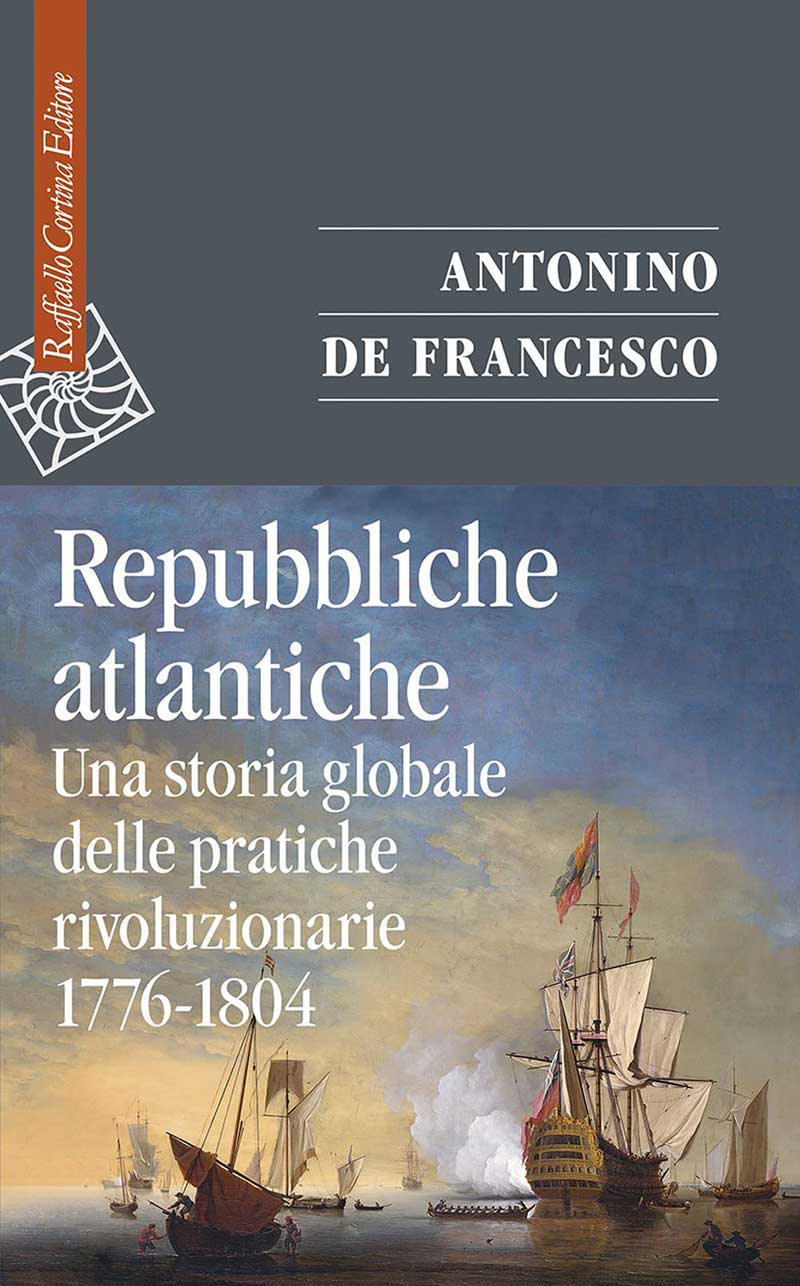Prima di iniziare un articolo che ha nel titolo cancel culture conviene sgomberare il campo da possibili equivoci attraverso due assunti di base. Primo: se per cancel culture intendiamo la definizione corrente di un movimento culturale prima che politico teso a cancellare le tracce di un passato scomodo non più in linea con il comune sentire contemporaneo, allora non si tratta di un fenomeno moderno; come spesso accade, la Rivoluzione francese ne fu antesignana. Basti ricordare l’abbattimento delle statue dei sovrani (quella di Luigi XIV a place Vendôme, ribattezzata piazza delle Picche; quella di Luigi XV nell’omonima piazza ribattezzata piazza della Rivoluzione, l’odierna place de la Concorde), la distruzione dell’ampolla dell’olio sacro di Reims, la sostituzione dei nomi delle città ribelli (Lione che diventa Ville-affranchie, Tolone Port-la-Montagne).
Secondo: dal punto di vista della ricerca storica – quel che qui ci interessa – la cancel culture può e deve assumere una forma costruttiva anziché distruttiva, vale a dire che, piuttosto di cancellare la memoria (ciò che per uno storico equivarrebbe a violare il giuramento d’Ippocrate per un medico), si occupa di recuperare una memoria cancellata. È la differenza che passa tra il rancore dei neoborbonici che vogliono abbattere le statue di Garibaldi nel Sud Italia e la moderna riflessione storiografica sul meridionalismo. Nel caso francese è la differenza che passa tra la polemica dello scorso anno sull’opportunità o meno di celebrare il bicentenario della morte di Napoleone – considerata da molti inopportuna in quanto Napoleone restaurò lo schiavismo nelle colonie (cfr. Daut, 2021) – e la rinnovata attenzione delle storiche e degli storici sul tema dello schiavismo e del razzismo nell’età rivoluzionaria e napoleonica, passato sottotraccia per quasi due secoli (di cui un esempio recente è la nuova storia della Rivoluzione francese proposta in Un nuovo mondo inizia dall’americano Jeremy D. Popkin, già autore di Haiti. Storia di una rivoluzione).

Una magistrale lezione storiografica, in questo senso, è quella offerta da Antonino De Francesco nel suo Repubbliche atlantiche. Una storia globale delle pratiche rivoluzionarie (1776-1804): titolo che a prima vista sembrerebbe riproporre il vecchio topos del parallelismo tra la rivoluzione americana e quella francese, ma che invece rinnova questo confronto alla luce della nuova esigenza di riportare alla luce la polvere che secoli di storia compiacente ha spesso nascosto sotto al tappeto.
Storia di tre rivoluzioni
Il dibattito intorno alle due rivoluzione “atlantiche” non è certo nuovo. Nelle sue linee essenziali era già stato impostato da Alexis de Tocqueville, che durante il suo soggiorno negli Stati Uniti nel 1831 si convinse delle profonde differenze tra la società nata dalla guerra d’indipendenza americana e quella emersa dalla Rivoluzione francese. Differenze che espose dapprima nel suo celebre La democrazia in America (1835-1840), e poi enfatizzò indirettamente nell’opera L’antico regime e la Rivoluzione (1856), scritta durante il Secondo Impero, in cui propose la celebre tesi secondo cui la Francia rivoluzionaria e imperiale non sarebbe stata altro che il naturale proseguimento di un processo di accentramento del potere già operato dalla monarchia di antico regime, cosicché i princìpi democratici non sarebbero stati che un contorno del processo rivoluzionario, tanto rapidamente quanto facilmente abbandonati in funzione del primato dell’autorità esecutiva, di cui Napoleone III rappresentava – agli occhi di Tocqueville – l’espressione più deteriore. In America, Tocqueville non visitò gli Stati schiavisti del Sud, ma aveva ben presente il problema e ne parlò al termine del primo dei due volumi dell’opera. Dall’alto dei suoi princìpi liberali e di emancipazione, lo schiavismo gli appariva un abominio; ma non nascondeva, invece, il profondo razzismo che lo portava a credere impossibile il melting pot e a preconizzare il futuro problema razziale americano:
“Se considero gli Stati Uniti del nostro tempo vedo bene che in una parte del paese la barriera legale che separa le due razze tende ad abbassarsi, ma non quella dei costumi: vedo dunque indietreggiare la schiavitù, ma non il pregiudizio che l’ha fatta nascere. […] Così negli Stati Uniti il pregiudizio che respinge i negri cresce via via che i negri cessano di essere schiavi e l’ineguaglianza pesa nei costumi via via che scompare nelle leggi”
(Tocqueville, 1996).
Quando, nella seconda metà del secolo scorso, il dibattito sulle rivoluzioni atlantiche tornò in auge, della questione posta da Tocqueville non v’era più traccia. La comunicazione presentata nel 1955 da Robert R. Palmer dell’Università di Princeton e da Jacques Godechot dell’Università di Tolosa al X Congresso Internazionale di Scienze Storiche a Firenze (Le Probléme de l’Atlantique du XVIIIe au XXe siècle) s’inscriveva tutta nel solco della scelta atlantista dell’Europa occidentale contro il blocco sovietico e rispondeva primariamente all’obiettivo di superare l’opposta visione classicamente proposta dalla scuola storiografica marxista francese che invece guardava alla rivoluzione russa come l’avveramento della profezia di Gracco Babeuf sull’ultima rivoluzione che avrebbe seguito quella francese (cfr. Paura, 2016). Palmer sviluppò la sua tesi nel celebre L’era delle rivoluzioni democratiche, Godechot in Le rivoluzioni (1770-1799), anche se quest’ultimo prese da subito le distanze dalla tesi atlantista del collega americano. De Francesco aveva già dedicato a questa vicenda del dibattito storiografico un’ampia parte del suo densissimo studio La guerre de deux cents ans (2018), pubblicata direttamente in francese da Perrin e proposta in italiano con il titolo Tutti i volti di Marianna (2019) da Donzelli, ricostruendo le ragioni del fallimento delle tesi di Palmer anche in quegli Stati Uniti dove erano state inizialmente salutate con grande favore:
“[…]il ritorno di attenzione verso le origini atlantiche della democrazia si rivelò presto un’estate indiana: negli Stati Uniti la lettura conservatrice del 1776 si mantenne al centro degli interessi storiografici, mentre la sfida della contestazione giovanile, favorita dalla guerra in Vietnam, non fece differenze nel rifiuto compatto di quanti sembravano detenere rendite di posizione all’interno del mondo accademico. Il fortunato manuale di Palmer sul mondo moderno, che continuava a essere aggiornato e ristampato, venne duramente contestato come uno strumento di indottrinamento delle nuove generazioni al culto wasp del proprio passato […]”
(De Francesco, 2019).
Nella prefazione di quel libro, De Francesco accennava appena al nuovo movimento storiografico che stava riportando in auge la lettura della “rivoluzione atlantica” da un inedito punto di vista. Con Repubbliche atlantiche l’autore prova invece fin dal titolo a realizzare una messa a punto di questo dibattito: la scelta di parlare di “repubbliche atlantiche” anziché di “rivoluzioni atlantiche” riecheggia la recente preferenza degli storici italiani per la dizione “triennio repubblicano” anziché “triennio rivoluzionario” per indicare il periodo 1796-1799, enfatizzando la svolta repubblicana rispetto all’impreciso concetto di “rivoluzione”, difficilmente applicabile tanto all’evanescente esperienza italiana durante l’occupazione napoleonica quanto alla guerra d’indipendenza americana (proprio la scelta di Palmer di parlare di “rivoluzione” per il 1773 era stata accolta freddamente).

La nuova storia atlantica – riconosce De Francesco – ha il suo perno nell’esperienza della schiavitù e delle rotte della tratta schiavile che ne hanno solcato i mari, per questo rappresenta oggi innanzitutto un’occasione per “studiare una nuova comunità, ovviamente transnazionale, fatta dell’incontro e dello scontro di nativi presto sulla difensiva rispetto all’invadenza dei colonizzatori”. E tuttavia il rischio di una simile dimensione (che rientra nella più vasta concezione della global history) è la relativizzazione, che “non si è fatta scrupolo di metter di lato il 1789, consegnandolo alla dimensione di un passaggio soltanto fra i molti che avrebbero accompagnato la nascita del mondo contemporaneo” (De Francesco, 2022).
Il 1789 finirebbe così per diventare l’ennesima vittima della cancel culture nella sua accezione distruttiva, ipotesi che De Francesco respinge fermamente: “non tutte le rivoluzioni sono eguali”, precisa lo storico, e questo è vero in particolare per il caso della rivoluzione haitiana che, lungi dall’essere un unicum come pretende la moderna storiografia americana, secondo De Francesco ebbe invece nel modello rivoluzionario francese il “chiaro esempio per la costruzione di uno spazio politico nell’isola caraibica”. Si tratta allora di provare a tracciare una storia delle tre repubbliche evidenziandone gli intrecci e le reciproche influenze, portando alla luce il tema centrale del ruolo della popolazione nera ma lasciando da parte la tendenziosità delle più recenti ricostruzioni ideologiche. Operazione per nulla semplice.
Il giacobino nero
Nel 1790 tanto gli Stati Uniti quanto la Francia contavano circa 700.000 schiavi. Né la Dichiarazione di indipendenza americana né la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino menzionavano la loro condizione. All’epoca, i mercanti francesi di schiavi rappresentavano il 40% del totale (più dei portoghesi e degli inglesi) e nel 1790 si toccò il picco di africani tratti in schiavitù dai francesi nelle colonie caraibiche: oltre 54.000 (Régent, 2013). Tanto l’economia americana quanto quella francese dipendevano fortemente dal sistema schiavile. Si può allora immaginare lo sconcerto quando già nel febbraio 1788 si inaugurava a Parigi la Société des Amis des Noirs, guidata da personalità quali Mirabeau, La Fayette, Brissot, Condorcet, Pétion, le cui carriere erano in procinto di spiccare il volo.
 Ribellione degli schiavi ad Haiti nella notte del 21 agosto 179. Incisione, 1815 circa.
Ribellione degli schiavi ad Haiti nella notte del 21 agosto 179. Incisione, 1815 circa.
Benché in seguito si sarebbero trovati su fronti politici diversi, in comune avevano tuttavia l’obiettivo della piena emancipazione: obiettivo che nel primo biennio della rivoluzione fu contrastato con fermezza dai grandi proprietari delle piantagioni caraibiche (molti dei quali aristocratici che non avevano mai messo piede nelle isole), ma che non appena il partito giacobino conquistò la maggioranza si tradusse dapprima nel decreto del 4 aprile 1792 con cui la Legislativa scioglieva le assemblee coloniali dominate dai bianchi e stabiliva la piena uguaglianza dei bianchi e neri liberi, dappoi con il decreto del 4 febbraio 1794 con cui la Convenzione sancì l’emancipazione generale degli schiavi e dei neri e l’abolizione della schiavitù. Tra queste due tappe apparentemente ravvicinate intercorre tuttavia una profonda frattura: quella, in Francia, che vede spaccarsi il fronte giacobino tra i girondini o brissottini (maggioranza dal gennaio ’92 al maggio ‘93) e la Montagna vicina a Robespierre e Danton (maggioranza dal giugno ’93 all’estate del ’94); quella che vede invece l’isola di Santo Domingo – principale colonia francese, che conta mezzo milione di schiavi – rivoltarsi alla stessa Francia sotto la guida di Toussaint Breda, che in seguito avrebbe assunto il nome di Toussaint Louverture. Il “giacobino nero” aveva iniziato la sua carriera rivoluzionaria – ci rammenta De Francesco – come
“uomo di antico regime, il cui universo politico nulla divideva con i valori della rivoluzione: fedele al re, di Francia o di Spagna poco importava, era molto religioso e guardava con sospetto agli sviluppi della rivoluzione […]. Sotto questo profilo, mentre per molti neri in rivolta la guerra era di liberazione anche dal sistema di lavoro fondato sulla piantagione, Breda non intendeva invece nulla variare e mostrava in tal modo tutto il suo conservatorismo sociale”
(De Francesco, 2022).
Fu solo nel maggio 1794, dopo la svolta emancipatrice della Francia, che Toussaint Louverture decise di diventare “una spada della Repubblica”: dimostrazione di quanto la rivoluzione haitiana dovesse a quella francese e alle sue continue svolte. L’ultima di queste sarebbe stata poi fatale allo stesso Toussaint.
Bonaparte, l’ultimo schiavista
Pur essendo all’epoca capo (quasi) indiscusso della Francia, Robespierre aveva più subìto che perorato la causa dell’abolizione dello schiavismo. Secondo Jonathan Israel, strenuo difensore dei girondini, a suo dire autentici rappresentanti dell’universalismo democratico rivoluzionario, ciò si deve al fatto che le visioni dei montagnardi fossero “dal punto di vista illuminista e democratico, meno ampie, radicali e universali” di quelle di Brissot e dei suoi. Il Termidoro e la caduta di Robespierre evitarono il rischio di un ritorno allo status quo ante e il ritorno al potere dei girondini sopravvissuti alle grandi purghe permise alla rivoluzione nera di dilagare nelle altre colonie caraibiche, in funzione anti-britannica, anti-spagnola e anti-olandese. Alla luce di ciò Israel si rivela molto vicino alle posizioni riprese da De Francesco, quando scrive:
“Il motore principale dell’emancipazione nera nei Caraibi nel corso degli anni Novanta del Settecento fu, senza dubbio, l’orientamento philosophique all’interno della Rivoluzione, cioè l’Illuminismo radicale che operò a Parigi attraverso gli Amici dei neri e la fazione brissottina”
(Israel, 2015).
Posizione ancora oggi molto dibattuta, specialmente in Francia, come mostra il recente studio sul periodo del Direttorio firmato da Marc Belissa e Yannick Bosc Nel labirinto della Rivoluzione francese. La repubblica senza democrazia del direttorio (2021). Fedele a una linea di respingimento tout court del periodo termidoriano come tradimento dell’esperienza autenticamente democratica del giacobinismo, l’opera s’inserisce nel dibattito su colonialismo e schiavismo affermando che “l’eliminazione dei montagnardi a partire dal maggio del 1795 indebolì in modo evidente il campo dei difensori della «libertà generale» e, malgrado il voto del 25 piovoso, gli schiavisti continuarono a esprimersi talvolta violentemente nell’Assemblea” (Belissa, Bosc, 2021). Se il campione della reazione termidoriana, Boissy d’Anglas, fu anche il più accanito difensore del decreto abolizionista, confermando nell’agosto 1795 la sua validità al punto da chiudere la questione per tutta la stagione del Direttorio, ciò si dovrebbe secondo i due storici al fatto che
“Per la Francia si trattava piuttosto di porsi alla guida (provvisoria?) dei popoli-bambini, ad immagine della retorica termidoriana come nel caso del Belgio per esempio. Siamo quindi a tutti gli effetti nel quadro della civilizzazione dei popoli dall’alto, al cuore del progetto sociale e culturale del Direttorio”
(Belissa, Bosc, 2021).
Più netta è invece la posizione della storiografia contemporanea riguardo la svolta impressa da Bonaparte una volta assunto il potere dopo il colpo di stato del 18 brumaio. Per la verità, già negli ultimi anni del Direttorio si erano accumulati indizi di una non unanime condivisione dell’abolizionismo tra gli uomini di governo per questioni di opportunità politica nei confronti delle potenze internazionali decisamente schiaviste; ma la logica di potenza che il Direttorio – ancora troppo legato alle formule rivoluzionarie – non si era deciso a seguire fino in fondo fu invece applicata senza remore da Bonaparte, che intendeva riprendere il controllo delle colonie per farne il perno di un impero atlantico. Nel 1802 comparve un violento trattato contro l’abolizione della schiavitù, Gli errori della negrofilia, che la moglie di Napoleone, Josephine (cresciuta in una famiglia di piantatori della Martinica, dove era ancora proprietaria di molti terreni), accettò di farsi dedicare (cfr. Popkin, 2021). Nel giro di due anni, al prezzo di quasi cinquantamila morti da parte francese, il Consolato ebbe ragione sulla repubblica haitiana e ripristinò lo schiavismo in tutte le colonie, mentre Louverture finiva i suoi giorni in una fredda prigione in Savoia. Decisione dettata dalla ragion di Stato, commenta De Francesco, ossia dalla politica di ralliement che in patria aveva permesso a Bonaparte di pacificare il paese riammettendo gli emigrati realisti, e che nelle colonie richiedeva di andare incontro alle richieste dei proprietari terrieri che non avevano tardato ad appoggiare il suo regime.
“Col facile senno del poi si può rimproverare a Bonaparte di aver sottovalutato l’impatto rivoluzionario del decreto di abolizione della schiavitù e di non avere tenuto conto delle aspirazioni alla libertà dei neri. Al tempo, però, l’opinione pubblica francese, alla quale soltanto il primo console era sensibile, voleva una pacificazione senza restaurazione e questa richiesta suggeriva che non si tornasse sulle situazioni create dalla rivoluzione, ma neppure si stravolgesse quelle che ne erano rimaste immuni. Il problema della schiavitù non usciva da questa politica dell’equilibrio e dunque non c’era spazio per le aspirazioni di quanti fossero ancora privi della libertà, anche se non si escludeva che chi l’avesse conquistata potesse conservarla. D’altronde, l’esempio degli Stati Uniti confermava come libertà e schiavitù potessero, a seconda dei contesti locali, comunque coesistere e il primo console voleva seguire quella via per avere voce in parte del nuovo mondo”
(De Francesco, 2022).
Fu insomma proprio il confronto con l’America a convincere Bonaparte – che all’epoca del Consolato aveva in George Washington il suo modello – che l’eguaglianza non richiedesse necessariamente l’abolizione dello schiavismo e che fosse possibile difendere i princìpi della rivoluzione senza necessariamente sposare l’universalismo democratico dei giacobini. Un’idea che fungeva da anticamera all’Impero e al ritorno del dispotismo; ma che, soprattutto – annota De Francesco – apriva a “un nuovo spazio mentale, destinato a consentire il rapido passaggio da un immaginario schiavile di stampo ancora tradizionale a una moderna forma di colonialismo, che avrebbe dato piena prova di sé a partire dal 1830 con la conquista dell’Algeria”.
- Marc Belissa, Yannick Bosc, Nel labirinto della Rivoluzione francese. La Repubblica senza democrazia del Direttorio, DeriveApprodi, Roma, 2021.
- Marlene L. Daut, Napoleon Isn’t a Hero to Celebrate, New York Times, 18 marzo 2021.
- Antonino De Francesco, Tutti i volti di Marianna. Una storia delle storie della Rivoluzione francese, Donzelli, Roma, 2019.
- Jacques Godechot, Le rivoluzioni (1770-1799), Mursia, Milano, 1989.
- Jonathan Israel, La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo a Robespierre, Einaudi, Torino, 2015.
- Robert R. Palmer, L’era delle rivoluzioni democratiche, Rizzoli, Milano, 1971.
- Roberto Paura, Rivoluzione atlantica, in Id., Guida alla Rivoluzione francese, Odoya, Bologna, 2016.
- Jeremy D. Popkin, Un nuovo mondo inizia. La storia della Rivoluzione francese, Einaudi, Torino, 2021.
- Frédéric Régent, Slavery and the Colonies, in Peter McPhee (a cura di), A Companion to the French Revolution, Wiley Blackwell, Oxford, 2013.
- Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, 2 voll., Rizzoli RCS, Milano, 1996.