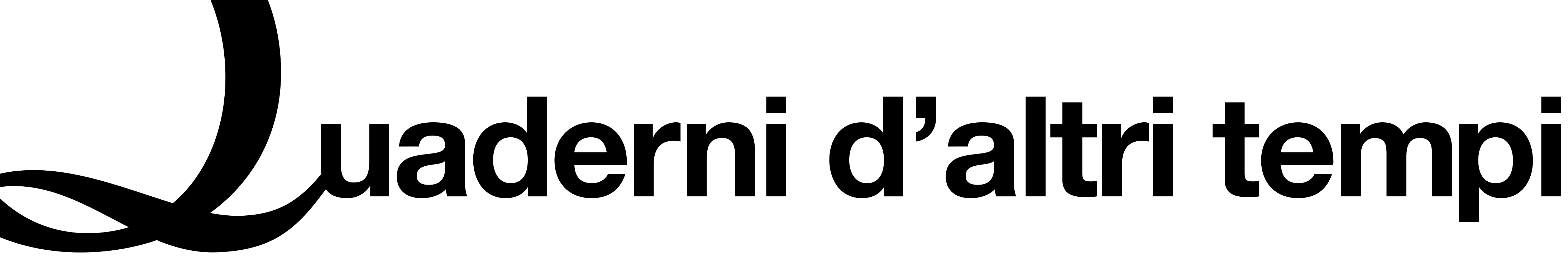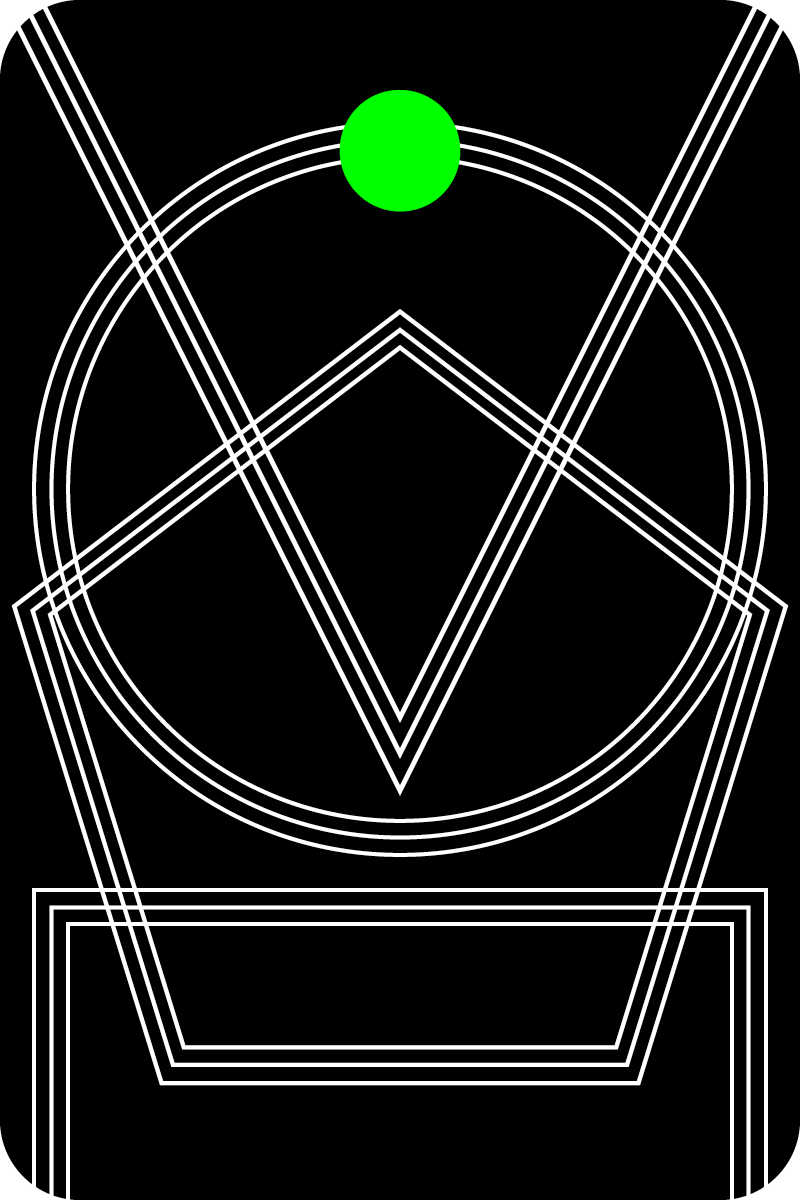Dopo la panoramica dedicata alla fantascienza italiana, siamo giunti alle battute finali di questo ciclo di articoli, volti a delineare una guida ideale, benché senza pretese di completezza ed esaustività, alle forme assunte e ai risultati raggiunti dal genere dopo l’anno 2000. Prima di tirare le somme, però, mancano all’appello ancora alcune autrici e autori che con le loro opere stanno plasmando il volto che assumerà la fantascienza per le prossime generazioni.
Fantascienza di massa e fantascienza d’avanguardia
La fantascienza è un fenomeno popolare e quindi non sorprende che dal suo humus fecondo di tanto in tanto spunti qualche bestseller. È quello che abbiamo visto ripetersi con una certa regolarità negli ultimi anni, a partire da Ernest Cline (1972), che nel 2011 esplode con Ready Player One, storia di un futuro mondo distopico (manco a dirlo, al collasso ambientale, energetico e sociale), in cui l’unica modalità di intrattenimento e svago per la popolazione è rappresentata da OASIS, un mondo virtuale che il suo creatore ha infarcito di indizi e riferimenti alla cultura degli anni Ottanta e Novanta, di cui era un grande appassionato. Alla sua morte, i giocatori (soprannominati Gunter, dalla contrazione di egg hunter) si sfideranno in una caccia al tesoro senza precedenti, in cui il premio in palio è costituito dall’eredità dello sviluppatore. Il romanzo è stato adattato nel 2018 da Steven Spielberg in un film di successo mondiale, che ha incassato più di 600 milioni di euro solo dalla programmazione in sala. Forte di questo riscontro, dopo aver dato alle stampe nel 2015 il suo secondo romanzo, Armada, sempre su un videogioco ma stavolta con una trama a base di invasioni extraterrestri e cospirazioni globali, Cline riprende i protagonisti del suo esordio letterario e prepara per loro una nuova avventura, nel sequel Ready Player Two (2020).
Immaginate un social network che riunisca tutte le caratteristiche dei social che conosciamo, in grado di perseguire attraverso la massima esposizione pubblica possibile delle vite dei suoi utenti il progetto di una trasparenza totale quale pretesto per un mondo più sicuro: è lo spunto da cui il saggista e scrittore americano Dave Eggers (1970) muove per imbastire la sua critica al capitalismo della sorveglianza nel romanzo Il Cerchio (2013), da cui il film omonimo di James Ponsoldt del 2017, con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega e Karen Gillan. Ancora una realtà artefatta usata come arma di controllo di massa è quella che costruisce Hugh Howard (1975), autopubblicandosi su Amazon la sua Trilogia del Silo: Wool (2011), Shift (2012) e Dust (2013) diventano un caso mondiale e vengono adattati da Graham Yost in una serie televisiva con Rebecca Ferguson trasmessa da Apple TV+ a partire dal 2023.

Guardano alla fantascienza anche i thriller psicologici di Blake Crouch (1978): a partire da un’altra realtà simulata portata in televisione, quella della trilogia di Wayward Pines (2013-2016), adattata in una serie in due stagioni da Chad Hodge per Fox (2015-2016), e fortemente debitrice verso i modelli di Twin Peaks e Il prigioniero. Il tema dickiano della realtà che non è ciò che sembra attraversa anche i lavori successivi dello scrittore statunitense, da Recursion. Falsa memoria (2019) a Upgrade (2022), passando per Dark Matter (2016), da cui lo stesso Crouch ha sviluppato una serie per Apple TV+ con Joel Edgerton e Jennifer Connelly nel ruolo dei protagonisti, che si trovano a incrociare le loro vite attraverso le realtà parallele teorizzate nell’interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica.
Tornando alla memoria, ai falsi ricordi e alla percezione alterata della realtà, il londinese Tom McCarthy (1969), autore postmoderno e segretario della International Necronautical Society, una rete di avanguardie artistiche, si è cimentato sul tema dell’amnesia e della ricostruzione dei ricordi perduti in Déjà-Vu (2005), delle società segrete all’opera nelle zone in ombra della storia con C (2010), che è anche un sottile omaggio personale alla letteratura paranoica di Thomas Pynchon, e infine con un romanzo come Satin Island (2015) ha affrontato l’iperstimolazione da informazioni a cui siamo sottoposti, portando in scena un etnografo incaricato di stilare una Grande Relazione che traduca i dati raccolti dalla ricerca in modelli comportamentali dei consumatori. E di società segrete parla anche il francese Antoine Bello (1970) nel dittico formato da I falsificatori (2007) e Gli illuminati (2009), caso letterario in Francia, su un misterioso Consorzio per la Falsificazione della Realtà all’opera dietro le quinte della storia in un mondo distopico, con evidenti punti di contatto con gli universi di George Orwell e Philip K. Dick, gli intrighi di John Le Carré e il funambolismo letterario di Jorge Luis Borges.
I futuri di altri tempi
Tra le più potenti espressioni della fantascienza di questo scorcio di secolo possiamo annoverare senza ombra di dubbio La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, bestseller del 2003 di Audrey Niffenegger (1963): oltre due milioni e mezzo di copie nei soli mercati nordamericano e britannico. Baciato da un successo che deve molto alla storia romantica che racconta, ma anche all’originale espediente che adotta nella contrapposizione dei punti di vista dei due protagonisti: Henry, incapace di controllare una disfunzione genetica che gli permette di saltare imprevedibilmente da un momento all’altro della sua vita; e Clare, costretta ogni volta ad aspettarlo. L’asimmetria di informazioni a loro disposizione, nel tempo lineare sperimentato dalla donna, porterà via via a un ribaltamento di prospettive, fino al toccante epilogo. Dal romanzo sono stati inevitabilmente tratti un film di successo nel 2009, diretto da Robert Schwentke, con Eric Bana e Rachel McAdams (Un amore all’improvviso, per noi poveri spettatori italiani) e una miniserie in sei episodi prodotta nientemeno che da Steven Moffat (già ideatore di Sherlock e showrunner di Doctor Who dalla quinta stagione) per HBO nel 2022, con Rose Leslie e Theo James (Un amore senza tempo, ahinoi). L’espediente dei viaggi nel tempo si presta a essere declinato in una infinità di contesti, rappresentando un efficacissimo dispositivo narrativo nelle mani di autori e autrici dotate (cfr. De Matteo – Fabriani, 2011), ed è quello che succede anche con Amal El-Mohtar e Max Gladstone, entrambi classe 1984, artefici dello strabiliante Così si perde la guerra del tempo (2019), un romanzo breve scritto in forma epistolare che mette a confronto i punti di vista di due agenti segrete schierate sui fronti opposti di un conflitto cosmico e quasi metafisico che si dipana attraverso la storia, meritatamente vincitore sia del premio Hugo che del Nebula.

Le vite di Tess e Beth, la prima una studiosa che viaggia nel tempo per cambiare la linea temporale e creare un futuro migliore, la seconda una diciassettenne costretta a fare i conti con la violenza che ha preso di mira donne e ragazze nel suo mondo, si incrocia quando uomini provenienti da un futuro ostile alla condizione femminile minacciano di distruggere il viaggio nel tempo: è l’inizio di una guerra, raccontata ne Il futuro di un altro tempo da Annalee Newitz (1969), vincitore del Lambda Literary Award. Uscito nel 2019, è il secondo romanzo dell’autrice, già analista politica della Electronic Frontier Foundation e caporedattrice prima di io9 e poi di Gizmodo, due tra i più influenti portali al mondo di fantascienza, tecnologia, scienza e cultura geek. Prima di questo, nel 2017 aveva esordito nel romanzo con Autonomous, sulla scoperta di una droga che promette di asservire l’umanità al controllo delle multinazionali, e nel 2019 si era aggiudicata il premio Sturgeon con la favola post-cyberpunk Quando Robot e Corvo salvarono East St. Louis (apparso sul numero 89 di Robot).
Mescolando satira e nostalgia, il bulgaro Georgi Gospodinov (1968) usa il viaggio nel tempo per permettere ai suoi personaggi di regolare i conti con il passato e per proiettare nel futuro le attese incompiute, in Cronorifugio (2020) come nel precedente Fisica della malinconia (2012). Mentre la già citata Emily St. John Mandel, nel suo ultimo romanzo, Mare della tranquillità (2022), salta tra le epoche con i suoi detective temporali attraverso i 500 anni che separano il Canada di inizio Novecento dalle colonie lunari del XXV secolo, per indagare una misteriosa anomalia spazio-temporale che arriverà a toccare le frontiere meno esplorate della fisica, ma tra le più care alla fantascienza degli ultimi tempi, con una nuova esplorazione dell’ipotesi dell’universo simulato.
Sei mesi, tre giorni è il racconto che ha segnato l’irruzione di Charlie Jane Anders (1969) nel panorama fantascientifico e fantastico americano: la storia, apparsa sul numero 67 di Robot, è giocata sul parallelismo tra i due protagonisti, muniti di facoltà precognitive, ma in grado lui di vedere un solo futuro, mentre lei di vedere i molti futuri possibili. Entrambi sanno che la loro storia d’amore non finirà bene e durerà esattamente sei mesi e tre giorni. Lo spunto ha ispirato anche il primo romanzo fantastico dell’autrice, Tutti gli uccelli nel cielo (2016), un fantasy che mescola magia e tecnologia e le è valso il premio Nebula. Nel 2019 è uscito il suo secondo romanzo, The City in the Middle of the Night, ambientato su un pianeta in orbita sincrona abitato da forme di vita aliene ostili. Un’idea in cui risuona forse una comune ispirazione con The Terraformers (2023), ultimo libro della sua compagna nella vita, la già citata Annalee Newitz, che racconta invece mille anni di storia di un pianeta del futuro sottoposto a terraformazione. Entrambi i romanzi restano al momento inediti in Italia.

Kristine Kathryn Rusch (1960), che lungo la sua carriera ha avuto la possibilità di cimentarsi con una varietà di generi diversi, negli ultimi anni ha sviluppato principalmente due cicli di novelle e racconti: quello detto del Diving Universe (Un tuffo nel relitto, Stealth, La stanza delle anime perdute) e quello dedicato all’Artista dei recuperi (iniziato nel 2000 con la novella omonima). La sua opera più significativa è però una struggente ucronia sulla corsa allo spazio, vincitrice del Sidewise Award nel 2008: Il recupero dell’Apollo 8. Con una quadrilogia di romanzi (Le piume di Vurt, Polline, Alice nel paese dei numeri e l’inedito da noi Nymphomation), negli anni Novanta il britannico Jeff Noon (1957) si era meritato lo status di autore di culto, legando il suo nome a una scrittura inventiva, che ricorreva non di rado a soluzioni tipografiche tutt’altro che ordinarie e si distingueva per la rappresentazione letteraria di una realtà volubile e mutante. Nel 2017 Noon ha iniziato una nuova serie nota come i Nyquist Mysteries, dal nome del protagonista, un investigatore privato in una città-mondo in cui diverse linee temporali coesistono fianco a fianco, e un misterioso serial killer semina il panico uccidendo in pubblico senza lasciare tracce. A pubblicare L’uomo delle ombre in Italia è stata la casa editrice Edizioni BD nel 2021. Nella stessa interessantissima collana 451 è uscito anche il romanzo di esordio di Alan Moore, fumettista di culto (V for Vendetta, Watchmen, From Hell, La Lega degli Straordinari Gentlemen, solo per citare alcune delle opere che hanno rivoluzionato il mondo del fumetto), nato nel 1953 a Northampton e che qui ambienta La voce del fuoco (1996): dodici capitoli per dodici personaggi disseminati lungo seimila anni di storia. Nel 2016 Moore amplia questa intuizione in Jerusalem, un romanzo-mondo in cui la ricostruzione storica si fonde con la cosmogonia, la denuncia politica con la teoria poetica, in un libro che è anche una saga familiare, che vede coinvolti Albert Einstein e H. P. Lovecraft, William Shakespeare e Samuel Beckett, Lewis Carroll (nome caro anche al già citato Jeff Noon) e Charles Dickens, per imbastire una riflessione sul tempo e sulla nostalgia.
Oliver Langmead, scozzese di Glasgow, si fa invece bastare meno di 200 pagine per fornirci la sua visione di un mondo alla fine del tempo con Dark Star (2015), autentico oggetto narrativo non identificato in forma di poema, un noir hard-boiled in salsa horror-fantascientifica ambientato in una città immersa in una notte eterna, ai confini dello spazio conosciuto.
Il maestro dell’horror Stephen King
Siamo riusciti ad arrivare fin qui senza citare un autore che i meglio informati si sarebbero già aspettati di incontrare da un pezzo, ma è tempo di porre rimedio. Effettivamente, negli ultimi anni anche il maestro dell’horror Stephen King (1947) è tornato con una certa costanza a spunti, idee e suggestioni di chiara matrice fantascientifica: prima con la chiusura del suo magnus opus, la saga della Torre Nera, che spazia dal fantawestern al romanzo post-apocalittico, e porta in scena un viaggio tra universi paralleli che da una parte permette al Re di Bangor di integrare in una cornice grandiosa e coerente elementi dal resto della sua opera sterminata, e dall’altro riesce a regalare al lettore una riscrittura fantastica del poema di Robert Browning Childe Roland alla Torre Nera giunse (1855, cfr. aracne 2017), modello anche del citato Diamond Dogs di Alastair Reynolds, amalgamata con un pantheon di ispirazione lovecraftiana e con omaggi al Signore degli anelli e agli spaghetti western di Sergio Leone. I romanzi del ciclo sono stati adattati in una serie di fumetti sontuosamente disegnati da Jae Lee per la Marvel, e hanno ispirato una trasposizione cinematografica diretta da Nikolaj Arcel (La torre nera, 2017, con Matthew McConaughey e Idris Elba), che purtroppo non ha riscosso il successo atteso e ha finito per congelare anche i piani per un’eventuale serie televisiva prodotta da Amazon.
Una delle storie con più punti di contatto con il ciclo è lo struggente Cuori in Atlantide (1999), infarcito di nostalgia e di riferimenti alla cultura popolare (dai pulp magazine a John Wyndham, fino alla serie televisiva di culto Il prigioniero). Attingono ancor più direttamente all’immaginario fantascientifico, il monolitico The Dome (2009), su una cittadina del Maine che si ritrova separata dal resto del mondo a causa della comparsa di una cupola misteriosa, e 22/11/63, che tratta di viaggi nel tempo e complotti per uccidere il presidente John Fitzgerald Kennedy, un tema esplorato in forma ucronica anche da Pierfrancesco Prosperi (1945) nel suo Incubi per Re John (2008). Tutti i titoli citati di King hanno ricevuto una trasposizione televisiva o (come nel caso di Cuori in Atlantide) cinematografica.

A proposito di mondi paralleli e ucronie, da segnalare il ritorno di Philip Pullman (1946) al mondo di Queste oscure materie, con la chiusura della trilogia originale (Il cannocchiale d’ambra, del 2000, che fa seguito a La bussola d’oro e La lama sottile, rispettivamente del 1995 e del 1997) e una serie di racconti e cartoline (La Oxford di Lyra, 2003) tratti dallo stesso universo, per arrivare alla trilogia sidequel Il Libro della Polvere, che al momento annovera La belle sauvage (2017) e Il regno segreto (2020): una storia che inizia in un mondo simile al nostro, ma che diventa via via più bizzarro e stravagante (tra tecnologie retrofuturistiche, animali parlanti, daimon che costituiscono una manifestazione visibile dell’anima, streghe e angeli), per rivelare progressivamente come il nostro non sia che uno dei tanti universi paralleli, e che tra questi esistano dei punti di contatto che consentono a chi possiede gli strumenti giusti, come la lama sottile, di aprire dei varchi tra le dimensioni. Dalla trilogia originale, HBO ha prodotto tra il 2019 e il 2022 l’omonima serie in tre stagioni con la promessa del cinema Dafne Keen (Logan: The Wolverine), His Dark Materials – Queste oscure materie.
Eclettismo e best seller: Joe R. Lansdale
Altro scrittore bestseller che ama spaziare tra i generi, come King e Pullman, è Joe R. Lansdale (1951): la dimensione parallela del suo Drive-in (1988) è tra le più inquietanti e grottesche che ci sia stato dato di leggere, e dopo la tappa intermedia del Giorno dei dinosauri (1989), nel 2005 giunge al capolinea con La notte del drive-in 3. La gita per turisti. Ma non è l’unica incursione del bardo texano in territorio fantascientifico: insieme ai racconti, che possiamo trovare antologizzati con il meglio della sua narrativa breve nelle raccolte Maneggiare con cura (2022) e In un tempo freddo e oscuro e altri racconti (2006), Fuoco nella polvere (2001) e Londra tra le fiamme (2006) cominciano una saga, non ancora del tutto tradotta in italiano, ambientata in un XIX secolo ucronico, con molti richiami all’estetica steampunk e omaggi all’immaginario del genere.
Universi paralleli e taglio young adult sono anche le coordinate in cui si muove la Multiversum Saga di Leonardo Patrignani (1980): tre romanzi pubblicati da Mondadori tra il 2012 e il 2014 (Multiversum, Memoria, Utopia), tradotti e distribuiti in 24 paesi, che hanno originato anche tre raccolte di spin-off curate dallo stesso autore. Nel 2023 esce La cattedrale di sabbia, pubblicato nella collana Oscar Fantastica di Mondadori, un thriller fantascientifico che porta in scena una Milano distopica del 2045, in cui il protagonista è costretto a misurarsi con la veridicità dei propri ricordi.
Storie intrecciate dentro storie intrecciate
La fantascienza vive di un duplice confronto: con il mondo reale, con cui finisce sempre anche solo implicitamente per essere misurata, come se potesse essere di fatto ridotta a mera anticipazione, estrapolazione di tendenze in corso, proiezione futura di ombre ingigantite tratte da una qualche inquietudine del presente; e con sé stessa, in un dialogo interno che pone ogni nuovo lavoro in relazione con la trama dei riferimenti intessuta dai precursori (cfr. Fazio 2006). Quindi è naturale imbattersi tra i suoi scaffali in lavori che giochino con le inclinazioni del lettore o con le attitudini del genere stesso, sfidandolo o spingendole alle estreme conseguenze, ora con invenzioni mitopoietiche, ora con gallerie degli specchi che talvolta deformano in molteplici riflessi l’immagine del presente, talaltra si divertono a scomporre l’immaginario del genere nelle sue componenti primarie, magari attraverso una rivisitazione delle diverse fasi attraversate nella sua evoluzione storica, o dei diversi filoni narrativi che ha di volta in volta esplorato.
Maestro in questo tipo di narrazioni è senz’altro il britannico David Mitchell (1969), che si è cimentato nei romanzi a incastro fin dai suoi esordi, prima con Nove gradi di libertà (1999) e poi con Sogno numero 9 (2001). Ma è con Cloud Atlas. L’atlante delle nuvole (2004) che porta questa tecnica allo stato dell’arte, componendo un arazzo narrativo in cui ciascun filone narrativo richiama i personaggi, le opere o le azioni di almeno una delle altre cinque storie che s’intrecciano nel romanzo: dal diario ottocentesco di un notaio americano in viaggio attraverso il Pacifico al racconto in forma epistolare di un musicista alla ricerca della composizione perfetta nell’Europa degli anni Trenta, dal resoconto in salsa hard-boiled dell’inchiesta di una giornalista che nel 1975 indaga su una centrale nucleare al racconto biografico in prima persona di un editore in fuga da una gang di criminali; arrivando fino all’intervista rilasciata da una ragazza clonata nella Seoul del futuro, invasa dall’oceano e governata da uno stato totalitario, prima dell’esecuzione della sua condanna a morte; e alle Hawaii di un futuro post-apocalittico, in cui gran parte della popolazione terrestre è regredita a uno stato semiprimitivo per le conseguenze della Caduta, mentre altri umani continuano a tenere in vita una civiltà tecnologica. Dal romanzo, nel 2012 le sorelle Lana e Lilly Wachowski (già artefici della saga di Matrix e successivamente ideatrici e produttrici della serie Sense8 per Netflix) e Tom Tykwer trassero il film omonimo con Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant e Hugo Weaving, che con un budget di cento milioni di dollari divenne la produzione indipendente più costosa della storia (cfr. De Matteo, 2013).

Ritroviamo la stessa impostazione anche nel successivo Le ore invisibili (2014), vincitore del World Fantasy Award, che secondo uno schema narrativo simile si sviluppa tra il 1984 e il 2043 mettendo in scena lo scontro tra due fazioni di immortali (raccontato questa volta in prima persona dal punto di vista di cinque diversi narratori), svelando al contempo una serie di indizi che lo ricollegano a tutti gli altri romanzi di Mitchell. Nel 2015, lo stesso anno del successo di Mitchell al World Fantasy Award nella categoria per il miglior romanzo, tra le novelle s’impose Siamo tutti in ordine di Daryl Gregory (1965), un horror che presenta curiosi spunti di contatto proprio con Le ore invisibili (che in originale si intitola The Bone Clocks), tra cui una ragazza ossessionata dai messaggi che l’Intagliatore le ha inciso nelle ossa, mentre con gli altri membri del suo gruppo di sostegno per sopravvissuti a orrori soprannaturali accompagna il lettore in un viaggio nel lato più oscuro e pericoloso della psiche umana, verso mondi paralleli e spaventosi in cui è facile perdersi. Il racconto Nove ultimi giorni sul pianeta Terra (2018) porta in scena una singolare invasione aliena: dopo l’incontro con un “uomo felce” il protagonista si ritrova a ricordare gli ultimi giorni che marcano il suo passaggio sulla Terra.
Tredici modi di concepire lo spazio-tempo è il dissacrante, struggente racconto di come una scrittrice di fantascienza viene al mondo, tra le storie più memorabili incluse in Le visionarie, la migliore antologia degli ultimi anni, uscito dalla penna di Catherynne M. Valente (1979), che nei suoi oltre dieci romanzi ha spaziato dal folklore in chiave fantasy (mythpunk, come preferisce definirlo lei) de L’immortale (2011) all’omaggio a Douglas Adams di Space Opera (2018), dai romanzi tie-in per le serie di videogiochi (Mass Effect: Andromeda – Annihilation, 2018) allo stralunato Radiance (2015), una storia sul potere delle storie di dare forma al mondo, purtroppo ancora non tradotta in italiano, che prende le mosse dalla scomparsa di una giovane regista di documentari di un universo alternativo (in cui Hollywood si trova sulla Luna, Marte è un Far West disseminato di saloon fuori legge e Venere un mondo acquatico) durante un sopralluogo per il suo prossimo progetto.
Altra scrittrice statunitense salita alla ribalta negli ultimi tempi è Sarah Pinsker (1977), nella vita cantautrice che si esibisce sia come solista sia con la sua band, le Stalking Horses; scrive ispirata da Ursula K. Le Guin, Kate Wilhelm, Octavia E. Butler e Karen Joy Fowler ed è stata per dieci volte in meno di dieci anni finalista al premio Nebula, vincendolo con il racconto Nostra Signora della Strada (2015, uscito sul numero 78 di Robot), che costituisce una sorta di antefatto al suo primo romanzo, insignito dello stesso premio, Canzone per un nuovo giorno (2019), su un futuro in cui i concerti sono dichiarati illegali a causa del terrorismo e del dilagare delle pandemie; e poi con i successivi Due verità e una bugia (2020) e Dove si raccolgono i cuori di quercia (2021), che si sono aggiudicati anche il premio Hugo, entrambi pubblicati sempre da Robot rispettivamente sui numeri 93 e 95. Non hanno raccolto premi, ma sono tra le cose più interessanti partorite dalla fantascienza di questi anni, il delizioso romanzo breve metanarrativo sugli universi paralleli Enne meno uno (2017) e il romanzo We Are Satellites (2021, non ancora tradotto in italiano).
L’archivio dei finali alternativi (2019), terzo romanzo di Lindsey Drager (1986), è stato accostato a David Mitchell per l’espediente di costruire una matrioska di storie che si richiamano l’un l’altra, in cascata, ma è anche stato elogiato dai colleghi, incluso Sam J. Miller, per la sua originalità e autenticità: incluso da NPR nella lista dei migliori libri dell’anno, la storia di un amore fraterno che echeggia all’intersezione tra i generi, tra l’ecodistopia e il dramma storico, tra l’epopea familiare e la denuncia civile, traccia il ciclo di vita delle storie, come ci cambiano passandoci attraverso (non a caso Miller nella sua prefazione all’edizione italiana di Zona 42 scrive: “Il tuo viaggio sarà solo tuo e la persona che uscirà dall’altra parte non sarà la stessa che è entrata”) e come evolvono nel viaggio da una generazione all’altra.
Il caso Elysium di Jennifer Marie Brissett
Parole che potremmo usare anche per Elysium di Jennifer Marie Brissett (1969). Scrittrice inglese ma trapiantata in America, ha scritto e pubblicato una dozzina di racconti in quindici anni, ed è uscita da poco con il suo secondo romanzo per Tor Books (Destroyers of Light, 2021). Elysium (2014) ha ricevuto una menzione speciale al Philip K. Dick Award ed evocato paragoni illustri (Paul Di Filippo ha accostato la sua autrice a Carol Emshwiller e Samuel R. Delany), non a caso: da solo vale un’intera libreria. Brissett riesce a toccare le corde più profonde del lettore scrivendo una storia che cerca di definire continuamente l’identità e la personalità dei suoi personaggi e, nel farlo, cambia incessantemente non solo le coordinate spazio-temporali in cui si muovono, ma le loro stesse caratteristiche distintive. Il cambiamento è l’unica costante che attraversa tutte le scene del romanzo: dal primo all’ultimo capitolo, ogni cosa fluisce e niente rimane intatto, se non la forza del legame che unisce, in tutte le sue forme, Adrian /Adrienne e Antoine/Antoinette. Mentre scava delicatamente nelle dinamiche affettive della coppia, l’autrice si diverte a rimescolare senza sosta le carte per calarli in situazioni sempre più tragiche, sottoponendoli a sfide che diventano via via più difficili da sostenere e da superare. E mentre attraversano tutto questo, sullo sfondo di un’invasione aliena tra le più memorabili che ci siano capitate, i due protagonisti si trasformano a loro volta, da amanti diventano fratelli, e poi padre e figlia, figlio e madre, amici, compagni, uniti per sempre in una resistenza che sfida il tempo e forze oscure – “superiori”, ci verrebbe da dire – che nemmeno loro possono pienamente comprendere. E mentre le pagine scorrono ci ritroviamo di volta in volta in una distopia, in un’ucronia, nel mezzo di un’invasione aliena, in un inferno apocalittico, in una Terra occupata, nel quartier generale della resistenza e ai piedi di un’arca generazionale che promette di portarci in salvo, in un compendio di tutta la fantascienza che è stata scritta e pensata in poco meno di un secolo di invenzioni fantastiche. Anche per questo Elysium è un’opera straordinaria, in cui ritroviamo certamente echi di Dick, ma anche di Kurt Vonnegut (come gli abitanti di Tralfamadore, gli alieni krestge sono creature che vivono nelle quattro dimensioni e risultano per questo sfuggenti ai sensi umani) e di Margaret Atwood (uno dei mondi che lǝ protagonistǝ si trovano ad attraversare sembra uscito dal Racconto dell’ancella), e che merita pienamente di entrare nel canone fantascientifico di tutti i tempi.
Is This the End?
Prima di chiudere, concediamoci un’ultima lettura. Altra scrittura camaleontica, mutevole, in continua trasformazione, è quella sfoggiata da Roberto Bolaño (1953-2003), l’esule cileno divenuto caso letterario e autore di culto poco prima della sua scomparsa prematura, che non fece in tempo ad assistere all’uscita del suo romanzo più ambizioso (2666), né paradossalmente alla riscoperta del suo primo libro. Scritto nel 1984, quando il suo autore era poco più che trentenne, e rinvenuto tra le sue carte dopo la morte, il romanzo è stato pubblicato postumo nel 2016. Adelphi, l’editore italiano di Bolaño, un po’ sorprendentemente per i lettori abituati a vedere la grande editoria rifuggire il marchio d’infamia del genere, lo ha presentato in libreria nel 2018 nella traduzione di Ilide Carmignani con un titolo fedele all’originale: Lo spirito della fantascienza. Nelle sue pagine, in una girandola di citazioni e invenzioni, ci imbattiamo nelle lettere che il compagno di stanza del narratore indirizza ai suoi idoli letterari (Alice Sheldon / James Tiptree Jr, Ursula K. Le Guin, Fritz Leiber, Robert Silverberg, Philip Josè Farmer): sono anche lettere d’amore rivolte a un genere spesso ritenuto a torto “minore” e rappresentano uno dei motivi per cui i lettori di fantascienza non dovrebbero lasciarsi scappare questo libro (nel caso non lo avessero già letto). Un altro motivo è chiaramente la bravura di Bolaño, che finirà per irretirli in una trama che centrifuga storia e immaginario in un vortice incandescente da cui emergono le numerose corrispondenze tra i simboli di un’iconografia nemmeno troppo esoterica: Thea von Harbou e i carri armati del Terzo Reich, le bombe atomiche e le albe e i tramonti di Città del Messico, l’irrequietezza giovanile e il bisogno quasi viscerale di rottura con le convenzioni del passato, fino alla riscoperta dell’essenza della poesia nelle forme dell’avanguardia (De Matteo 2018).
Come fanno i protagonisti di Bolaño, possiamo cercare nella fantascienza le risposte alle domande che ci assillano, possiamo interrogare i nostri autori preferiti come oracoli, o possiamo semplicemente accontentarci di imparare a leggerne di nuovi: scopriremo così la meravigliosa complessità di un genere che non ha mai smesso di parlarci, nei tempi bui che stiamo attraversando come nei giorni più splendenti che ci siamo lasciati alle spalle. E se non avremo trovato le risposte che cercavamo, pazienza… magari dai nuovi avremo imparato come formulare domande nuove, alla cui soluzione cominciare a lavorare. È questo, in fondo, che ci insegna lo spirito della fantascienza: un genere in continua trasformazione e proprio in questo suo incessante ricambio di idee, di temi e di stili, fedele e aderente alla sua essenza più profonda.
(fine… per il momento)
- Autori vari, Le visionarie, a cura di Ann e Jeff VanderMeer, Nero Editions, Roma, 2018.
- Charlie Jane Anders, Tutti gli uccelli nel cielo, Mondadori, Milano, 2022.
- Aracne, Childe Roland alla Torre Nera giunse, Found in Translation: la letteratura ritrovata, 2017.
- Antoine Bello, Gli illuminati, Fazi Editore, Roma, 2010.
- Antoine Bello, I falsificatori, Fazi Editore, Roma, 2010.
- Roberto Bolaño, 2666, Adelphi, Milano, 2009.
- Roberto Bolaño, Lo spirito della fantascienza, Adelphi, Milano,. 2018.
- Jennifer Marie Brissett, Elysium, Zona 42, Modena, 2017.
- Ernest Cline, Armada, Mondadori, Milano, 2024.
- Ernest Cline, Ready Player One, Mondadori, Milano, 2021.
- Ernest Cline, Ready Player Two, Mondadori, Milano, 2021.
- Blake Crouch, Dark Matter, Fanucci, Roma, 2024.
- Blake Crouch, I misteri di Wayward Pines, Sperling & Kupfer, Milano, 2014.
- Blake Crouch, Recursion. Falsa memoria, Fanucci, Roma, 2020.
- Blake Crouch, Wayward Pines Vol. 2. Il bosco, Sperling & Kupfer, Milano, 2015.
- Blake Crouch, Wayward Pines Vol. 3. L’ultima città, Sperling & Kupfer, Milano, 2015.
- Blake Crouch, Upgrade, Fanucci, Roma, 2023.
- Giovanni De Matteo, Cloud Atlas, Fantascienza.com, Milano, 2013.
- Giovanni De Matteo, Lo spirito della fantascienza, Fantascienza.com, Milano, 2018
- Giovanni De Matteo, Lanfranco Fabriani, Una breve storia del viaggio nel tempo, Next-Station.org, 2011.
- Lindsey Drager, L’archivio dei finali alternativi, Zona 42, Modena, 2023.
- Dave Eggers, Il Cerchio, Feltrinelli, Milano, 2022.
- Amal El-Mohtar e Max Gladstone, Così si perde la guerra del tempo, Mondadori, Milano, 2020.
- William Gibson, Neuromante, Mondadori, Milano, 2023.
- Georgi Gospodinov, Cronorifugio, Voland, Roma, 2021.
- Georgi Gospodinov, Fisica della malinconia, Voland, Roma, 2013.
- Daryl Gregory, Nove ultimi giorni sul pianeta Terra, Zona 42, Modena, 2020.
- Daryl Gregory, Siamo tutti in ordine, Fanucci, Roma, 2016.
- Hugh Howard, Dust, Fabbri Editori, Milano, 2014.
- Hugh Howard, Shift, Fabbri Editori, Milano, 2014.
- Hugh Howard, Silo, Fabbri Editori, Milano, 2013.
- Stephen King, 22/11/’63, Sperling & Kupfer, Milano, 2012.
- Stephen King, Cuori in Atlantide, Sperling & Kupfer, Milano, 2016.
- Stephen King, The Dome, Sperling & Kupfer, Milano, 2013.
- Stephen King, La Torre Nera. La leggenda del vento, Sperling & Kupfer, Milano, 2017.
- Stephen King, La Torre Nera V. I lupi del Calla, Sperling & Kupfer, Milano, 2017.
- Stephen King, La Torre Nera VI. La canzone di Susannah, Sperling & Kupfer, Milano, 2017.
- Stephen King, La Torre Nera VII. La Torre Nera, Sperling & Kupfer, Milano, 2017.
- Oliver Langmead, Dark Star, Carbonio Editore, Catania, 2017.
- Joe R. Lansdale, Drive-in. La trilogia, Einaudi, Torino, 2012.
- Joe R. Lansdale, Fuoco nella polvere, Fanucci, Roma, 2008.
- Joe R. Lansdale, In un tempo freddo e oscuro e altri racconti, Einaudi, Torino, 2006.
- Joe R. Lansdale, Londra tra le fiamme, 2011.
- Joe R. Lansdale, Maneggiare con cura, Fanucci, Roma, 2002.
- Tom McCarthy, C, Bompiani, Milano, 2013.
- Tom McCarthy, Déjà-vu, ISBN Edizioni, Milano, 2008.
- Tom McCarthy, Satin Island, Bompiani, Milano, 2016.
- David Mitchell, Cloud Atlas. L’atlante delle nuvole, Mondadori, Milano, 2021.
- David Mitchell, Nove gradi di libertà, Mondadori, Milano, 2021.
- David Mitchell, Le ore invisibili, Frassinelli, Torino, 2016.
- David Mitchell, Sogno numero 9, Mondadori, Milano, 2021.
- Alan Moore, Jerusalem, Rizzoli, Milano, 2016.
- Alan Moore, La voce del fuoco, Edizioni BD, Milano, 2021.
- Annalee Newitz, Autonomous, Fanucci, Roma, 2017.
- Annalee Newitz, Il futuro di un altro tempo, Fanucci, Roma, 2021.
- Audrey Niffenegger, La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, Mondadori, Milano, 2019.
- Jeff Noon, Alice nel paese dei numeri, Frassinelli, Milano, 1999.
- Jeff Noon, Le piume di Vurt, Frassinelli, Milano, 1995.
- Jeff Noon, Polline, Frassinelli, Milano, 1996.
- Jeff Noon, L’uomo delle ombre, Edizioni BD, Milano, 2021.
- Leonardo Patrignani, La cattedrale di sabbia, Mondadori, Milano, 2023.
- Leonardo Patrignani, Multiversum. La saga completa, De Agostini Libri, Milano, 2021.
- Sarah Pinsker, Canzone per un nuovo giorno, Fanucci, Roma, 2024.
- Sarah Pinsker, Enne meno uno, Delos Digital, Milano, 2022.
- Pierfrancesco Prosperi, Incubi per Re John, Mondadori, Milano, 2008.
- Philip Pullman, Il Libro della Polvere: La Belle Sauvage, Salani Editore, Firenze, 2017.
- Philip Pullman, Il Libro della Polvere: Il Regno segreto, Salani Editore, Firenze, 2020.
- Philip Pullman, La Oxford di Lyra, Salani Editore, Firenze, 2024.
- Philip Pullman, Queste oscure materie. La trilogia completa: La bussola d’oro-La lama sottile-Il cannocchiale d’ambra, Salani Editore, Firenze, 2008.
- Kristine Kathryn Rusch, L’artista dei recuperi, Delos Digital, Milano, 2015.
- Kristine Kathryn Rusch, Il recupero dell’Apollo 8, Delos Books, Milano, 2010.
- Kristine Kathryn Rusch, La stanza delle anime perdute, Delos Digital, Milano, 2016.
- Kristine Kathryn Rusch, Stealth, Delos Digital, Milano, 2015.
- Kristine Kathryn Rusch, Un tuffo nel relitto, Delos Digital, Milano, 2014.
- Emily St. John Mandel, Mare della Tranquillità, La Nave di Teseo, Milano, 2022.
- Catherynne M. Valente, L’Immortale, Fazi Editore, Roma, 2023.
- Catherynne M. Valente, Mass Effect: Andromeda – Annihilation, Multiplayer Edizioni, Terni, 2019.
- Catherynne M. Valente, Space Opera, 21lettere, Modena, 2020.