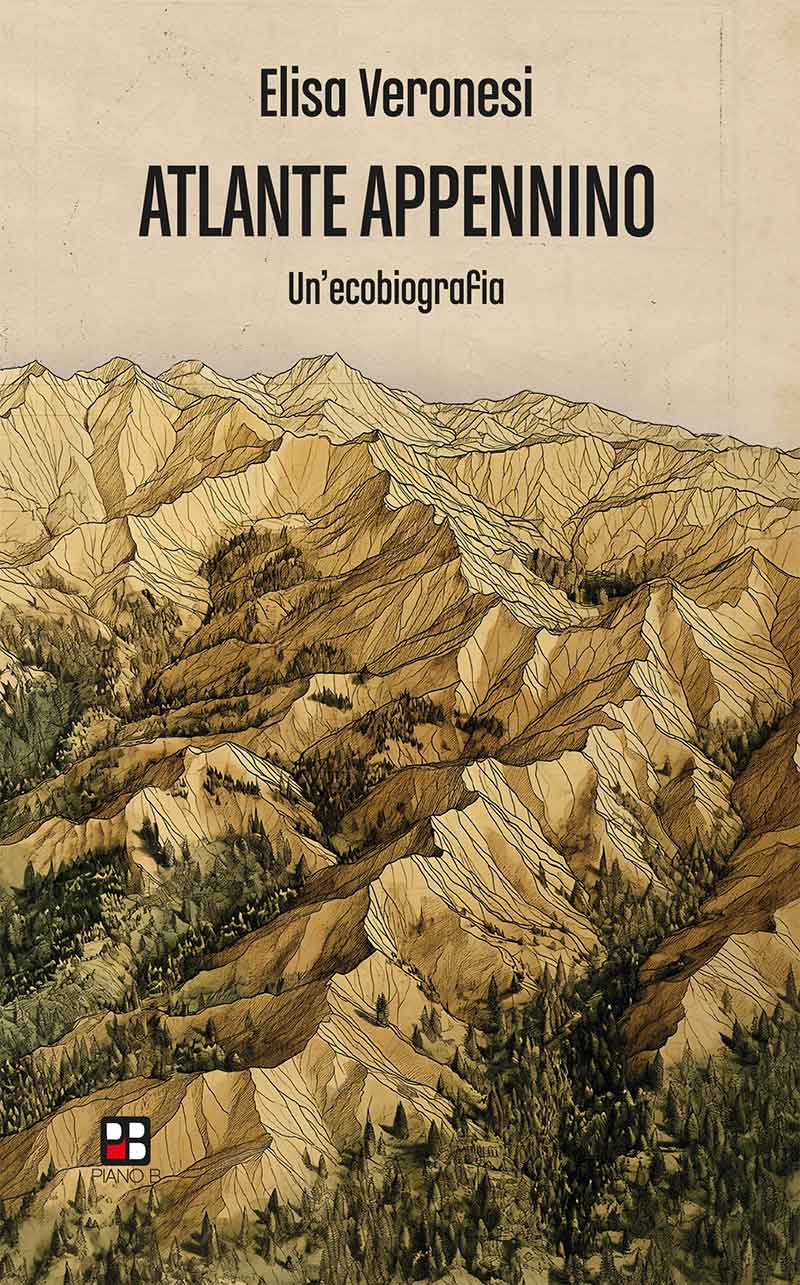Il sottotitolo di questo esordio di Elisa Veronesi definisce questo libro come Un’ecobiografia. Ogni correttore automatico a questo punto sottolinea in rosso la parola, proponendo, con una salomonica soluzione, di scindere il sostantivo in due termini distinti: eco e biografia. Anche Google, se viene inserita una query, risponde: “forse cercavi: eco biografia”. Insomma, un termine che già al primo approccio pare complicato da gestire, soprattutto ostico di fronte al matrimonio tra le due sue componenti. Pare che questo matrimonio non sia da fare, verrebbe da dire. Eppure, Veronesi già dalle prime pagine descrive piuttosto bene che cosa vuol dire questo neologismo:
“In ascolto, tra osservazione e rimemorazione, l’ecobiografia scrive (graphein) e narra l’interazione tra storie di vita (bios) e ambiente (oikos), mostrando i legami inscindibili tra noi stessi e il mondo”.
È impresso quindi nel sostantivo stesso, e nella sua etimologia, il fatto che l’oggetto della ricerca sia una relazione, piuttosto che dei dati. Lo spazio tra i due termini scompare, ed emerge il loro essere soprattutto un legame, un collegamento. Non è propriamente corretto chiamare neologismo la parola ecobiografia. È vero invece che effettivamente in Italia viene introdotta probabilmente per la prima volta con questo volume. Difatti l’autrice vive e lavora in Francia, dove ha avuto modo di conoscere il lavoro del filosofo Jean – Philippe Pierron, che in un suo recente saggio ha avuto modo di sviluppare il concetto di ecobiografia (cfr. Pierron, 2021). Un libro centrale che mira a decostruire la nostra soggettività mostrando invece quanto siamo un noi, usando un plurale che non è semplicemente allargato al resto della razza umana, ma che è rivolto all’intero mondo.
“«Forma rinnovata del “conosci te stesso”», l’ecobiografia, egli scrive, «dispiega un’ecologia in prima persona, dove la persona non viene per prima». L’«io» umano vi gioca certamente un ruolo creativo, ma senza rubare la scena agli altri viventi, come avveniva nei pensieri antropocentrici che hanno avallato lo sfruttamento del mondo naturale. Si tratta infatti di percepirsi vivente in mezzo ai viventi: «Il dato più immediato del pensiero umano è così formulato: “Io sono vita che vuole vivere, circondata da vita che vuole vivere”». L’energia primaria dell’ecobiografia è dunque quella dell’empatia, in una «comunione simbiotica dei viventi».”
(Sonnet, 2021).
Dalla definizione che ne dà Veronesi si comprende inoltre perchè si tratta di un’idea che forza il linguaggio, costringendolo a essere generativo, a unire concetti che nello status quo si vorrebbero separati, ma che in questa convivenza diventano fertili. Difatti, se l’ecobiografia è in primis una torsione linguistica, questo suo valore topologico viene immediatamente colto dall’autrice, che lo applica alla geografia. Difatti anche nella vita dell’autrice si tratta esplicitamente di unire contrasti, di ricongiungere distanze, e questo avviene proprio tramite la geografia, la torsione dello spazio. Come si affronta la distanza, che la geometria misura nello spazio ponendo paletti e limiti? Viaggiando, così da ritrovarsi. Ma chi si sposta, andando da un luogo a un altro, affrontando la distanza che separa l’origine dal presente, è costretto sempre a ripensarsi, e a ritrovarsi continuamente nei luoghi in cui arriva. E così l’autrice, che nasce in Italia, in un paese dell’Appennino, misura sé stessa in quanto migrante nella distanza tra l’origine e il suo presente francese. Qui esiste l’ecobiografia: nel racconto di sé stessi come mutanti, misura dello spazio che si percorre a partire da un sé passato per giungere a un sé presente.
Un tratto appenninico memorabile
Il racconto dell’Appennino, a cui l’autrice dedica gran parte di questo testo, è perciò un continuo avvicinamento, un movimento circolare che cerca un’origine da cui si possa poi ripartire, in un movimento verso il futuro. Perché è solo se si fonda sul passato che il futuro può trovare un modo per continuare ad esistere. La relazione tra gli ambienti del passato e quelli che saranno nel futuro è una connessione infinita, ricorsiva, in cui nessuna delle due parti può esistere senza l’altra.
“Restare nel mezzo delle rovine è come sostare sul limitare del tempo, in un precipizio vertiginoso che oscilla tra un passato anche lontano e u futuro in arrivo. I luoghi abbandonati non finiscono mai di finire. Nascono, ma la fine è lentissima, la fine non finisce. I nuovi abitanti, piante, insetti, ghiri, topi modificano le dimensioni, modificano piano i dintorni, poi gli edifici, i quali, lentamente erodono in qualcosa che diviene resto, scheletro di un passato che si allontana ma che, allo stesso tempo, pare vicinissimo, e pure ci scavalca per farsi futuro. In molte lingue la parola futuro indica qualcosa che sta dietro di noi, perché non possiamo vederlo, mentre il passato sta davanti a noi, proprio perché visto, visibile, traccia tangibile di quello che è stato, cammino alla volta degli avi che siamo diventati”.
Nel ribaltamento delle cose abbiamo parlato prima di ciò che significa il sottotitolo, ma a questo punto è il titolo che deve ritornare al suo posto comandato, alla sua raison d’etre. L’atlante appennino è perciò, ancora una volta, una mappa, una torsione dello spazio che è costretto dal linguaggio ad adattarsi, a ripiegarsi prima per poi spiegarsi. Sono moltissimi i concetti che qui vengono utilizzati, a partire dalle rovine, tracce lasciate dal passato, segni giunti fino a noi, e costitutivi della nostra interpretazione del presente. La storia è semiotica, e quindi scrittura, testo, e difatti sono moltissimi i punti in cui è la letteratura a irrompere in questo viaggio, anche se magari non è sempre esplicitata.
Il viaggio però, sebbene si soffermi con mille racconti sull’appennino di un tempo, il suo passato, sia profondo sia recente, si è detto che è sempre torsione spaziotemporale, ed è quindi una sorta di elastico, quasi un corridoio fantascientifico affine alla piega di deleuziana memoria, che accartocciando l’atlante costringe le colline tosco-emiliane a toccarsi con la costa azzurra, continuando a spostare concetti e sguardi da un luogo all’altro, un rivolgersi al mare con le spalle tra i boschi. Difatti, nello stesso modo in cui si mescolano passato e futuro, l’Appennino e la Costa Azzurra, così il saggio si fonde con la narrazione. A elementi di analisi, in cui vengono esposti dati sul clima, sull’ambiente, sulla geografia e sulla storia di questi luoghi, si intervallano pezzi di narrativa, in cui i personaggi del passato (o forse anche del presente) si presentano ed emergono, testimonianze viventi, causa di ciò che è il presente. La presenza della memoria però non è un semplice database a cui attingere per ricostruire un mosaico più o meno complesso, il racconto si deve immergere nella memoria, abitarla:
“Un racconto che non sia semplice narrazione storica di avvenimenti, né manualistica botanica o aneddotica personale, ma un racconto che sappia invece di terra triturata, di ortiche, dalla forma delle tracce dei cinghiali nel bosco, del gusto freddo della neve che si scioglie tra le mani. […]”.
E qui incontriamo di nuovo le tracce del passato, le rovine di un mondo che non finisce mai, e che forse, suggerisce Veronesi, dovremmo trovare il modo di dimenticare, così da lasciarlo finire, per poter infine scardinare il passato da un immaginario che è solo una nostra proiezione, e finalmente lasciare nuove tracce, creare nuove mitologie, per chi verrà dopo di noi.
- Jean-Philippe Pierron, Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, Actes Sud, Arles, 2021.
- Jean-Pierre Sonnet, La terra dei viventi, La civiltà cattolica, 21 dicembre 2021.