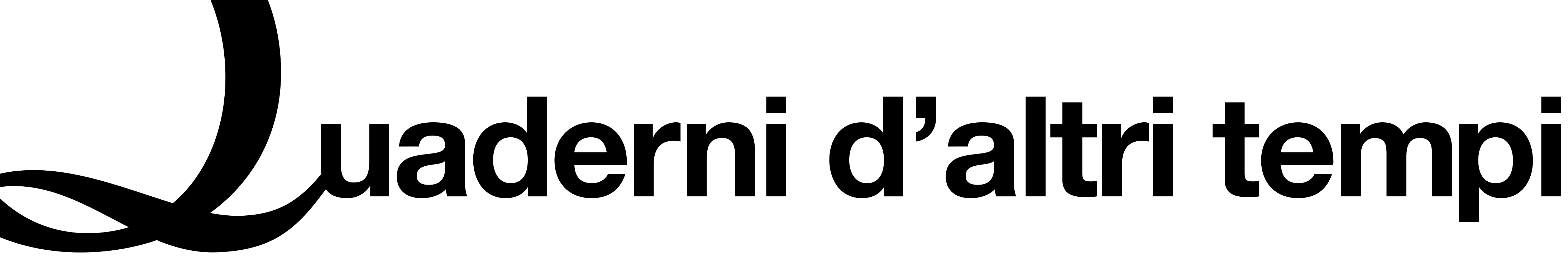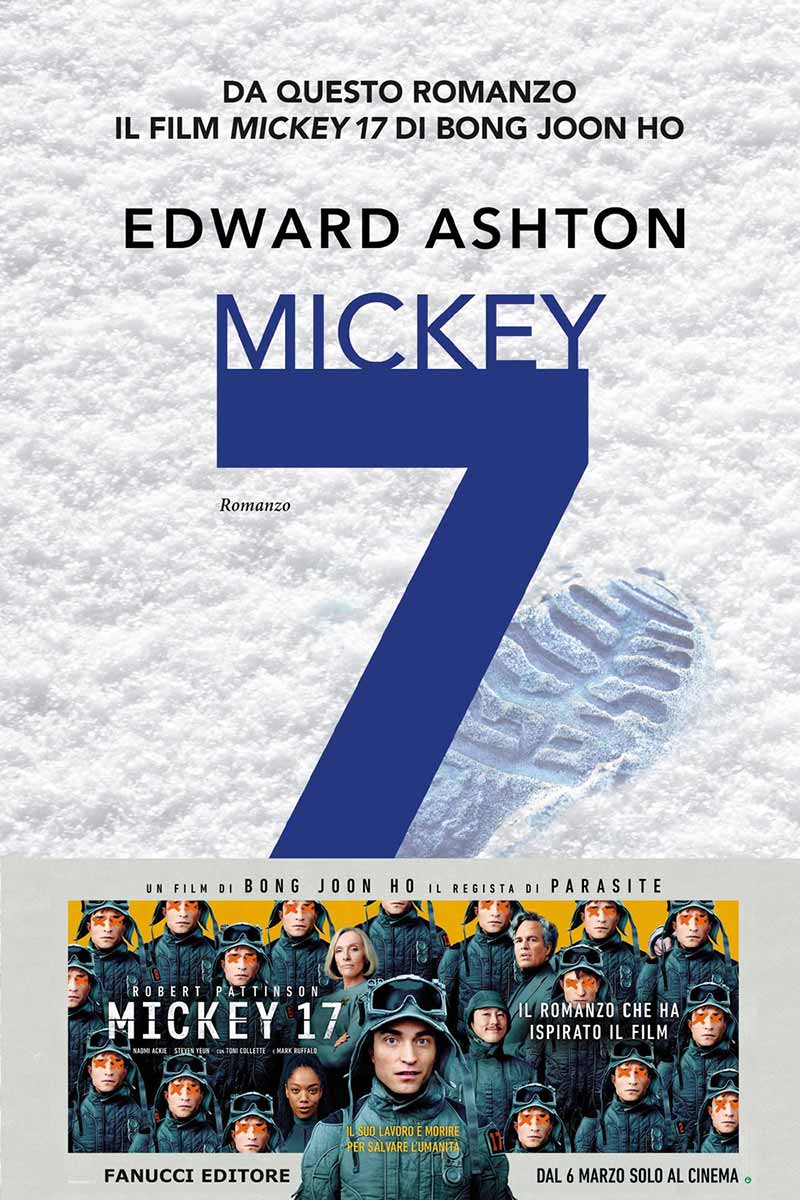Mickey 7, romanzo di Edward Ashton, è stato pubblicato nel 2022 negli USA, e successivamente tradotto in italiano da Stefano Ternavasio per Fanucci. Il libro ha rapidamente catturato l’attenzione sia degli appassionati di fantascienza che della critica mainstream, spingendo il regista premio Oscar Bong Joon-ho a realizzarne una trasposizione cinematografica, intitolata Mickey 17. Ashton – oltre che scrivere romanzi e racconti di speculative fiction – insegna fisica e si occupa anche di oncologia. Entrambi questi aspetti della sua formazione sono ampiamente presenti nel romanzo. La storia è quella del personaggio principale, Mickey Barnes, il cui nome dà anche il titolo al libro, che, per sfuggire a degli usurai particolarmente aggressivi, decide di imbarcarsi su di una nave interstellare in partenza per una missione di colonizzazione su un pianeta chiamato Niflheim. Il problema è che l’unico incarico ancora disponibile è quello di Expendable (nella versione italiana tradotto come sacrificabile). In cosa consiste questo lavoro? In una missione interstellare così come nella colonizzazione di un pianeta sconosciuto si possono presentare innumerevoli situazioni in cui vi sia la certezza di morire, o comunque una elevatissima probabilità che questo accada. In particolare, questo pianeta, che avrebbe dovuto essere abitabile, si rivela completamente ricoperto di ghiaccio e già abitato da una specie autoctona con cui le relazioni sono solamente di reciproca violenza. La procedura e la burocrazia prevedono perciò che venga selezionato almeno un candidato al ruolo di sacrificabile (se non esiste si procederà con il reclutamento forzato) cosicché ogni elemento del suo corpo venga memorizzato. Nel contempo verranno eseguiti degli upload periodici della memoria, cosicché, nel momento in cui dovesse presentarsi la situazione per cui qualcuno dovrà morire affinché la collettività sopravviva, cosa che inevitabilmente succede, il sacrificabile sa che il giorno dopo la sua morte una nuova iterazione del suo corpo verrà prodotta nei laboratori, aggiornando la memoria all’ultimo upload. Il presupposto quindi della vita di un sacrificabile è che ogni volta che muore, la sua mente si ritrova a vivere in un nuovo corpo, un nuovo clone, sostanzialmente identico, ma non lo stesso, e con la maggior parte dei suoi ricordi. Il protagonista è la settima iterazione di Mickey (da qui il titolo Mickey 7).
Immortalità a scadenza
Certamente il tema dell’immortalità è già stato rappresentato e analizzato a lungo nella science fiction, e la lista dei romanzi in cui vi sono personaggi che devono confrontarsi con questa condizione è lunga. È però altrettanto certo che Ashton in Mickey 7 offre una prospettiva unica. A differenza dell’immortalità quasi mistica degli Highlander, dove Connor MacLeod mantiene un’esistenza continua attraverso i secoli con lo stesso corpo e una coscienza ininterrotta, o della profonda angoscia che prova il protagonista del recente fumetto BRZRKR di Keanu Reeves, un guerriero immortale condannato a combattere attraverso le ere, Mickey Barnes sperimenta un’immortalità frammentata e meccanica. Non è un’entità singola che perdura, ma una successione di copie, ognuna destinata a morire solo per essere sostituita. Mentre gli immortali tradizionali soffrono per la solitudine dell’eternità, il dolore per la morte degli altri, Mickey soffre per la certezza delle sue infinite morti traumatiche.
“Finora non sono mai morto assiderato. Tuttavia ci ho pensato parecchio. È stato difficile sfuggire all’idea, fin da quando siamo approdati su questa palla di ghiaccio dimenticata da dio. Dovrebbe essere piuttosto semplice, relativamente parlando. Cominci a sentire freddo, ti addormenti, e poi non ti svegli più, no?”
È un’immortalità che non offre consolazione né potere, ma solo la consapevolezza che una versione di sé continuerà, anche se lui stesso cesserà di esistere, seppur solo per andare essa stessa a morire dolorosamente. Una versione intergalattica della reincarnazione e del samsara, ma non per questo meno drammatica e fondamentalmente sfiduciata circa la condizione umana. Questa peculiare forma di immortalità è inestricabilmente legata al lavoro di Mickey come sacrificabile: il suo ruolo è letteralmente quello di morire: viene mandato nelle situazioni più pericolose, utilizzato per testare cibo potenzialmente tossico, esposto a radiazioni letali, inviato in ricognizioni suicide. Il lavoro di Mickey rappresenta una versione estrema dell’alienazione capitalistica: è completamente definito dalla sua funzione e dalla sua sostituibilità. La colonia non vede Mickey come un individuo ma come una risorsa rinnovabile, un costo operativo accettabile. Inoltre, è visto dagli altri abitanti sostanzialmente come una stranezza da loro difficilmente comprensibile e ammissibile, solo il suo ruolo lo rende tollerabile, per evidenti e ipocriti motivi. Mickey è solo, non comunica, al punto che dopo nove anni di vita condivisa ancora non conosce nemmeno il nome di molte delle persone con cui coabita la colonia. Mickey frequenta solo alcune figure, con cui ha rapporti complicati, resi inoltre estremamente difficili dalla sua condizione. È straziante – per esempio – il passaggio in cui la sua compagna lo vede (lo vuole vedere) morire in diverse e dolorose situazioni.
“Probabilmente aveva saputo fin dal nostro primo bacio che un giorno o l’altro avrebbe dovuto guardarmi morire, ma adesso che dopo otto anni stava finalmente accadendo, credo che non sapesse cosa fare”.
È lei, più ancora che lui, a uscire devastata psicologicamente da questa prova. In questo senso, il romanzo offre una critica feroce del capitalismo contemporaneo e della vita a cui costringe, dove i lavoratori sono sempre più considerati intercambiabili e sacrificabili. L’immortalità di Mickey non è un dono ma una condanna a morte, a un ciclo infinito di sfruttamento lavorativo: una metafora dell’impossibilità di sfuggire alle esigenze del sistema economico.
La storia e l’ironia
La drammatica condizione di Mickey viene comunque da lui accettata: in diversi passaggi il protagonista parla della propria esistenza come del risultato di scelte ponderate, della valutazione di pro e contro.
“Il lato positivo di tutto questo morire è che io in realtà sono una sorta di immortale, però di merda”.
Il suo è un processo materialistico e concreto, quasi deterministico. Difatti Mickey, in un mondo dove la storia viene giudicata esplicitamente come qualcosa di completamente inutile, si dichiara uno storico, e trascorre ogni momento libero a leggere i resoconti delle precedenti missioni di colonizzazione, concentrandosi sui motivi dei fallimenti, sugli errori che sono stati compiuti. Barnes racconta, con ironia, sagacia e humor, le drammatiche e devastanti condizioni in cui la razza umana ha condotto i propri membri nel corso dei secoli, dimostrando equilibrio tra un notevole umorismo nero e le riflessioni filosofiche più profonde che si affrontano. Barnes è un narratore coinvolgente e simpatico nonostante (o forse a causa di) la sua situazione insolita. I resoconti del passato, che intervallano le sue disavventure personali, sono come illuminanti aneddoti, conditi con osservazioni di sociologia e antropologia, oltre che di etica, religione e politica. Di fatto però, la questione più importante che traspare è l’assurdità della colonizzazione spaziale. Attraverso i resoconti storici che Mickey studia ossessivamente, emerge un quadro desolante di colonie fallite, spedizioni disastrose e interi pianeti abbandonati.
“Fu con un certo stupore che appresi che nel corso degli ultimi mille anni i tentativi falliti sono stati quasi lo stesso numero di quelli riusciti”.
L’umanità persiste testardamente in questi tentativi nonostante una serie quasi ininterrotta di catastrofi, spinta da una combinazione di disperazione e arroganza. Il pianeta ghiacciato Niflheim, con il suo ambiente ostile e le sue forme di vita aliene incomprensibili, rappresenta l’ennesima frontiera che l’umanità cerca di piegare alla propria volontà, ignorando le lezioni del passato. La follia di questa impresa riflette una critica all’espansionismo coloniale storico, con i suoi costi umani e la sua fondamentale insostenibilità, esattamente come sulla Terra, così nello spazio. L’elemento di novità portato dal personaggio è che proprio attraverso il suo ruolo di storico amatoriale, Mickey trova una via d’uscita dal suo dilemma personale (e anche alla inevitabile fine della sua colonia). La sua ossessione per i resoconti delle precedenti catastrofi coloniali si rivela quindi essere non solo un hobby macabro ma uno strumento di sopravvivenza. Studiando i fallimenti passati, Mickey acquisisce una conoscenza che lo aiuta a navigare le crisi attuali. Questo elemento del romanzo vuole indicare come la conoscenza storica, spesso sottovalutata nelle società orientate al futuro, è in realtà essenziale per evitare di ripetere errori fatali. Mickey, con la sua prospettiva unica di testimone di multiple morti personali, diventa paradossalmente il più adatto a prevenire la morte della colonia intera.
“Un discreto numero di colonie teste di ponte finisce in malora per un motivo o per l’altro. Non mi piacerebbe affatto se in questo caso avvenisse per colpa mia”.
Sebbene intriso di riflessioni filosofiche ed esistenziali, il romanzo mantiene un tono di humor nero e feroce che lo salva dal diventare eccessivamente cupo o didattico. L’ironia di Mickey è il suo meccanismo di difesa contro l’assurdità della sua situazione, un modo per mantenere la sanità mentale di fronte a morti ripetute e a un sistema che lo considera fondamentalmente sacrificabile. Il suo sarcasmo di fronte alle situazioni più terribili riflette una sensibilità profondamente umana. Questo humor diventa anche un potente strumento narrativo, permettendo ad Ashton di affrontare temi come la morte, lo sfruttamento e il fallimento coloniale senza scivolare nel melodramma o nella predica morale. Mickey 7 si rivela così non solo un’avvincente storia di sopravvivenza su un pianeta alieno, ma una meditazione stratificata sulla natura dell’identità personale nell’era della riproducibilità tecnologica, sull’umanità di fronte all’inumano, e sulla possibilità di resistenza in un sistema che riduce le persone a funzioni sostituibili. Attraverso le molteplici morti e rinascite del suo protagonista, il romanzo ci invita a considerare cosa significhi veramente essere vivi e insostituibili in un universo indifferente.
Sconfinando oltre il doppelgänger
La condizione in cui vive (e muore) Mickey Barnes sarebbe di per sé ampiamente sufficiente a delineare un romanzo, ma Ashton innesta in questo orizzonte un ulteriore elemento di deflagrazione. Mickey 7 viene dato per morto al termine di una spedizione esplorativa, e, come previsto dal protocollo, viene prodotto Mickey 8. La coesistenza dei due – un evento che non dovrebbe mai verificarsi, secondo i regolamenti, e che viene visto come un abominio etico dalla morale piuttosto puritana della colonia – complica ulteriormente questa dinamica. Si crea perciò una situazione che va oltre il classico tema del doppio letterario. Non si tratta di due facce della stessa persona o di manifestazioni legate a impulsi contraddittori, ma letteralmente di un duplicato, con memoria condivisa fino al punto di divergenza. La loro interazione non è antagonistica ma collaborativa, costringendoli a confrontarsi con domande fondamentali sull’identità: se sono identici nei ricordi e nella fisiologia, sono davvero persone separate? Se uno muore e l’altro vive, c’è stata realmente una morte? Se due versioni della stessa persona esistono simultaneamente, quale è l’originale? L’identità è definita dalla continuità della memoria o dall’unicità dell’esperienza? Può una persona essere veramente sostituita da una copia? Questo sviluppo narrativo trasforma il tradizionale motivo del doppelgänger in un’esplorazione più profonda dell’identità personale nell’era della tecnologia avanzata. La loro convivenza, la/le relazioni con le due compagne con cui si confrontano, l’intera narrazione diventa così una potente metafora per esplorare il concetto di sé in un contesto fantascientifico, mettendo in discussione i confini dell’individualità in un futuro dove la coscienza può essere replicata. Durante il romanzo viene in più occasioni citato il paradosso della nave di Teseo, per cui se nel corso del tempo vengono sostituiti a poco a poco tutti i pezzi della nave, ciò che avremo alla fine è la stessa nave, seppur completamente modificata nella sua materia, oppure un’altra nave, per quanto indistinguibile nella forma.
“Tu sei la Nave di Teseo. Tutti noi lo siamo. Non c’è una singola cellula vivente nel mio corpo che fosse viva e parte di me dieci anni fa, e lo stesso vale per te. Noi veniamo ricostruiti di continuo, una tavola alla volta. Se davvero svolgerai questo incarico, è probabile che a un certo punto verrai ricostruito per intero nello stesso momento, ma a ben vedere, in realtà non fa alcuna differenza, o sbaglio?”
Analogo discorso vale per il corpo di ognuno di noi, le cui cellule si sostituiscono continuamente, rendendoci dopo pochi anni il clone di noi stessi. Per Mickey Barnes il processo è analogo, solo che la sostituzione non avviene una cellula alla volta, ma per il corpo nella sua totalità. Difatti Mickey si chiede spesso se è veramente la stessa persona o semplicemente una copia che crede di essere l’originale. Inoltre, la coesistenza di Mickey 7 e Mickey 8 complica ulteriormente il concetto: se entrambi sono “Mickey”, allora l’identità di Mickey è già frammentata, rendendo il concetto di immortalità personale ancora più problematico. Se la condizione esistenziale qui descritta non fosse già una fonte sufficiente di problematiche, serve ricordare che la situazione di Mickey 7 e Mickey 8 li pone inevitabilmente in opposizione all’autorità coloniale. La loro stessa esistenza simultanea viola le regole, costringendoli a nascondersi e ingannare il sistema.
“Mi restano quattrocentocinquanta chilocalorie per tutta la giornata.
Correzione. Ci restano quattrocentocinquanta chilocalorie per tutta la giornata. Se starò agli accordi presi con Otto, lui ha diritto a trecento di queste”.
Questa resistenza inizialmente pragmatica evolve gradualmente in una più profonda contrapposizione ideologica, che rispecchia anche una certa evoluzione divergente: con il progredire della storia, i due Mickey iniziano a sviluppare differenze sottili nelle personalità e prospettive autonome, illustrando come anche partendo da una base identica, le esperienze diverse portino a identità che gradualmente divergono. Mickey 7 in particolare inizia a mettere in discussione la gerarchia della colonia e il valore assegnato alle diverse vite umane. Il suo status di outsider – né completamente umano secondo alcuni, né completamente sostituibile come vorrebbe il sistema – gli permette di vedere le contraddizioni dell’impresa coloniale. In questo senso il sacrificabile diventa una figura rivoluzionaria proprio perché la sua esistenza sfida le categorizzazioni rigide su cui si basa l’autorità.
Dark Forest e humor nero
Ashton ha quindi fin qui descritto uno degli universi più pessimisti, senza speranza e drammatici della storia della letteratura fantastica. Ricorda, per alcuni versi, altri due romanzi che propongono soluzioni e scelte differenti a problemi analoghi, ovvero la trilogia di Takeshi Kovacs, scritta da Richard K. Morgan e l’analisi della cosiddetta Teoria della Foresta Oscura, contenuta nella trilogia Il Problema dei tre corpi di Liu Cixin. Entrambe queste narrazioni presentano sia elementi di affinità sia di discordanza con la prospettiva di Ashton. L’universo di Mickey 7 presenta effettivamente una visione profondamente pessimistica della colonizzazione spaziale. Non è l’utopia tecnologica di molte opere di fantascienza, ma un panorama di fallimenti ripetuti, morte e sofferenza. Le colonie umane sono fragili avamposti in ambienti ostili, e quasi tutte finiscono in tragedia. Il fatto che la colonia di Niflheim continui a mandare avanti la sua missione nonostante le probabilità schiaccianti contro il suo successo evidenzia una sorta di disperazione collettiva. La Teoria della Foresta Oscura, difatti, evidenzia che, in una condizione di risorse limitate, come è l’universo, acquisito che tutte le forme di vita hanno come primo scopo la propria sopravvivenza, e che non vi è mai modo di sapere per tempo e con certezza quali sono le condizioni dell’altro, anche a causa delle distanze immense che ci separano, l’unica azione razionale che qualsiasi senziente possa compiere è eliminare qualsiasi altro senziente prima che possa diventare una minaccia. In questo universo l’unica azione che possa compiere una comunità o un individuo debole (e quindi impossibilitato ad attaccare per primo) è perciò nascondersi, cercare di impedire che un qualche tipo di segnale possa farla individuare, perché in quel caso, ogni istante potrebbe essere l’ultimo, prima che un alieno a noi sconosciuto ma dotato di logica, applichi a noi un analogo ragionamento.

In Mickey 7 vi sono effettivamente molti elementi simili: la missione coloniale stessa è un atto di disperata sopravvivenza, poiché la Terra appare sovraffollata o esaurita; il rapporto con le forme di vita aliene (gli Striscianti su Niflheim) è caratterizzato da incomprensione e conflitto; le risorse sono estremamente scarse, tanto da giustificare l’uso dei sacrificabili come Mickey; c’è una fondamentale solitudine nell’impresa umana, simile all’isolamento cosmico della Teoria della Foresta Oscura. Tuttavia, c’è una differenza significativa: mentre la Teoria della Foresta Oscura immagina un universo pieno di civiltà che si nascondono per paura reciproca, l’universo di Mickey 7 sembra quasi vuoto, o almeno con forme di vita così aliene da rendere impossibile una vera comunicazione. Il pessimismo di Ashton non deriva tanto dalla paura di altre civiltà, quanto dall’indifferenza dell’universo stesso e dall’ostilità degli ambienti planetari. Potremmo dire che Mickey 7 rappresenta una visione ancora più desolante: non una foresta oscura dove predatori e preda si nascondono l’un l’altro, ma un deserto cosmico dove la vita umana lotta disperatamente per attecchire, fallendo quasi sempre. La terribile ironia è che, in questo universo così ostile, l’unica immortalità concessa a Mickey non è una benedizione ma un ciclo infinito di morti traumatiche, un riflesso della condizione dell’umanità stessa nell’universo di Ashton: condannata a ripetere i suoi tentativi fallimentari di espansione, incapace di imparare dalle catastrofi del passato.
Un’immortalità analoga
La trilogia che Richard K. Morgan dedica al personaggio di Takeshi Kovacs è invece rilevante perché anche in quel mondo esistono i replicatori di coscienza, analoghi alla tecnologia che permette a Mickey di risorgere: difatti entrambe le opere esplorano il concetto di immortalità tecnologica attraverso il trasferimento della coscienza, ma la struttura sociale che ne è stata generata è completamente diversa. Nella trilogia, la possibilità di utilizzare corpi nuovi in cui si può essere impiantati, che sono chiamati custodie, è una tecnologia estremamente costosa, ed è di fatto utilizzabile solo da una ristretta élite. I corpi sono completamente mercificati, ridotti a puri contenitori, grazie all’utilizzo delle pile corticali, in cui è possibile condensare l’intera personalità. L’umanità di Altered Carbon, seppur distopica e disumanizzante, offre potenzialmente libertà e possibilità illimitate per chi può permettersela. Questo non elimina la totale alienazione che i soggetti sottoposti a continue transizioni di questo tipo subiscono. Kovacs, che è un soldato, lotta per mantenere un senso di continuità identitaria nonostante i cambi di corpo, ma per lui come per Mickey Barnes, l’immortalità diventa principalmente una condanna, e mai un premio. Entrambe le opere utilizzano l’humor nero come meccanismo di difesa dei protagonisti contro l’orrore esistenziale della loro condizione, ma mentre Kovacs trova una forma di ribellione nel cinismo e nella violenza, Mickey trova la sua nella resistenza passiva e nell’astuzia storica. Forse la differenza più profonda risiede nella visione dell’universo: Altered Carbon presenta un futuro tecnologicamente avanzato ma moralmente corrotto; Mickey 7 mostra un futuro tecnologicamente limitato e disperato. Nel primo, l’immortalità amplifica i difetti umani; nel secondo, evidenzia la fragilità umana di fronte all’indifferenza cosmica. Entrambi questi romanzi, così come accade ogni qual volta nella letteratura fantastica compare il tema dell’immortalità, sia nel caso di un singolo individuo sia se è il soggetto a replicarsi un numero potenzialmente infinito di occorrenze, ci lasciano con la domanda inquietante: se potessimo vivere per sempre attraverso copie di noi stessi, saremmo ancora noi? E questa forma di sopravvivenza varrebbe il prezzo da pagare?
- Richard K. Morgan, La trilogia di Altered Carbon, Tea, Milano, 2016.
- Liu Cixin: Il problema dei tre corpi, Mondadori, Milano, 2017.
- Bong Joon Ho, Mickey 17, Warner Bros., 2025.
- Keanu Reeves: BRSKR 1-12, Panini comics, Modena, 2022-2024.
- Russell Mulcahy, Highlander – L’ultimo immortale, Universal Pictures, 2015 (home video).