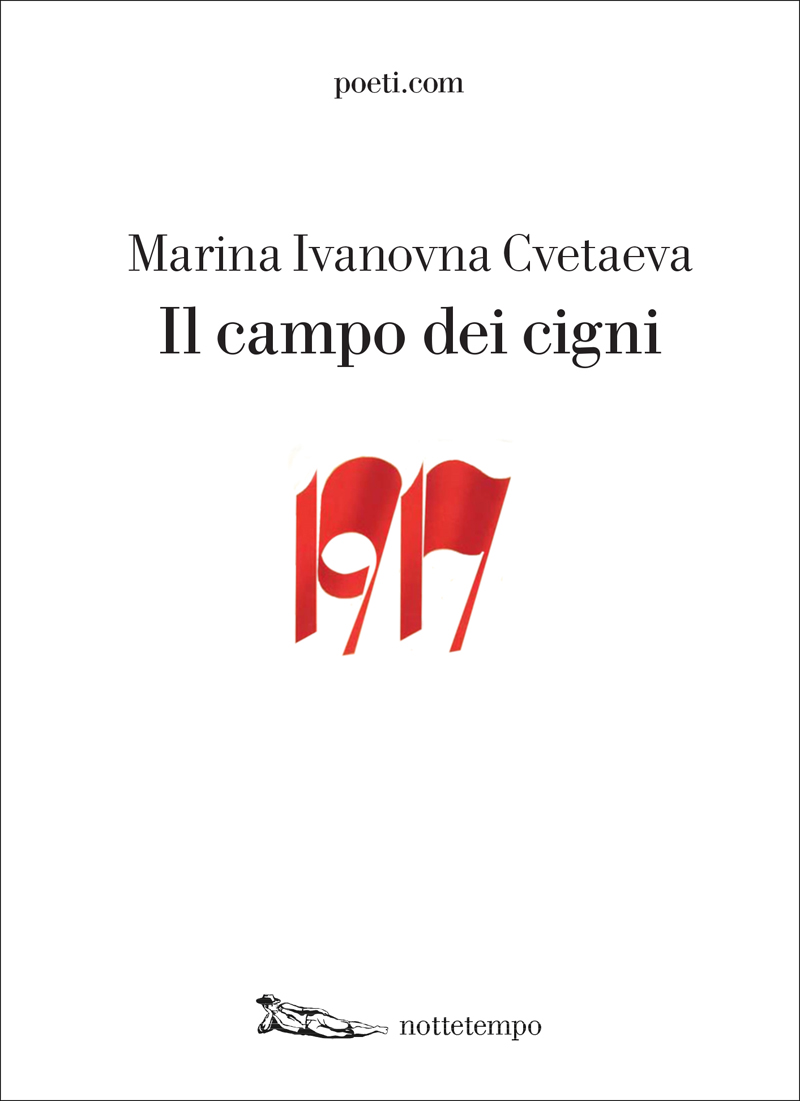“Sparsi fra la polvere dei magazzini, / dove nessuno mai li prese né li prenderà, / per i miei versi, come per i pregiati vini, / verrà pure il loro turno” (Cvetaeva, 1979). Marina Cvetaeva l’aveva immaginata più o meno così la prospettiva dei suoi scritti, riservati alla risonanza di un calendario senza data. Non a caso, clandestina e isolata in vita, dopo la metà degli anni Sessanta Cvetaeva è stata realmente inseguita da noi tutti nel suo paese dell’Anima, per poterne recuperare le note tempestose. E, finalmente, grazie alle edizioni Nottetempo, siamo riusciti a dare definizione alla condizione della poetessa moscovita anche nei mesi febbrili della rivoluzione russa e della subitanea guerra civile: Il campo dei cigni raccoglie difatti i versi composti tra il 1917 e il 1920, con la preziosa presenza di materiale fino a oggi inedito nella nostra lingua. Storia editoriale piuttosto inquieta se si pensa che nella Russia sovietica furono resi noti solo cinque di tali componimenti. Il ciclo completo troverà conferma di stampa a Monaco nel 1957, a cura di Gleb Struve, grazie alla consegna della stessa Cvetaeva all’Università di Basilea nel 1939. La motivazione di questa reticenza editoriale insiste sulla natura apertamente politica delle poesie, radicale rivolgimento all’azione delle Guardie Rosse, prima, dell’Armata Rossa, poi. Perché in quel torno febbrile di mesi tra febbraio e ottobre del 1917 i rivoltosi russi riescono, sì, nel disegno trionfale di mettere all’angolo l’autocrazia zarista di Nicola II e trasformare la rivoluzione da democratica in proletaria e comunista, ma poi hanno da spingersi oltre. Hanno da fronteggiare l’insidia di un avversario prossimo, palesatosi all’indomani della rivoluzione d’ottobre, quando alle insegne rosse dei bolscevichi si giustappongono le divise bianche della coalizione antirivoluzionaria, per lo più nobili, borghesi, contadini agiati. Un’eterogenea barriera all’ipotesi proletaria di Lenin e dei Soviet, un’unica matrice tradizionalista, sotto il colore degli zar. La guerra civile sopravvive fino al 1922-1923. Il bottino bolscevico si traduce nell’orgogliosa fondazione dell’Unione Sovietica.
Gli affanni e le miserie dopo l’Ottobre
“Scriverò un giorno una Storia della vita quotidiana nella Mosca del 1919. – Non conosco altra Rivoluzione!” (Cvetaeva, 2014). É promessa che ci restituiscono la prosa e i versi di quegli anni. Suo marito, l’allievo ufficiale Sergej Efron, si unisce in Crimea all’esercito antibolscevico. È il 1917. Fino al 1922, la poetessa non riceverà notizie di lui se non un paio di volte per vie traverse. La guerra civile interrompe i collegamenti con il Sud della Russia, laddove lei, in compagnia delle due figlie, Ariadna (Alja) di quattro anni e Irina di pochi mesi, pure mirava a raggiungere Sergej.  Si vede così costretta a rimanere a Mosca, al civico 6 di Borisoglebskij pereulok. In questo vicolo, Marina Ivanovna, a soli 25 anni, dovrà imparare l’arte tagliente della sopravvivenza. Lei, figlia di una pianista di grande cultura e di un professore di Arte all’Università di Mosca, fondatore del Museo di Belle Arti, vissuta tra gli agi di un’educazione variegata e viaggi ispirati, si vede all’improvviso alla periferia della sua stessa vita. La rivoluzione e la guerra civile hanno condotto Mosca al tesseramento per il pane e i viveri essenziali, all’elemosina dei generosi. La luce e l’acqua scarseggiano, le condutture gelano, l’orologio è fermo. Alla mensa del Praga si snoda il serpentone stordito dei richiedenti razioni alimentari, mentre nei magazzini di vendita commissionata c’è chi prova a barattare qualsiasi cosa prometta un rublo in più. Marina rivede casa sua come un taglio di facciata sempre identico, ma assaltato da inquilini anarchici, comunisti, clandestini, con diritto di soggiorno in questi tempi nuovi. Lei e le sue figlie subiscono lo sbandamento di una mutilazione: la sola cucina e mansarda sono la sostanza di quei giorni privati, in cui bisogna scardinare travi per fare legna e fuoco. Quel fuoco stentato che, per compensazione, brucia vivo tra le pulsazioni dei versi dedicati agli amati Bianchi. Il campo dei cigni denuncia la verità di una donna con stivali da uomo, un abito marrone di fustagno, le maniche trattenute dalle spille per non inumidirsi nel raschiare patate dal fondo del samovar. Il freddo isterico scava tra polvere e stracci, quasi fosse in scena sempre un unico inesauribile inverno. L’attesa si fa delirio nel ribalzo ripetuto di una domanda: “Non è che stanno bussando? Mi sembra che stiano bussando” (Cvetaeva, 2014). Sergej, aspettano Sergej, partito con il nome di Marina inciso sulla daga.
Si vede così costretta a rimanere a Mosca, al civico 6 di Borisoglebskij pereulok. In questo vicolo, Marina Ivanovna, a soli 25 anni, dovrà imparare l’arte tagliente della sopravvivenza. Lei, figlia di una pianista di grande cultura e di un professore di Arte all’Università di Mosca, fondatore del Museo di Belle Arti, vissuta tra gli agi di un’educazione variegata e viaggi ispirati, si vede all’improvviso alla periferia della sua stessa vita. La rivoluzione e la guerra civile hanno condotto Mosca al tesseramento per il pane e i viveri essenziali, all’elemosina dei generosi. La luce e l’acqua scarseggiano, le condutture gelano, l’orologio è fermo. Alla mensa del Praga si snoda il serpentone stordito dei richiedenti razioni alimentari, mentre nei magazzini di vendita commissionata c’è chi prova a barattare qualsiasi cosa prometta un rublo in più. Marina rivede casa sua come un taglio di facciata sempre identico, ma assaltato da inquilini anarchici, comunisti, clandestini, con diritto di soggiorno in questi tempi nuovi. Lei e le sue figlie subiscono lo sbandamento di una mutilazione: la sola cucina e mansarda sono la sostanza di quei giorni privati, in cui bisogna scardinare travi per fare legna e fuoco. Quel fuoco stentato che, per compensazione, brucia vivo tra le pulsazioni dei versi dedicati agli amati Bianchi. Il campo dei cigni denuncia la verità di una donna con stivali da uomo, un abito marrone di fustagno, le maniche trattenute dalle spille per non inumidirsi nel raschiare patate dal fondo del samovar. Il freddo isterico scava tra polvere e stracci, quasi fosse in scena sempre un unico inesauribile inverno. L’attesa si fa delirio nel ribalzo ripetuto di una domanda: “Non è che stanno bussando? Mi sembra che stiano bussando” (Cvetaeva, 2014). Sergej, aspettano Sergej, partito con il nome di Marina inciso sulla daga.
Una donna tra amore e Storia
“Lascio andare al vento i capelli, / in uno scrigno serbo le spalline”. Si apre così Il campo dei cigni, in uno stile che è quello di sempre, fatto di poche parole che guadagnano la pagina bianca, stile anarchico rispetto alle ricerche poetiche dei suoi contemporanei, tanto simboliste quanto acmeiste. Non cambia la forma consueta, ma la voce, sì. Il timbro è fermo e spiegato. Non una flessione. Marina affida il suo saluto alla concretezza di un dettaglio. Di Sergej custodirà le spalline che lo hanno reso uomo. L’uomo che lei ha difeso mentre amava altri, altre, altro, che ha amato in maniera così piena proprio perché trasfigurato nella distanza. Ma, in questi componimenti, d’amore non parlerà, almeno non alla maniera dei taccuini e delle lettere. Qui sarà la moglie di un soldato con la responsabilità di tenerne alto l’onore. Sarà la donna che, nell’annullamento di mani putride e labbra screpolate, insegue l’andirivieni del sole dal lucernaio, nella fermezza di svegliare Mosca da un sonno eterno. Perché lo zar è deposto, ma nel giorno di Pasqua del 1917 Marina trasfigura e doppia la resurrezione di Cristo nell’ardore di un altare che anche nell’oggi possa sfidare le tenebre dei profanatori.
Stesso ritmo precipitoso, fiero, a tratti evangelico, nell’evocazione del vento napoleonico che irrompe sulla Russia di zar Alessandro I. Napoleone squillava la tromba della pace. Però, in quel turbine, prende corpo la musica cupa di un giovane dittatore, d’un tratto ultimo sulla mappa di una terra a lui promessa. Così, la storia presente sembra avanzata senza progresso, masso vacillante su un passato privo di cemento. A chi risale il miasma? Pietro I, fu lui progenitore dei Soviet, fautore di ogni europeizzazione, già in secoli senza sospetto. Imperioso è allora lo sdegno verso quelle assemblee proletarie che sanno di vendetta. “Stalle – nei sacrari! Sacrari – nelle stalle”, chiasmo potentissimo nella sua ellissi verbale, a dirci di una dissacrazione radicale della vita aristocratica, consumata nei convivi di piazza sulla polvere del trono, su quel “Verbo oltraggiato”, da cui pure si attende giustizia. Giustizia, nonostante il Cremlino vietato nel giorno della Passione di Cristo, un velo rosso sugli occhi di San Nicola, la parola volgare dei vecchi beoni. Resta l’Onore, riaffermato con la maiuscola, che l’Armata bianca, un fiabesco stormo di cigni, avrà il Dovere di difendere sul fiume Don. Restano i colori sulla tavolozza dei versi, la Guardia Bianca illividisce nel “Chiodo nero / al costato dell’Anticristo”, la morte imbianca un’insegna rossa. Resta un soldato caduto, “è nostro, è vostro”, per cui una virgola separa l’illusione dal dolore. E, nel rituale del grido “-Mamma!”, tutta la smisurata solitudine della Russia.

Madre Russia e una piccola madre
Eppure, Marina Cvetaeva impone il suo sguardo acuminato all’avverso fronte, sente come peccato la sopravvivenza quando altri bardi subirono la lacerazione della ghigliottina negli anni francesi del Terrore. Si snerva tra un “è vivo o non è vivo?”, ma, senza cedimenti, identifica due soli nemici, “la fame degli affamati – e la sazietà dei sazi!”. La sazietà dei bolscevichi, la fame di chi, come lei, spera che le desolanti cure dell’orfanotrofio di Kuncevo sappiano garantire un inverno più mite alle proprie bambine. Irina non ce la farà. A soli due anni. Le lettere e i taccuini ci hanno insegnato a leggere nel disagio psichico della piccola tutto lo smarrito rifiuto di sua madre. Lì, non è mai “la mia Irina” (Cvetaeva, 2014), se non dopo la morte. In Il campo dei cigni Cvetaeva, la moglie di un ufficiale di guerra, sembra conoscere solo l’onore dell’appartenenza, e Irina è da subito “la mia bimba”, a cui augura il vanto dell’immensa Russia, dei suoi vessilli, dei suoi inni. Le noti dolenti di una madre che chiede nei carteggi di essere difesa dal mondo e perfino da se stessa, si convertono nel “resisto come un soldato” di questi versi, nel passo ferreo, nel cuore saldo. Una Cvetaeva dalla maggiore ostinazione, ma pur sempre capace di amore assoluto. Osteggia il trionfalismo della rivalsa, ma sa ammettere che tra gli stessi bolscevichi vi “sono esseri umani” (Cvetaeva, 1988). Non a caso, al diciottenne comunista Boris assegnerà la redenzione della parità, “Crescete verso il cielo. È uno solo: per i rossi e per i bianchi” (Cvetaeva, 2014).
- Marina Cvetaeva, Poesie, traduzione e cura di Pietro A. Zveteremich, Feltrinelli, Milano, 1979.
- Marina Cvetaeva, Il paese dell’Anima. Lettere 1909-1925, Adelphi, Milano, 1988.
- Marina Cvetaeva, Taccuini 1919-1921, Voland Edizioni, Roma, 2014.